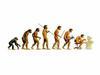Di Michele Rainone
Di Michele Rainone Letteratura e mondo. Prospettive in collisione durante la lettura.
Viaggiare tra le pagine di un libro è cosa di tutti i giorni, ormai; leggere un libro, non più. Eppure, l’uno non collide con l’altro: una mente libera da preconcetti è aperta a qualsiasi esperienza, o quasi; l’ignoranza, invece, incastra il cervello nel mondo delle favole, degli amori impossibili, dei sogni infranti, della bellissima isola che non c’è, il più delle volte incurante dei mezzi per andare oltre. La lettura diventa inevitabilmente consumo spasmodico di pagine, momento di evasione, un viaggio, appunto: bello o brutto che sia, resta pur sempre un viaggio, una illusione, una caduta su soffici cuscini rosa o rossi, poco importa.
Leggere non è consumare, sfogliare cento e cento pagine per poi accorgersi che il viaggio è finito tutto d’un tratto; leggere è cadere, rialzarsi, imparare a camminare, cadere, rialzarsi, non cadere più. Il lettore sa già quando il viaggio finisce, il buon lettore sa che quel viaggio potrebbe terminare prima dell’ultima pagina, in un rigo qualsiasi; in quel preciso rigo, per qualcun altro il viaggio potrebbe iniziare da un momento all’altro.
Ci sono viaggi e viaggi: ognuno ha i suoi. Qualcuno sa che viaggiare nel presente non è ciò che serve (questo va vissuto) ma ripercorrere il passato, sognare il futuro. Lo scrittore può permettere tutto questo. Eppure, i libri da divorare ci sono, e non sono pochi: offrono a basso prezzo delle interminabili spedizioni nei giorni nostri: descrivono, ma non raccontano; se raccontano, non conducono. Una tale accozzaglia di frasi non va letta, o meglio, non dovrebbe essere l’unica.
Esistono storie che il mondo dimentica, che la letteratura ricorda: anche uno sguardo d’insieme a tutto l’Ottocento e il Novecento italiano renderebbe meglio l’idea. Nascono lettori che non hanno la benché minima idea di cosa siano “Le mie prigioni” (Silvio Pellico), “Se questo è un uomo” (Primo Levi), “L’amico ritrovato” (Fred Uhlman), “Amici assoluti” (John Le Carrè), “Il profeta” (Kahlil Gibran), “Nessun luogo è lontano” (Richard Bach), e tanti altri ancora.
Il passato insegna a costruire un futuro diverso dal presente, a mantenere il presente così com’è, se serve; il passato viaggia, dovrebbe viaggiare, assieme a noi nelle tante righe che rimangono della nostra storia: la lettura esige questo approccio; dimenticarlo è dimenticare il nostro passato; è guardare al presente, e non al futuro, col nemico alle spalle.
Badate bene, non è solo “Le mie prigioni” a fare la sua dignitosa comparsa nella lista: qualcuno, sbagliando, potrebbe considerarle noiose e datate. C’è anche Il profeta, Nessun luogo è lontano fa da gustosa ciliegina sulla torta; potrebbe aggiungersi persino la sconvolgente Storia di Cristo di Papini, ma a qualcuno importerebbe? No, il motivo è presto detto: dimenticato persino dalla scuola, pochi sanno che a chiedere la redenzione fu un ateo dai comportamenti bizzarri, dalle discussioni facili, dal carattere tremendamente difficile.
Per quanto possa essere importante il periodo storico, non sarà lui il nostro compagno di viaggio: tutt’al più potrebbe fare da testimone. Tutti, chi più chi meno, hanno una vaga conoscenza dei periodi storici più importanti; pochi riescono a coglierne il messaggio, talvolta nascosto talaltra un po’ meno. Siete liberi di recepirlo quando e come volete: al primo rigo o all’ultimo, poco importa: conta farselo amico e arrivare, magari a braccetto, fino alla fine della storia.
Letteratura e mondo, oggi, collidono: i messaggi sfuggono, il passato sbiadisce, il futuro si allontana, e con essi la letteratura. Se la colpa è del sistema, questo fantasma cui si suole ricorrere con estrema facilità, bisognerebbe ricordarsi che noi, prima di tutto, siamo il sistema.