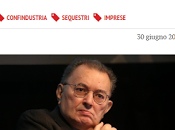Ugo Splendore, nato nel 1966, é vicedirettore del bisettimanale ¨Luna Nuova¨ e collabora con il Manifesto dal 2008, dove ha pubblicato articoli di calcio, rugby e boxe dalla Patagonia e dall’Argentina, che ha eletto a sua seconda casa. I suoi racconti sono pubblicati dalla Editorial Intangible di Aharon Quinconces (http://www.editorialintangible.com/).
Due pugili che in pubblico scatenavano tempeste di pugni e che in privato quasi non sapevano che farsene della quiete. Due pugili che hanno fatto sognare l’Argentina: Carlos Monzón se n’è andato 15 anni fa. Víctor Galíndez 30 anni fa. Ma mentre Monzón è saldo nel mito, Galíndez vaga nel limbo di un’epoca che sorvola le faccende di chi non ha avuto addosso abbastanza luce nonostante si sia seduto sul trono mondiale. L’ombra di Monzón gli ha tolto questa luce e forse è per questo che Galíndez ha cercato di essere un personaggio a tutti i costi, un laser che attraversasse l’oblio dei giganti. Diversi eppure uguali in una sorte dannata, la morte trovata sull’asfalto con la colonna sonora di un rombo d’auto, Monzón e Galíndez sono i capolavori di un pugilato che come un tango predestinato usciva dai barrios per farsi vivo e lasciare il segno fino a un capolinea che non poteva essere il ring.
Morto l’8 gennaio 1995, Carlos Monzón è il toro che nessuno è riuscito a maneggiare con cura, se non il suo allenatore Amílcar Brusa. Se n’è andato a 52 anni. Sembra ieri, scrivono i giornali a Sante Fe, 500 chilometri sopra Buenos Aires, dove El Negro è l’icona del successo frantumato dalla tragedia. Un’imbattibilità di quasi 13 anni, poi la fine. Monzón andava di fretta. È partito alla velocità dei pugni che dava. Un’uscita di strada a 140 all’ora mentre rientrava nella prigione di Las Flores, dove scontava 11 anni per l’uccisione, durante un litigio, dell’ultima compagna, una modella uruguaiana. Perché a Monzón appartenevano la bellezza e la forza, il fascino e infine la sventura.
Se il personaggio Monzón, incubo di Nino Benvenuti e re degli anni 70 con Alì e Durán, è stato passato ai raggi X dalla storia e delle cronache, il ritratto di Galíndez s’impolvera sempre più. La sorte gli ha riservato una fine assurda a 31 anni, come se fuori dal ring non ci fosse spazio per questo guerriero che sembrava uscito dalla foresta amazzonica. Era il 25 ottobre 1980, Galíndez si era ritirato da pochi mesi per una lesione alla retina in allenamento. Era reduce dalla sconfitta contro Jesse Burnett e stava pensando di dare una svolta alla vita con le corse. Davanti a un’auto fiammante Galíndez esibiva l’espressione di un bimbo estasiato, sorpreso, isolato dal mondo.
C’è una gara d’auto nella provincia di Buenos Aires, lui e il manager Antonio Lizeviche si iscrivono con la Chevrolet numero 19. Le auto, le bottiglie e le donne erano le passioni di Galíndez. Grazie ai guadagni di una rapida carriera (dal 7 dicembre ’74, prima corona mondiale dei mediomassimi contro Len Hutchins, fino alla sconfitta con Burnett nel 1979 ha sommato un milione e 600mila dollari), il campione che viveva vertiginosamente ha collezionato tre Torino Ika, tre Peugeot, quattro Ford, un pick up Chevrolet, cinque Mercedes, una Corvette, una Pontiac Trans Am e una Bmw, più tre moto (una Yamaha e due Kawasaki). La prima gara delle due celebrità della boxe dura poco: 6 chilometri e l’auto si pianta per un guasto. Scendono, salutano il pubblico e mentre s’incamminano a bordo strada vengono falciati dalla Falcon impazzita di Marcial Feijo che li uccide sul colpo.
La vita di Galíndez, ancor prima del lampo della morte, era stata un’istantanea. Era nato a Vedia, provincia di Buenos Aires, il 2 novembre 1948. A 20 anni era professionista e nel 1968 aveva partecipato alle olimpiadi messicane. Lo scoprirono a una riunione dove c’erano in palio una coca e un sandwich: «Forse vincevo per la fame – raccontava – Eravamo poveri e io volevo fare soldi. Il sogno era comprare a mia madre una grande casa bianca con un tetto rosso».
A inizio carriera Galíndez arrivava al Luna Park, il Madison Squadre Garden di Buenos Aires, su una Fiat 600 con interni in leopardo. Anche la vestaglia con cui saliva sul ring era leopardata. Inguardabile, diceva il suo guru Tito Lectoure, che però vedeva in lui un ghigno speciale e gli trovava avversari sempre più forti per farlo diventare il più forte. Stravagante e vistoso, Galíndez mostrava sempre il petto tenendo la camicia aperta. Camicia alla moda, s’intende. Di giorno la boxe, di notte il resto. Galíndez aveva un debole per le bibite. Era capace di stappare una coca da un litro con i denti e di bersela d’un fiato. Era più forte di lui: di notte si alzava assetato e tracannava tutto quello che trovava.
Tant’è che le più grandi battaglie le ha combattute con la bilancia. Nel settembre ’78, alla vigilia del match con Mike Rossman a New Orleans, era fuori peso. Lectoure lo chiuse nella sauna dell’Hilton. Ne uscì debilitato e perse. Per la rivincita il manager fece dormire Galíndez con il suo allenatore, Oscar Rodríguez, che lo marcava a uomo e sigillava bagno e dispense. Ben allenato, Galíndez diede una gran batosta, una «paliza», a Rossman. Il suo capolavoro fu però il successo per ko all’ultima ripresa il 22 maggio 1976 contro Richie Kates. Dopo una tremenda testata, Galíndez era una maschera di sangue e sull’orlo del ko tecnico. Raccolse tutto quello che aveva in corpo e devastò l’ultimo round mandando al tappeto Kates a un secondo dal gong. Dietro, c’era la mano esperta di Lectoure, il quale nel momento critico del match disse all’arbitro che il medico dava l’autorizzazione a continuare, mentre al medico disse che per l’arbitro si poteva andare avanti.
Quello stesso giorno a Reno, nel Nevada, era stato assassinato il peso massimo argentino Oscar Natalio Bonavena, detto Ringo perché aveva i capelli lunghi come il batterista dei Beatles, uno dei più grandi pugili dell’epoca e idolo di Galíndez. Lectoure tenne segreta la notizia fino a dopo il match. Galíndez pianse come un vitello. «Se l’avesse saputo prima – diceva sicuro Lectoure – avrebbe perso quell’incontro».
Il Luna Park di Buenos Aires, che nel 1936 aveva ospitato i funerali di Carlos Gardel e che oggi è ancora in piedi, ha accolto tra le sue braccia paterne sia Bonavena che Galindez. Per Bonavena, che nel 1970 aveva affrontato Alì e che nel ‘66 e nel ‘68 aveva sfidato Joe Frazier per il mondiale perdendo ai punti dopo match durissimi, arrivarono in 150mila. A lui, che si era appena ritirato dal ring, è toccata la sorte di diventare uno degli atleti più amati d’Argentina. A Galíndez è andata diversamente. Ma nel mondo della boxe in pochi hanno dimenticato la sua stravaganza e i numeri irreversibili della sua carriera: primo argentino a vincere un mondiale negli Stati Uniti, 55 vittorie di cui 34 per ko, dieci allenatori in dieci anni, 12 difese del titolo fuori patria, compresa quella con Archie Moore. Talento e bibite, pugni e orgoglio. Non ha mai difeso la cintura mondiale nella sua terra, nemmeno quando il rivale era argentino: sconfisse Jorge Ahumada, nel 1975, al Madison di New York.
Dietro questi numeri e oltre la fatale passione per le auto e le corse («Correre è come volare», diceva agli amici), resta il cuore indomabile di un leone della selva oscurato dal monolito Monzón, altro indio, leggenda dalla smorfia triste, morto guidando con cuore selvaggio una Renault 19. Il numero maledetto. Galíndez, che amava la vita, l’adrenalina e il pericolo, dall’ombra è uscito come da una falla del destino. Il tempo di un saluto.