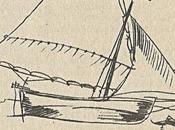Oggi, all’«Osteria d’Andrea», sedeva pacifico un signore che ritraeva vagamente da «Digiuno». Vi è certo qualcuno che ricorda il canto del ciabattino «Digiuno»:
«Il calzolaretto, che niente gl’importa
piglia la sporta
dei burattin.
E ci ha la testa che gli va via;
all’osteria
bisogna tornar».

Viareggio – Torre Matilde – Foto Archivio e Centro Documentario Storico di Viareggio
Oggi «Digiuno» è ritornato all’osteria, – chè quel pacifico signore seduto da Andrea era proprio lui, – ma con la testa al posto, e come! Ho tentato di rievocare il passato, ma mi è stato interdetto da un cenno di «Digiuno», simile a quello eternato dal Beato Angelico nel chiostro di San Marco a Firenze: egli si è posato un dito sulla bocca ed ha abbassato gli occhi: silenzio. Ed io ho fatto silenzio.
Avendo, in vita mia, fatto anche il ragazzo di calzolaio, ho abilmente osservato le mani di «Digiuno»: i risegoli che lo spago impeciato incide sui polpastrelli del dosso della mano sono quasi del tutto spariti; il callo, che producono il ferro da sformare e lo steccone, non si scorge più. Le mani di «Digiuno» si sono affusolate e ingentilite. Ma silenzio!
«Digiuno», dopo aver vestito non soltanto gli ignudi, come prescrivono le Opere, ma anche i morti e risolato e scarpettato quasi tutto il paese, un tempo assai lontano, a cagione di una maledizione che gli mandò un suo beneficato, fu messo a bando di Dio.
Un vecchio incagnito, con la testa pelosa ed ispida come un cardo strinato dal sinibbio, cattivo come una iena (che quando era sborniato si sdraiava sul terriccio e rosicchiava i sassi, gridando ogni tanto: «Brucio, brucio»), dormiva in una capanna di falasco nelle lame della palude, tra i canneti e l’ontanelle. Un cagnaccio spelazzato, guercio e smagrito, era legato a una calocchia piantata nel pantano fuori la capanna, dove si ricettava il vecchio sozzo e scarnato. Un giorno, gente corse alla Misericordia, dicendo trafelata:
– Correte prestamente nelle lame di levante, dove agonizza un vecchio mendico.
«Digiuno», che già aveva avuto l’ardire di porgere con le sue mani medesime il pane ad un lebbroso, dispiacendogli di vederglielo porgere con una forca come a una bestia, corse per primo ad assistere il mendicante morente.
Gli dette da bere perchè era assetato, gli dette da mangiare perchè era affamato, lo rivestì perchè era ignudo, corse dal contadiname vicino ed ebbe per il vecchio vitto e indumenti, lo distese su di un lenzuolo di bucato, gli rassettò la capanna e, pago delle sue opere, il povero «Digiuno» chiese con umiltà all’infermo:
– Ora non vi sentite meglio?
Sopra le occhiaie del vecchio mendicante si drizzò il pelame delle ciglia: e, squassato dalla pazzia, il vecchio si alzò spettrale, fissò «Digiuno» con due gocce di sangue bollente:
– Che tu sia maledetto in eterno, te e tutta la tua famiglia!
La maledizione del vecchio mendico perseguitò per anni ed anni «Digiuno» con dolori e con pianti, ch’egli tentava di affogare nel vino e nel canto:
«E ci ha la testa che gli va via;
all’osteria
bisogna tornar».

Viareggio – Darsena Vecchia – Foto Archivio e Centro Documentario Storico di Viareggio
Pare che anche le maledizioni, come le monete, si logorino col tempo, chè oggi «Digiuno» è tranquillo e pacato, vestito come un benestante che volesse imitare, con abiti buoni, un ciabattino il giorno di festa. Il gesto dell’imperioso silenzio non ha liberato «Digiuno» dalla seccatura delle mie domande inquisitive.
– Spiegami la metamorfosi del tuo temperamento e del tuo vestito; mi pare che ti sia scorciata la lingua e allungata la superbia.
– Parlerò, ma silenzio! Sono stati gli arnesi da calzolaio che m’hanno salvato e liberato dalla maledizione. Una signora, vedova e sola, era andata da un mio collega per farsi rimontare un paio di scarpe; egli dormiva acciocchito sul deschetto; destatosi di soprassalto, le disse: «Posi qui le scarpe e si metta a sedere: mi vado ad ammazzare e torno subito». Il mio collega l’indomani fu trovato sulla spiaggia spurgato dal mare. La rimonta delle scarpe toccò a me, ed io feci un vero punteggio, una insetatura di suole a dovere, tirai i tacchi a pero che parevano fusi, sformai con cera vergine e ritinsi con nero inferno tanto che il «capo» sembrava ritornato nuovo: divenni il calzolaio di sua fiducia; di lì ad accasarci ci corse soltanto un momento. Se mi verrai a trovare vedrai che anche i ferri hanno avuto la loro riconoscenza.
«Digiuno» si è ritirato in campagna, in una villetta a cui si accede da un vialetto lineato di rose rosse e gialle: villetta a tettoia, di un piano, per non aver la seccatura di scendere e salire le scale.
Nel salottino c’è un tavolinetto coperto di un tappeto a fiorami, con su un centrino ricamato; entro una cristalliera c’è un servizio per sei persone, di porcellana, dei bicchieri di vetro soffiato, delle bocce, e un lungo ordine di bicchierini; il pavimento lustrato a cera, sedie imbottite, canapè, e sulle pareti, sotto un velo di mestizia trasparente, ci sono i ritratti dei defunti: pace alla loro anima.
L’ordine palesa la presenza di una signora in questa casa taciturna e profumata di rose. Non mi sono ingannato, eccola: alta, distinta, fiera, garbata, misurata di termini. Ho l’impressione che i due abbiano messo in comune i loro dolori, oltre che le loro sostanze. La signora è sparita nell’attigua cucina, da cui viene un grato profumo di arrosto steccato di rosmarino. Quanto rosmarino è qui, intorno alla villa di «Digiuno», e che incensi di roseti sfioriti!
Legato a «Digiuno» da una vecchia fraterna amicizia, cementata tra i battiti del martello nelle notti desolate della giovinezza, quando la persecuzione della maledizione si scatenava sulla testa di lui, non ho esitato a domandargli:
– E il deschetto, e i ferri?
– Sono là, – ha risposto accuorato «Digiuno», accennandomi un salottino discreto e buio.
– E la maledizione?
– Chi sa, vedendomi così rimpellicciato, nel mondo di là come sgrana gli occhi di falco marino il vecchio Sciamanna, che mi maledisse trent’anni fa nelle lame di levante.
Ho, con discrezione, accennato alla signora alta, distinta, fiera, garbata, misurata di termini; ma «Digiuno» ha ripetuto il gesto eternato dal Beato Angelico nel chiostro di San Marco. E silenzio sia, anche su questo tasto.
– Ma cantare si può?
– Oh, quello sì.
«Il martedì, poi, giorno seguente,
male si sente
per lavorar.
E ci ha la testa che gli va via…»
ma non ho potuto concludere che all’osteria bisogna tornar, perchè «Digiuno» mi ha detto, con lo sguardo rivolto in casa, nel più profondo della casa:
– Silenzio! Ora i ponci me li fa in casa; l’ho convinta con la ricetta. La ricordi? Cos’è il ponce? Prima di tutto è caffè, e quando uno è ammalazzato, cosa ordina in primis il dottore? Caffè forte. Poi dopo viene il rumme: quando uno è in fin di vita, cosa dice il dottore? Provate a dargli una goccia di rumme. Poi viene lo zucchero: appena nasce un bimbo, prima che si avvii il latte dal petto della madre, cosa dice la levatrice? Dategli un pezzetto di zucchero. L’ultimo elemento è la scorza di limone: qui ci sarebbe da scriverci un romanzo; il limone salva dal tifo, dal colera morbus e da qualsivoglia infezione. Per combinare tutti questi elementi la umanità ci ha impiegato secoli perchè anticamente non si conoscevano i ponci.
Anche le protuberanze fragoline che un tempo rimettevano sul discreto naso di «Digiuno» sono sparite; il suo naso oggi ha la lucentezza laccata del frutto di stagione, le ciliege: «Acqua coi fichi e vin con le ciliege», dice «Digiuno», prendendosi gentilmente il naso tra l’indice e il pollice della mano sinistra. L’ho guardato perplesso e dubbioso. «Digiuno» ha mangiato la foglia:
– Lo pigliamo a damigiane.
– Il rumme? – ho detto.
– Il vino; il rumme si piglia a fiaschi.
La tavola era imbandita: tovaglioli aculeati a piramide, bicchieri capovolti, posate a trapezio, a cui pareva sospeso il piatto maiolicato; il vino era in una boccia di cristallo. Ho guardato, sedendomi, perplesso e dubbioso, «Digiuno»; egli ha mangiato la foglia:
– Ti verso io –, ha detto.
– L’umanità ci ha messo nove secoli per arrivare al fiasco.
– So anche quella, – ha detto «Digiuno»; – ma la boccia tiene un fiasco.
– Ma ti tocca bere con l’impaccio di quando ti sogni d’essere in camicia in mezzo di una strada. Ai tempi dei fiaschi («Digiuno» mi ha guardato con gli occhi supplichevoli di un vitello) potevi travasarlo senza rendere scandalo.
– È vero.
La boccia si è svuotata, come se sotto il tavolo ci fosse stata la pompa di un rifornimento di benzina; ma subito si è avuta la sorpresa di riveder un’altra boccia rossa infiammata, sì che pareva che il vino fosse passato da una boccia all’altra, come nei giuochi di prestigio.
– Alziamoci or dunque.
I lambicchi dei caffè espressi filtravano in tre bicchieri distinti. Il rumme era entro una bottiglia impagliata:
– Le ho detto che sarebbe stata vergogna –, osserva, con qualche gravità, «Digiuno». E prosegue:
– Vuoi vedere il salottino?
– E vediamolo.
La porta è stata spalancata, la luce elettrica accesa: oh meraviglia! Il deschetto abbagliava d’oro come un piccolo altare; il trincetto di «Digiuno» che dalle arruotature era ridotto soltanto un palmo, legato con un filo di oro pendeva da un chiodetto tutto dorato a foglia di zecchino; similmente il martello, la lesina, il cava-forme, lo steccone, il guardamano, la pietra da affilare; anche una stenderia di forme, in bell’ordine, erano tutte dorate sì che parevano piedi di statue antiche dell’Oriente. «Digiuno» ha reso d’oro anche quel gran ghiaione di fiume sul quale per degli anni ha suonato a martello la sua desolazione.
L’ho guardato fisso negli occhi ceruli, rimasti intatti, stupito e dubbioso; egli mi ha detto:
– A chi fa è così: l’oro s’indora con l’oro.
(Lorenzo Viani, L’ex ciabattino col trincetto d’oro, racconto tratto da “Il nano e la statua nera” )