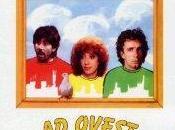Nel gennaio del 1556 accadde nel territorio di Lucchesia uno straordinario fenomeno: si videro fiorire le rose, maturare le fragole, le viti coi pampini, gli alberi verdeggianti come se fosse stato maggio; a tutti parve che la mano dell’Onnipotente avesse dissepolto la primavera di sotto un’arca di neve. Questo prodigio dai timorati di Dio si dice fosse riguardato come un pronostico di qualche flagello vicino proveniente dal cielo e tutta la Lucchesia si tramutò in una grande Ninive penitente. Di solito i popoli temono l’avvicinarsi dei flagelli quando odono il cielo bombire e la romba del vento che si intomba nelle cappe dei camini sul cui focolare già crepitano come sarmenti i rami dell’ulivo benedetto e gli uomini accecati dai lampi recitano le devozioni. Ma il lucchese non si commosse a tutto quell’inusitato fiorire degli alberi nel crudo inverno, e disse:
– Che questi fiori non si tramutino in tante ghirlandette tombali.
Una di queste algide notti parve essersi ripetuto il miracolo della fioritura; spannando i vetri della finestra, si scorgeva sulla piana della Lucchesia e sui monti di Pisa che la interchiudono, dando la mano alle dirupate scoscese delle Apuane, tutta una esitante primavera: faceva civetta dai monti fioriti di bianco, le ombre abbrividite di azzurri, i botri verde tinto, i gelsi tramutati in rappe di gelsomini; le rame dei salicastri lungo il Serchio sanguinavano d’umidi rossi; le acque, sui ratti vellutati d’ardesia, prendevano il turchinetto dal cielo; il lago sembrava un grande pesce argentato che, sospirando, amoreggiasse con la luna.

Massarosa – Cacciatore in padule – Foto tratta da “Come eravamo-Lucca” – Ed. Il Tirreno
Le folaghe dondolavano sull’acque tranquille e chiare, come se fossero state di sughero, come gli «stampi»; quegli uccelli che i cacciatori fan galleggiare davanti ai loro capanni a richiamo dei volatili. Udendo qualche sparo isolato, le folaghe avranno pensato al fulmine a ciel sereno. Ma la folaga proveniente dalle fredde arie brumose barcheggiando leggera sui folaghi, certi stagni d’acqua che fiatano caldo come i bovi, può darsi che abbia pensato, come i lucchesi, che tutte queste bellezze non si tramutino in tante ghirlandette. E così fu.
Nella più incarnatina delle albe che si fosse mai vista, tanto che le nuvolette sembravano ditate di celeste su tutto quel roseto che si spampanava sul tremulo lago, certi barchini pitturati di pece, marini come ossi di seppia, capaci soltanto di portare il cacciatore e il barcaiolo il quale, munito di un remo da spinta, dava direzione alla navicella, cominciarono a sbucare dai ciuffi dei falaschi, dalle spiaggette, dalle piccole calanche, dalle grandi sponde di levante e di ponente. Così comincia la tela alla folaga. Ogni cacciatore riguarda i suoi fucili. I branchi delle folaghe staccano sul lago come nuvole plumbee, da quelli stormi si leva rado e rauco un accordo triste di zampogna, i barchini si dispongono intorno agli stormi a guisa di un telaio e cominciano la «stretta»; alle prime fucilate comincia lo scompiglio, un fremito d’ale ondulante, un impetuoso sciaguattìo di tronconi percossi a fior d’acqua, una tela infuocata di schioppettate avvampa l’aria, i barchini vanno e le folaghe ubriacate dagli spari roteano folli, vengono come la spola della tessitrice sull’ordito; quelle uccise cadono a picco come fossero d’alastro, quelle ferite vengono sterminate dai colpi; i cacciatori si contendono quelle uccise in due, in tre, in cinque nel trambusto; qualche branco si alza e punta ai monti di Levante, le folaghe ferite si gettano spossate nei folti dei giuncheti, i colpi dei fucili sono come raddoppiati dal rimbombo dei monti; scompiglio nel cielo, scompiglio sul lago, le stive di quasi tutti i barchini sono ingombre di folaghe uccise che il barcaiolo stringe con un giunco e il cacciatore, appena sbarcato, le porta come in trionfo.
La folaga, alla cui tela convengono, in questo lago leggendario da molte parti d’Italia, è un uccellaccio che rende, cucinandolo, il salvatico delle marigiane, quegli uccelli che si nutrono di spurghi marini e d’alga; la folaga, anche se spellata e messa in guazzo nell’aceto, rende sempre un che di palustre e fa scervellare un cuoco che deve trovarle un sapore a furia di droghe.
Tra i rari manoscritti lasciati dal maestro Giacomo Puccini, il quale fu appassionatissimo cacciatore, c’è la maniera di cucinare la folaga e di toglierle da dosso il salvatico. Certo inaspettato zampognare nella sottile strumentazione delle sue opere. Egli diceva di averlo studiato quando nelle silenziose notti estive certi cacciatori, con una piccola zampogna di canna, imitavano il canto delle folaghe, e queste, ingannate, si buttavano, e venivano sterminate anche a centinaia.
Eppure ai cacciatori, quando ritornano dalla tela con un bel ciuffo di folaghe, sembra di andare a far Pasqua, come i pescatori quando ritornano in porto con le corbe ripiene di salacche; pescatori e cacciatori ricordano certi avvogliati di vino squattrinati, i quali dimandano all’oste:
– Cattivo, ma tanto.
Ai tempi che il maestro Giacomo Puccini, armato come un saracino, si sacrificava nel chiattino per la tela della folaga, sulla sponda del lago c’era accampata una tribù zingaresca di pittori sfornati freschi freschi dalla trattoria famosa di «Gigi porco», in Firenze, dove, insieme ai loro maestri Giovanni Fattori e Telemaco Signorini, si cibavano di carne di ciuco, quella che cresce in bocca come il mosciame, quegli interiori di pesce seccati e rattorti dal sole.
Plinio Nomellini, già adulto nell’arte, Ferruccio Pagni, detto «Ferro» perchè avrebbe digerito i chiodi rattrappiti, Cecco Fanelli, il Gambogi, la prosapia dei livornesi Tommasi e, come i gabbiani di passaggio, Giulio Cesare Vinzio, il Natali, Mario Puccini (il pittore bravo e trascurato), trattavano le folaghe con gli onori delle beccacce. Nel tempo che l’arrosto girava sullo spiedo, piantato verticalmente sulla terra, s’udivano ripercossi dal bosco certi sbadigli di Pagni, nei quali erano fusi il bramito della belva e l’urlo del pirata all’arrembaggio; lungo com’era, avrebbe da solo diluviato anche lo spiedo. Quando augnava il suo quarto di folaga, digrumava anche l’ossa, gridando agli astanti stupefatti:
– I gatti fanno così!
– Hai ragione, caro Ferruccio, – rispondeva Nomellini, – ma io fino a lì non ci arrivo, – e mostrava una carcassa di folaga ripulita di ogni tiglia.
Oggi i nomi di questa ondata di pittori (vivi e morti) sono stati scolpiti sopra una lapide, che è stata murata sulla facciata della casa di una società di cacciatori, che è davanti al lago e, sotto, c’è dipinta a tempera una schiera di folaghe. Quando portai questa notizia al Poggio Imperiale, Nomellini strillava come una folaga spellata viva:
– Delle aquile, delle aquile dovevano affrescarci sotto i nostri nomi; o che siamo uomini salvatici?
Dopo che si fu rappacificato, mi disse:
– Devi sapere che da un pezzo in qua, con gli animali sono disgraziato. O senti: vengo ora dall’Elba, dove ero citato come testimonio in una causa che si dibatteva contro un tale che aveva bestemmiato proprio sotto la mia casa a Marina di Campo. Il pretore mi disse sbrigativo: «Racconti in succinto il fatto.» Risposi: «Ero lì sotto casa che stavo dipingendo un ciuco…. » A queste mie parole ti sento scoppiare una risata generale. Nomellini, che è livornese e lettore perseverante dell’Asino del suo conterraneo Francesco Domenico Guerrazzi, a quella risata generale, a cui fecero eco anche gli avvocati e le parti, rispose: «O cosa c’è da ridere? I ciuchi sono bestie intelligenti. Gli uomini sono imbecilli quando diventano ciuchi».

Massarosa – Due cacciatori al ritorno di una tela alle folaghe nel 1947 – Foto tratta da “Come eravamo-Lucca” – Ed. Il Tirreno
Vedendomi con uno strano involto sotto il braccio, mi ha chiesto garbato:
– O lì, cosa ci hai?
– Un regalo per te.
– Permee? Permeee!
– Sì, per te. Ieri c’è stata la tela….
Non potei finire la parola che lui, agile e volastro come un falco, strillava in tutte le modulazioni:
– No, no, no, no, no, oibò! Uccelli del paradiso ci vogliono! – e intanto dava delle pennellate su delle ali di cherubino.
( Lorenzo Viani, Tela alla folaga, tratto da “Il cipresso e la vite” )