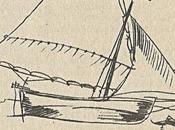La “Canaglia” era geldra varia.
Giuliano e Ruffino, due fratelli spagnuoli, attempati, uno cocchiere e l’altro alla dispensa del vino. Giuliano, testa da famulo fiscale, bevve tanto e poi tanto che col tempo il vino si convertì in acqua e morì lentamente di idropisia.

Viareggio – Villa Borbone
I cocchieri, oltre Ruffino, piccino piccino con gli occhi vivi come bacche di mortellino, erano un francesone grosso come una botte, con dei basettoni lunghi un palmo, e un altro spagnuolo.
L’unico italiano della scuderia era soprannominato “il Nasone” a cagione del suo naso inviperito e rosso in punta. Il Nasone avrebbe bevuto Adige e Brenta se quei fiumi avessero corso in vino; egli beveva anche quando era bardato della livrea celestona, coi bottoni d’argento e il cilindro nero su cui spiccava la coccarda gialla e rossa.

Viareggio – Villa Borbone – Scuderie
Un giorno accadde un fatto che destò furore nel “Palazzo”: davanti al cancello della Reale Tenuta c’era una rimescita di vino padronale alla quale dicevano “La Proibita”, perchè i padroni avevano proibito alla “Canaglia” di fermare il regal cocchio davanti alla rimescita.
Dunque, un giorno che la “Sovrana” aveva fatto attaccare un tiro a due, e lei stessa aveva preso le redini e il Nasone le stava al fianco impettito come se avesse ingollato un bastone, la pariglia, appena fuori del cancello, s’andò a fermare davanti alla rimescita e non c’era più né modo né verso di farle riattaccare il trotto.
Lo stalliere era un contadino il quale si dannava l’anima perchè nel “Palazzo” era proibito, come lepisto le corte, di mangiare l’aglio.

Viareggio – Villa Borbone – Scuderie
Nel tinaio, a sciaguattare le botti, ci stava un contadino torbido a cui dicevano il “Moro” perchè aveva l’occhio truce dei mori e la pelle colore della buccia di una noce. Egli era continuamente sborniato e digrumava cicche e moccoli. Era l’unico che poteva cibarsi di teste di cipolle e d’aglio, e per questo lo invidiavano tutti quelli della “Canaglia”.
I camerieri erano gente del luogo incivilita. Col tempo diventarono tutti uguali. Il cuoco sembrava una statua di Budda plasmata di burro. Ai tempi della mia infanzia, il sotto-cuoco era un certo “Gioasse”; lo chiamavano così perchè, essendo egli toscano e remissivo, diceva sempre nelle traversità della vita: Giovasse: gioasse.
Dunque, Gioasse, era uno di quegli uomini nati e cresciuti per le cucine, assuefatti ai lavori più umili e più bassi.
– O che ti adatti anche a questo?
– Gioasse! – rispondeva egli invariabilmente.
Gioasse era uno di quegli uomini di cucina che, coll’andar degli anni, rendono sempre un sito di unto anche se si sgrumano colla lisciva, e le cui mani sono quasi lessate dove s’incarnano l’unghie.
Anche Gioasse beveva; beveva tanto che fu licenziato per ripugnanza. Dopo il licenziamento, Gioasse si dette a bere, a bere a più non posso, e tanto bevve che fu colto dalla idropisia e dalla elefantiasi; da taciturno che era diventò sboccato e lubrico; poi, accattone ramingo per la campagna, tutti gli porgevano qualcosa e lo allogavano la notte nelle altane, sopra le stalle, ove i contadini ripongono il fieno che disseccando odora. Una notte una di queste altane prese fuoco. Il sinibbio alzò le fiamme al sereno stellato e le faville parvero stelle rosse. Gioasse bruciò vivo quella notte. La mattina trovarono le sue ossa annerite dal fumo.
Lo sguattero si chiamava Sisto ed era meschinissimo di statura, con due baffoni lunghi lunghi che sarebbero stati bene sul viso di un saraceno. Egli pescava sempre in un caldaione di rame, nel quale egli ci poteva essere lessato. Là dentro pescava piatti e scodelle stemmate d’oro, forchette d’argento, coltelli col manico d’avorio, come alla pesca reale.
L’altro sguattero era un ragazzone bianco e rosso come una mela. I padroni l’avevano raccolto perchè suo padre, guarda-boschi, era stato freddato con una fucilata nel petto da un cacciatore di frodo. Nel palazzo v’erano molte cameriere e istitutrici, e una guardarobiera butterata nel viso dal vaiolo…
Poi, v’era il fattore, un codino partigiano del Duca di Lucca, stitico come un’ape, il quale passeggiava sempre per i campi, maledicendo tutti i ragazzi; non li poteva vedere. Egli era uno scapolo vecchio, barboso, avaro, tirchio, tirannico.
Ricordo che quando egli ci incontrava per i poderi che erano estesissimi, ci teneva d’occhio e ci pedinava come un secondino. Noi si peluccava l’uva e poi si faceva delle senate delle pigne più belle, si scaricavano i meli e i fichi e si passeggiava sulle sparagiaie. Egli, essendo vecchio, non poteva correrci dietro, ma trovava il suo sfogo facendo l’atto di imbracciare il fucile e fare con la bocca: «Tun, tun, tun.»
Se riusciva a prenderci a tradimento, ci scalciava quasi gli orecchi. Il fattore era fanatico della lettura, leggeva i giornali dalla prima all’ultima parola. Noi, quando egli era ben bene concentrato nella lettura, ci si avvicinava in punta di piedi e gli si dava fuoco al giornale.
La sera poi, tra lui e i nostri genitori ci finivano di legnate.

Viareggio – Villa Borbone
Il falegname della casa sembrava San Giuseppe; il suo figliolo fu quello che una sera mi tirò in un pozzo fondo una diecina di braccia e lui, perso l’equilibrio, mi venne dietro: per ripescarci bisognò che facessero della vita torchio. Egli che al momento in cui mi gittò nel pozzo era ubriaco, al fresco e al gelo tornò in sè e mi tenne sulle spalle come San Cristoforo. Quel giorno, era il giorno dello Spirito Santo, a cui, disse mia madre, dovevo la vita più che allo scalone che i contadini accorsi al tonfo calarono nel pozzo.
( Lorenzo Viani, tratto da “Il figlio del pastore”, 1929 )