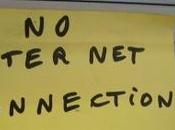Sono tornata a casa per qualche giorno. Dovevo restare solo per un fine settimana, ma mi sono trattenuta più a lungo. Le ragioni ufficiali: cambiare aria, un concerto, andare a trovare nonno Igino, probabilmente assisterlo per un po' in ospedale.
Ero già stata a fare una notte, prima del mio più recente rientro a Trento. Non avevo chiuso occhio per un secondo, perché il mio compito consisteva nel tenergli ferme le mani per evitare che si togliesse i tamponi che gli avevano messo nel naso.
Mio nonno ha la seconda elementare e parla solo in dialetto, ma è la persona che mi insegnò a scrivere in stampatello maiuscolo e minuscolo. Durante ogni pomeriggio di un'estate flemmatica, di cui ricordo lamiere bollenti e il mio solitario saltare la corda in cortile, mi dava delle lettere da copiare. Io lo osservavo mentre le preparava per me, con una lentezza e una precisione tipica di chi ha scritto poco nella propria vita. Lo sforzo per stare entro le righe, ogni carattere della giusta altezza. Io copiavo.
In ospedale non ho sentito le usuali bestemmie di mio nonno, che da sempre punteggiano la sua parlata con una naturalezza che non mi hai mai dato fastidio. Erano finalmente riusciti a sedarlo. Mia nonna, sfinita, dormiva su una poltrona vicino al letto. Io cercavo di non spezzarmi il collo nel tentativo di appoggiare la testa da qualche parte e tenergli al contempo le mani ferme.
La mia prima vera bici me la regalò lui, e in verità anche l'ultima.
Mio nonno Igino è sempre stato appassionato di biciclette. D'estate mi rubava il posto davanti alla tv per "guardare il ciclismo". Io me ne andavo in un altra stanza.
L'ultima bici di mio nonno aveva un telaio da corsa, con pedali e manubrio da modello da città. Per due anni è stata ospite di un garage amico. Poi è stata smontata, ha preso la pioggia ed è arrugginita. Ora è la mia bici di Vicenza. L'estate scorsa l'ho aggiustata un po' per volta, benedicendo i mercoledì sera del 2010 trascorsi in ciclofficina, a strizzar gli occhi per lavorare nella penombra.
Da quando ha avuto un infarto, nonno Igino chiama mia nonna Cecilia per cognome. Le ha sempre dato gli ordini, ma negli anni è diventato progressivamente più scostante.
Non credo di avere un singolo ricordo di situazioni in cui egli sia stato gentile con lei in mia presenza.
Mia nonna Cecilia me lo disse già quand'ero troppo piccola per capire a cosa stesse alludendo: non sposarti mai, che il matrimonio è solo l'ennesimo un modo per fare di te una serva.
Quando sono tornata in ospedale, le cose erano cambiate rispetto alla volta precedente. Le infermiere avevano chiesto a mia nonna di accorciare le sue visite. Questo pareva l'unico modo per farlo stare un po' più calmo. Con lei e con mia madre non c'era modo fermare l'interminabile flusso di minacce, lamentale e porchi che uscivano dalla bocca di mio nonno.
Quando mi sono seduta accanto al suo letto, invece, pareva tranquillo.
Non sapevo cosa dirgli. Escludendo forse i discorsi di politica a Natale e a Pasqua, non abbiamo mai parlato più di tanto. Il punto era che egli appurasse che ero ancora una brava ragazza. Ad ogni visita in quel di Magré, lo raggiungevo in salotto, dove ascoltava la radio accanto alla sua bombola d'ossigeno, e gliene davo conferma dicendo "bene", "sì", "come al solito".
Ho fatto lo stesso la sera della mia ultima visita. Solo dopo un po' mi sono resa conto che guardava me, ma vedeva qualcun'altra. Una cugina che non ho mai conosciuto, forse. Parlava di parenti di cui non so nulla. Io annuivo, come quando mia nonna Lilia, anni fa, mi raccontava di eventi consumatisi durante gli anni '40 e '50, come se fossero avvenuti quella mattina stessa.
Mio nonno parlava con un altra, e io annuivo. Mi ha citata ad un certo punto, dando ad intendere che non è chiaro cosa io stia facendo della mia vita.
Ubriaca per due giorni pressoché consecutivi. Presentabile solo durante il pranzo con i miei. Fuori piove, piove da un'eternità. Ricordo poco della sera precedente, ma riesco a ricostruire quando e cosa ho bevuto con relativa precisione. Da giorni, quando sono in giro e mi metto le mani in tasca, vi rinvengo con inedito stupore il biglietto da visita di un locale che mi è stato donato quella notte, accompagnato dal commento "mio zio è morto lì". So per certo che era un modo per provarci. Tra ubriachi potrebbe anche funzionare. Non in quel caso.
Rivedo pavimenti, i miei occhi chiusi, lo sconcerto nel realizzare che non avevo ricordi di quanto avvenuto un'ora prima. Il mio parlare, che rimbombava contro le pareti, tornando a me in forma distorta. La mia voce diceva: "Perché non te ne stai zitta? Tanto è inutile esplicitare queste cose, ora".

Margherita mi parlava, e io l'ho ascoltata con tutte le mie forze.
Mi pareva il minimo.
Poi ho ricominciato a bere, in parte per rimuovere temporaneamente la consapevolezza del fatto che tutto ciò che posso fare è ascoltare. In parte perché si era deciso di offrire un giro a testa. Le birre arrivavano da tutte le direzioni, passavano di mano in mano, mi comparivano alle spalle senza preavviso.
Nel frattempo, una performance sconvolgente sotto i miei occhi. Qualcosa di sublime, nel vero senso del termine. Così terrificante da farmi dimenticare le voci che mi ripetono che il posizionamento è sbagliato, che ci vogliono precauzioni nell'esporsi. Così terrificante da farmi commuovere e bisbigliare all'orecchio del mio vicino versi senza senso, che volevano dire "questa è una delle cose più belle e potenti che mi siano successe".
Non è più chiaro cosa stia facendo della mia vita. Passano le settimane, e le domande si infittiscono.
Le più accattivanti sono quelle di mia madre che, non leggendo questo blog, ignora il fatto che io pensi di continuo alla morte, alla malattia, al futuro, alla miseria economica e spirituale, e alla solitudine, e quindi me lo chiede, "ma tu ci pensi mai a queste cose?". E io, quieta, guido lungo una strada poco illuminata e le rispondo "sì, certo, che ci penso".
(foto: Ana Mendieta)