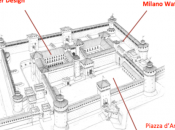Manifestazione di Otpor! a Belgrado, nel 1999
Facciamo iniziare questa vicenda nei Balcani, e più precisamente a Belgrado. Anno 1999. L’unica crisi conosciuta si studiava a scuola, quella del 29 ottobre 1929. La madre di tutte le crisi. Il trampolino di lancio americano. Il mondo usciva dai Nineties, con l’assurda consapevolezza di dover ormai gestire solo piccoli fastidi, nella corsa verso il progresso. La maggiore minaccia era rappresentata dal Millennium Bug, che paventava un “reset” sistematico di ogni apparecchio informatico sul pianeta. In quel contesto, molto differente dall’attuale, le manifestazioni nella capitale serba fiammeggiavano lungo le strade, tutte compatte contro Slobodan Milošević e il suo governo oppressore. Il tiranno tra i tiranni, secondo l’opinione pubblica, nel conflitto jugoslavo. L’artefice, secondo l’opinione pubblica, della pulizia etnica in Kosovo. Il movimento, chiamato Otpor (in cirillico Отпор!, traducibile con “Resistenza!”), ispiratosi alle teorie non-violente del politologo americano Gene Sharp, includeva tra le sue fila studenti, intellettuali e lavoratori, e aveva come simbolo il pugno chiuso. Questo, alla fine del secolo scorso. Negli anni successivi, questo movimento assunse la forma di un vero e proprio Centro Organizzativo, un’associazione volta ad influenzare ed assistere qualsiasi tipo di “rivoluzione” (i paesi in cui ha agito e continua ad agire l’Otpor, o Canvas, sono circa una cinquantina). Il finanziamento economico di questa “organizzazione del dissenso”, però, ha i contorni piuttosto nebulosi. Scrive Michel Chossudovsky, di Global Research, qualche giorno fa: «Le élite economiche – che controllano grandi fondazioni – supervisionano anche il finanziamento di numerose organizzazioni della società civile, che storicamente sono state coinvolte nel movimento di protesta contro l’ordine stabilito economico e sociale. I programmi di molte organizzazioni non governative (comprese quelle coinvolte nel movimento ‘Occupare Wall Street‘) si basano molto sui finanziamenti di fondazioni private tra cui le fondazioni Tides, Ford, Rockefeller, MacArthur, tra le altre.

Storicamente, il movimento anti-globalizzazione che è emerso negli anni ’90 si è opposto a Wall Street e ai giganti del petrolio del Texas, controllati da Rockefeller, e altri. Eppure, le fondazioni e le associazioni di beneficenza di Rockefeller, Ford ed altri, hanno, nel corso degli anni, generosamente finanziato reti progressiste anti-capitaliste e ambientaliste (opposte a Big Oil), al fine di sorvegliare e, in ultima analisi, l’elaborarne le varie attività». Dunque, quel che emerge, è una sorta di “business per la rivoluzione”. Dalla rivoluzione rosa in Georgia, passando per quella arancione in Ucraina e quella verde in Iran, fino ad arrivare alle primavere arabe, tangibile ed evidente è l’ingerenza di tale organizzazione (confermata dal rapporto della rivista Foreign Policy) nel pianificare movimenti di rivolta in tutto il pianeta (Myanmar, Cambogia, etc. etc.). «Il viaggio dalla dittatura alla democrazia non consiste semplicemente nel sovvertire una leadership non democratica e nell’organizzare elezioni libere e giuste. E’ anche e soprattutto un lungo processo di costruzione delle istituzioni» afferma Srdja Popovic, direttore del Centro per l’Applicazione di strategie ed azioni non-violente (Canvas) di Belgrado. Ed è proprio a Belgrado che i dissidenti egiziani anti-Mubarak (ossia gli organizzatori della grande manifestazione del 6 aprile scorso a El Cairo) furono istruiti per pianificare la rivolta. Rivolta che, guarda caso, presentava gli stessi simboli (pugno chiuso) e gli stessi slogan (“Basta!”) del movimento serbo che portò alla caduta di Milošević, nell’ottobre del 2000. «Nell’estate del 1999, il capo della CIA George Tenet, apriva un ufficio a Sofia, in Bulgaria per “educare” l’opposizione serba. Lo scorso 28 agosto [2000], la
BBC ha confermato che uno corso speciale di 10 giorni era stato seguito dai militanti di Otpor, anche a Sofia. Il programma della CIA è un programma in fasi successive. Nella fase iniziale, lusingano il patriottismo e lo spirito di indipendenza dei serbi, agendo come se rispettassero queste qualità. Ma dopo aver seminato confusione e spezzata l’unità del Paese, la CIA e la NATO farebbero molto di più» (Gerard Mugemangano e Michel Collon, “To be partly controlled by the CIA? That doesn’t bother me much”, Interview with two activists of the Otpor student movement, International Action Center (IAC), 6 Ottobre 2000).
Siamo dunque di fronte ad un vero e proprio centro di consulenza per la rivoluzione, con ramificazione capillare e rigorosa metodologia. Una caratteristica evidente è, ad esempio, l’utilizzo dei mass-media come veicoli di trasmissione della teoria del dissenso. Ricordate quando, lo scorso inverno, si inneggiava ai social network come canali di trasmissione della rivolta tunisina prima, egiziana e libica poi (“Raid aerei su Tripoli, migliaia di morti”, solo un esempio)? Una domanda spontanea, che resta irrisolta, è questa: come ha fatto internet a recitare un ruolo da collante per milioni di persone, in paesi dove la connessione è possibilità per pochi (stiamo parlando di villaggi), e laddove c’è, è controllata (e dunque censurata) dalle istituzioni governative? Per esempio: in Libia, i providers internet sono in mano al figlio di Gheddafi. Ora, si può riuscire ad immaginare, giusto per fare un esempio, Mediaset che lancia segnali per destituire Berlusconi? La similitudine può risultare pacchiana, lo so, ma piuttosto efficace per far comprendere l’assurdità della tesi e la portata del progetto descritto sopra.

Dunque, slogan ricorrenti, simboli ricorrenti. Basta fare un giro sul sito del movimento “Occupy Wall Street”, e notare la coincidenza dell’ormai consueto pugno chiuso, utilizzato a Belgrado per rappresentare il movimento anti- Milošević. Insomma, dopo anni trascorsi a destabilizzare dittature e regimi nei paesi “di secondo livello”, con l’avvento della Crisi, CANVAS ha dirottato le sue attenzioni nel fomentare il dissenso nei paesi occidentali. Ivan Marovic, uno dei leader di Canvas, si è recentemente rivolto al movimento di Brooklyn (Qui il discorso di Ivan Marovic a New York). Scrive ancora Michel Chossudovsky, su Global Research, il 13 ottobre: «“Anonymous”, il social media del gruppo “hacktivista”, è coinvolto negli attacchi informatici ai siti web del governo egiziano, al culmine della “primavera araba”. Nel maggio 2011, “Anonymous” ha condotto attacchi informatici contro l’Iran e lo scorso agosto ha condotto simili attacchi informatici diretti contro il Ministero della Difesa siriano. Questi attacchi informatici sono stati intrapresi a sostegno dell’opposizione in esilio siriana, che è in gran parte integrata dagli islamisti. (Vedasi
Syrian Ministry Of Defense Website Hacked By ‘Anonymous’, Huffington Post, 8 agosto 2011). Le azioni di “Anonymous” in
Siria e Iran sono coerenti con il quadro delle “rivoluzioni colorate”. Cercano di demonizzare il regime politico e creare instabilità politica». Il ruolo di CANVAS tra gli indignati newyorkesi è ancora da decifrare, tuttavia la sua
influenza sembra piuttosto palese. Lo stesso Marovic, in una dichiarazione risalente ai primi mesi del 2011, riconosceva come non ci sia alcunché di spontaneo in un movimento di protesta: «Sembra che le persone siano appena andate in strada. Ma è il risultato di mesi o anni di preparazione. E’ molto noioso fino ad un certo punto, quando potete organizzare manifestazioni di massa o scioperi. Se è attentamente pianificata fin dall’inizio, tutto finisce nel giro di settimane». (Citato in Tina Rosenberg, Revolution U, Foreign Policy, 16 febbraio 2011).

“Mesi e anni di preparazione”, insomma. Nessun effetto domino, come i media occidentali continuano a dichiarare da mesi. Un’azione pianificata, nata con gli “Indignados” di Puerta del Sol a Madrid, e ora sbarcata anche a Roma. Una sceneggiatura con gli stessi figuranti che si riciclano. Come quel ragazzo con la barbetta, Luca Cafagna. Lo stesso intervistato sia dal Tg1, che dal Tg5 (guarda caso, pescato in mezzo a mille manifestanti) nei giorni scorsi. Lo stesso chiamato ad
Annozero nel confronto-scontro con il Ministro della Difesa La Russa, durante le giornate di protesta dello scorso inverno culminate con gli scontri del 14 dicembre. Un volto fisso, insomma, spacciato per casuale. Spacciato per paradigma del giovane insoddisfatto. Dichiarazioni, quelle di Cafagna, che poco si discostano da un generico e approssimativo commento sulla situazione generale: “Siamo insoddisfatti”, “Noi la vostra crisi non la paghiamo”, “Battaglia alla finanza, e alle banche”. La stessa finanza che però, curiosamente, nella mattinata del 15 ottobre, per voce di uno dei suoi uomini più influenti, quel Mario Draghi Governatore di Bankitalia e futuro presidente della Banca Centrale Europea, si è schierata a favore del movimento: «Draghi benedice la protesta, purché naturalmente non degeneri. E fa capire che l’appello dei ragazzi e delle ragazze “indignati”, se pacifico, ha sicuramente più possibilità di essere ascoltato a tutti i livelli e tanto più al suo, che tra due settimane diventerà il banchiere dei banchieri». Insomma, il movimento contro le banche, benedetto dal “banchiere dei banchieri”. Un po’ come se
Silvio Berlusconi appoggiasse le iniziative del Popolo Viola. Mille domande sepolte sotto la sabbia: per organizzare una qualsiasi manifestazione in una qualsiasi piazza di una qualsiasi città italiana (e mondiale, suppongo), vanno richiesti dei permessi, con nomi e cognomi. In nome della trasparenza, chi ha fatto da garante per la manifestazione nella Capitale? Chi si è fatto carico
di tutto questo? Qual è la firma posta in calce al permesso presentato alla Questura? “Indignados”? “Indignati”? Come è possibile che un centinaio di black bloc riescano a mettere a ferro e fuoco il centro di una città come Roma? Come è possibile che la manifestazione sia stata così pompata dagli organi di stampa, tesi a martellare ben prima dell’evento, piuttosto che concentrarsi sul “post” (come di solito accade)? Come si fa a credere che una pagina
Facebook di neanche 10000 aderenti abbia potuto contribuire al consueto “tam tam da social network” tanto sponsorizzato dai mass-media che ha portato mezzo milione di persone per le strade di Roma, alla stessa stregua dei discorsi fatti per la situazione “multimediale” nordafricana? Perché, se questa manifestazione (in concomitanza con altre 950 manifestazioni sparse per il globo), come sembra, vuole porsi come baluardo contro il sistema, viene sponsorizzata così apertamente dallo stesso sistema, banchieri compresi?
Luca Cafagna, studente romano
Questa analisi vuole dunque delineare i contorni di una pellicola già vista, di una struttura cinematografica ormai tradizionale. Intervista al fantoccio di turno, casualmente raccolto tra migliaia di manifestanti (un nome a caso, che so: Luca Cafagna), per preparare il terreno. Solito lucido intervento di Sabina Guzzanti, che con la sua competenza (unita a proverbiale tranquillità e autocontrollo) imputa tutti i mali al bandito Silvio e ai suoi compari. Lei, l’indignata di lusso. La super indignata, un’indignata sul piedistallo, un pupazzo da slogan, che ha perso comicità consapevole, a scapito di quella inconsapevole. E poi, auto incendiate, vetrine rotte, banche assaltate. Dopodiché, nel dopo partita, indagini sui black bloc infiltrati dalla Polizia (che si riconosceranno dalle scarpe), sermoni di Saviano, attacchi della maggioranza alle violenze di piazza, indignazione di tutte le forze politiche, solite banalità di Napolitano, interviste a manifestanti fasciati e sdraiati su lettini d’ospedale. Prese di distanza dai violenti, che hanno rovinato «una serena e festosa giornata di manifestazione» (come se, di fronte alla riduzione del proprio stipendio, si reagisca portando cappellini, trombette, torta e candeline nell’atrio del proprio ufficio). E lunedì, tutti a lavoro. Tutti a mandare avanti la macchina. Attendendo il prossimo evento mediatico da fine settimana, comodi in poltrona, o scomodi nelle piazze. Perché si sa, la volontà che pesa è sempre quella del produttore.
(Pubblicato su “Il Fondo – Magazine” del 17 ottobre 2011)