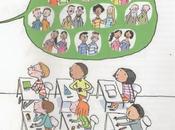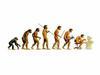Qualche tempo fa Morgan Palmas riportava su Facebook un breve stralcio di una conversazione avuta con un amico.
Qualche tempo fa Morgan Palmas riportava su Facebook un breve stralcio di una conversazione avuta con un amico.
L’amico chiedeva a Morgan: “Ma tu leggi tutti i giorni?”
E Morgan rispondeva con un’altra domanda, più esauriente e significativa di qualsiasi altra possibile risposta: “Tu forse non mangi tutti i giorni?”.
Queste parole mi sono rimaste in mente, le ho lasciate decantare nel mio animo come un succo ricco di sostanze che si cerca di ricavare da frutti la cui bellezza esteriore lascia solo presagire l’importanza dei segreti racchiusi nella polpa, un complesso barocco e ricco di idee ma forse scomodo da riportare alla luce della nostra coscienza. E infatti la mia coscienza si fermò, stanca di pensare. Si accontentò di avere ben presente solo una conclusione come questa: leggere serve, serve tantissimo per comprendere noi stessi, il mondo che ci circonda e il modo di pensare di noi stessi e delle persone che incontriamo nella nostra vita. Ma il modo con cui ciò potesse avvenire non mi era chiaro. Lo sentivo scomodo da indagare, pericoloso da capire.
Poi mi ritornò in mente Martin Eden. La storia è ben nota. Martin è un ragazzo volenteroso. Ha lavorato sui bastimenti in giro per i mari di tutto il mondo. Conosce Ruth, una ragazza della quale s’innamora. Molte cose li dividono. L’estrazione sociale e soprattutto una generale rozzezza di Martin che non ha studiato, si esprime male, conosce poco la sua lingua madre. Ruth cerca di aiutarlo, gli insegna alcuni comportamenti da assumere in società, durante le cene. Gli insegna persino ad esprimersi correttamente.
Martin fa mille sacrifici. Si dedica a lavori umilissimi con turni massacranti e paghe da fame. La notte, a costo di rinunciare al sonno, legge e studia continuamente. I primi libri di filosofia, i grandi saggi di letteratura sono difficili. Non li comprende bene. Ma si batte. Non cede alle fatiche, ad ostacoli all’apparenza insormontabili. Ha sempre in mente Ruth. Per lei vuol diventare uno scrittore, un grande scrittore. Guadagnare tanti soldi e far vedere quanto vale alla famiglia di Ruth, al marito di sua sorella che lo considera un fallito senza speranza, al mondo che lo circonda.
Un uomo che legge, riflette, comprende, pensa e scrive. E scrive tanto, Martin. Racconti, saggi, novelle. Manda i suoi scritti a riviste che a quanto gli hanno raccontato dovrebbero pagare un tanto a parola. È fiducioso. Convinto di potercela fare. Calcola con accurata attenzione quanto può fruttargli un racconto di quindicimila parole o una poesia di quaranta versi. Ma nessuno accetta di pubblicare i suoi racconti. Li respingono, li mandano indietro. Quando qualche rivista alla fine accetta di pubblicargli qualcosa, dopo che ha lavorato per comprare i francobolli e spedire un po’ in tutti gli Stati Uniti, non viene pagato. Gli editori non rispettano gli accordi e le promesse.
A un certo punto Martin conosce un certo Brissenden, uno strano personaggio di grande cultura e sensibilità che vive quasi ai margini della società. La sua casa è una povera stanza di una locanda in un quartiere di secondo ordine. Anche Brissenden scrive. Le sue poesie, le sue opere sembrano a Martin straordinari capolavori. Brissenden diffida delle riviste, degli editori. Vuol far capire a Martin che il più grande valore della scrittura si risolve nello scrivere per se stessi.
Martin continua a scrivere e a inviare racconti alle riviste, agli editori. E spedisce anche un’opera di Brissenden. Qualche tempo dopo una rivista importante comunica a Martin che lo scritto di Brissenden verrà pubblicato e pagato. È considerato un capolavoro. Martin corre a cercare l’amico per comunicargli la felice notizia. È troppo tardi. Brissenden si è sparato un colpo alla testa.
Questa tragedia lo colpisce immensamente. Sembra sentire che nella fine dell’amico è racchiusa una lezione immensa che per il momento riesce solo a presagire con l’animo.
Continua a scrivere e invia nuovamente anche gli scritti che gli erano stati sempre rifiutati.
Da quel momento i suoi stessi racconti che poco tempo prima venivano bocciati da tutti, vengono accolti anche dagli stessi editori che li rifiutavano, come straordinarie creazioni. Vengono pubblicati e pagati.
Per Martin è un trionfo. Scrive il suo creatore, Jack London: “Non c’era alcuna spiegazione a questo improvviso pubblicare i suoi lavori. Non era altro che uno scherzo del destino”.
Tutto cambia intorno a lui. La famiglia della ragazza che ama gli concede di sposarlo. Il marito di sua sorella che lo aveva considerato sempre un fallito lo accoglie come un genio. Viene invitato alle serate più esclusive. I personaggi più importanti della città che lo avevano sempre ignorato e che avevano giudicato i suoi scritti privi di valori, adesso gli offrono di fare conferenze e lo ascoltano come un grande maestro? Perché? Si chiede Martin. Perché? Il suo valore non è cambiato. Le cose per cui adesso viene osannato le aveva scritte anche quando tutti lo respingevano. Perché? Se nulla era cambiato in lui come poteva essere considerato dagli altri in modo così diverso? In questa incertezza immensa che sembra averlo ferito dentro riesce a trovare un sollievo umano facendo visita alle persone semplici che frequentava una volta. Scrive in proposito ancora il suo creatore: “Tutti erano contenti del ritorno di Martin. Per loro non aveva pubblicato alcun libro e non vedevano alcuna aggiunta di valori fittizi in lui”.
Martin è cambiato. Qualcosa lo ha ucciso nell’animo. Non sente più la tensione che prima lo spingeva ad affrontare ogni difficoltà, a combattere per i suoi sogni.
Con disillusione spiega a Ruth, che improvvisamente e con entusiasmo si era riavvicinata a lui, che non vuole più sposarla.
Durante un viaggio su una nave di lusso, una notte si lascia scivolare in mare. E sotto la luna, nel freddo dell’acqua gli sembra di capire, forse riesce a scoprire tutto. Forse riesce a capire, a sapere o almeno intuire i dettagli del mistero racchiuso nella morte di Brissenden, il significato del suo ultimo gesto.
Conclude il suo creatore: “E nell’istante stesso in cui lo seppe cessò di saperlo”.
A me è capitato molte volte di parlare con amici e conoscenti di uomini considerati dei falliti, e perciò respinti un po’ da tutti, che quasi all’improvviso hanno visto riconoscere il valore del loro lavoro, delle loro creazioni, della loro attività. Perché la loro considerazione da parte degli altri è cambiata? Quegli uomini da tempo avevano scritto, pensato, elaborato le loro idee. Perché se non sono cambiati, se non è cambiato il loro valore, il loro modo di essere considerati da parte degli altri si è così modificato? Ebbene la risposta di quasi tutti i miei interlocutori è sempre la stessa: “Ma è ovvio, hanno avuto successo!”.
Questa risposta appare come qualcosa di naturale, di evidente, soprattutto nella società in cui viviamo, ma, a mio parere, nasconde qualcosa di terribile. Mi spiego meglio.
Se la risposta dei miei amici, “Ma è ovvio, hanno avuto successo!”, la consideriamo come una frase che descrive un rapporto di causa ed effetto in una certa situazione, allora posso accettarla. Così frasi del tipo: “Vengo cercato da tutti perché ho successo”, “ La mela cade perché c’è la forza di gravità”, “La lampada si accende perché c’è la corrente” hanno tutte lo stesso valore. Unicamente descrittivo.
Ma l’impressione è che nella frase “ Ma è ovvio, hanno avuto successo!” sia nascosta una enorme presunzione sul piano epistemologico, cioè relativamente alle modalità e ai principi della conoscenza.

Infine, secondo me la frase, “Ma è ovvio, hanno avuto successo!”, si spinge oltre perché sembra proprio che in chi la pronuncia ci sia una più o meno inconsapevole, espressione di validità ontologica, cioè relativa ad una condizione del mondo che non è modificabile e dunque nemmeno discutibile. Il mondo è questo. Punto e basta. In quelle parole si nasconde una enorme presunzione che consiste nel far coincidere l’apparente ovvietà di un meccanismo consolidato in una certa società, in un certo e ben definito contesto sociale, con una condizione dell’esistenza umana necessaria e solo da accettare con passività, eventualmente solo da riconoscere con fatalismo. Dobbiamo riconoscere che questa presunzione ontologica è il primo e terribile ostacolo prodotto da coloro che la presuppongono ad ogni possibile cambiamento della società in cui viviamo.
Il povero Martin comprende bene perché è ricercato da tutti dopo il suo successo come scrittore. Non è certo stupido. Comprende il valore descrittivo del rapporto di causa ed effetto tra il suo successo e l’improvvisa considerazione per lui da parte di coloro che solo poco prima lo dichiaravano un inetto.
Ma quando si rende conto che intorno a lui, Ruth e la sua famiglia, il cognato, molti personaggi della bella società, quasi tutti insomma, cambiano il suo giudizio non in base ad una reale conoscenza di Martin in quanto uomo ma in base al successo di facciata da lui avuto, allora gli risulta chiarissimo che queste degne persone hanno solo cambiato il loro giudizio ma non il loro modo di pensare, il criterio per giungere ad un giudizio. È il fallimento epistemologico della società in cui vive.
Quando poi percepisce che quella loro vita sembra ovvia a tutti, che quei comportamenti falsi sono visti come qualcosa di implicitamente naturale, allora si sente perso. È il fallimento ontologico della società in cui vive.
Erano falsi quando lo consideravano un inetto senza conoscerlo. Sono ancora più falsi adesso che lo osannano continuando a non conoscerlo, dopo il suo successo.
Scoraggiato decide di seguire la sorte di Brissenden.
Proviamo a pensare a quanto sarebbe più facile cambiare la società in cui viviamo se diventasse naturale per tutti distinguere i tre piani di riflessione, così meravigliosamente rappresentati da Jack London.
E poi qualcuno dice che la letteratura non serve!
Adesso smetto di scrivere. Devo fare una cosa. Non credo che interessi a nessuno che cosa esattamente. Ma in caso contrario non ci sarebbe forse bisogno di dirlo. Vado a mangiare! È ovvio! Lo faccio tutti i giorni.