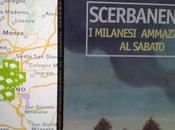In quella sera di maggio, nella sua stanza da letto, nella notte infinita come l’angoscia, lei è sola, completamente sola, ed ha paura. Le manca il respiro e implora il suo cuore perché smetta di battere così forte. Sgrana infiniti perché senza risposta e il tempo che scorre lento su un rosario di dolore, nel tentativo di dominare la paura e pensare. I ricordi. Ecco, ripercorrere i ricordi da quel tempo lontano in cui è stata felice, quando era solo una bambina, Domenica si chiamava – il suo nome, allora, non faceva paura – , e con le sue tre sorelle godeva del mare e del sole che scaldava anche l’anima nel suo paese, giù in Calabria. Fino a che le prime ombre erano giunte a turbare la sua gioia di vivere e, brutali, le avevano insegnato l’abbandono e l’insicurezza, quando suo padre, quell’uomo forte che amava i libri, aveva lasciato sole le sue donne ed era andato via. Poi era arrivata la musica a salvarla, e lei aveva scoperto che la sua voce era capace di sollevarla sulle sue fragilità. Era diventata forte allora, e quella bambina spaventata e incerta che voleva cercare la libertà in Amazzonia era diventata una donna che sapeva cosa voleva dalla vita. ”Io volevo solo cantare. Riempire il vuoto con le parole e con la musica.” E lei sapeva farlo bene, meglio di tutti, perché sapeva commuovere e toccare le corde del cuore. Lei ora è Mimì, in tanti le vogliono bene ma la sua fame d’amore non si appaga. Ha successo e uno come Charles Aznavour, dopo due anni, la vorrebbe con sé ancora in tournée. Ma l’invidia è una brutta cosa e sa farsi subdola e strisciare viscida, insinuandosi lenta proprio nell’ambiente in cui lavora. Suo padre, da bambina, le aveva insegnato quella parola greca che è un peccato terribile, la hybris, il peccato di chi è bravo e vuole andare oltre, terribile perché scatena l’invidia degli dei. Ma gli dei non esistono, e tuttavia c’è la gente che è capace di fare non meno male. E il caso, poi, sa essere cattivo quanto la gente, quando comincia ad inanellare episodi stupidi a vicende tragiche. Lei, Mimì, non ha colpa, ovviamente, ma diventa “quella lì”, quella il cui nome fa paura, è impronunciabile, perché fa accadere brutte cose. Perché dicono questa cosa terribile, che cresce, cresce come una valanga? “Come se si rispondesse a una fame antica. La fame di scaricare altrove i propri problemi o di trovare una soluzione all’incomprensibilità della vita.” Ora anche lei ha paura di quel nome, lei che adesso è sola in quella stanza con la sua sofferenza, lei che sa che dovrebbe chiamare qualcuno ma non ce la fa, lei che, rannicchiata su se stessa, cerca di smettere di pensare perché le fa troppo male, cerca di dormire, respirare e dormire. Per riposare, finalmente. “Adesso non c’è più poesia.”
In quella sera di maggio, nella sua stanza da letto, nella notte infinita come l’angoscia, lei è sola, completamente sola, ed ha paura. Le manca il respiro e implora il suo cuore perché smetta di battere così forte. Sgrana infiniti perché senza risposta e il tempo che scorre lento su un rosario di dolore, nel tentativo di dominare la paura e pensare. I ricordi. Ecco, ripercorrere i ricordi da quel tempo lontano in cui è stata felice, quando era solo una bambina, Domenica si chiamava – il suo nome, allora, non faceva paura – , e con le sue tre sorelle godeva del mare e del sole che scaldava anche l’anima nel suo paese, giù in Calabria. Fino a che le prime ombre erano giunte a turbare la sua gioia di vivere e, brutali, le avevano insegnato l’abbandono e l’insicurezza, quando suo padre, quell’uomo forte che amava i libri, aveva lasciato sole le sue donne ed era andato via. Poi era arrivata la musica a salvarla, e lei aveva scoperto che la sua voce era capace di sollevarla sulle sue fragilità. Era diventata forte allora, e quella bambina spaventata e incerta che voleva cercare la libertà in Amazzonia era diventata una donna che sapeva cosa voleva dalla vita. ”Io volevo solo cantare. Riempire il vuoto con le parole e con la musica.” E lei sapeva farlo bene, meglio di tutti, perché sapeva commuovere e toccare le corde del cuore. Lei ora è Mimì, in tanti le vogliono bene ma la sua fame d’amore non si appaga. Ha successo e uno come Charles Aznavour, dopo due anni, la vorrebbe con sé ancora in tournée. Ma l’invidia è una brutta cosa e sa farsi subdola e strisciare viscida, insinuandosi lenta proprio nell’ambiente in cui lavora. Suo padre, da bambina, le aveva insegnato quella parola greca che è un peccato terribile, la hybris, il peccato di chi è bravo e vuole andare oltre, terribile perché scatena l’invidia degli dei. Ma gli dei non esistono, e tuttavia c’è la gente che è capace di fare non meno male. E il caso, poi, sa essere cattivo quanto la gente, quando comincia ad inanellare episodi stupidi a vicende tragiche. Lei, Mimì, non ha colpa, ovviamente, ma diventa “quella lì”, quella il cui nome fa paura, è impronunciabile, perché fa accadere brutte cose. Perché dicono questa cosa terribile, che cresce, cresce come una valanga? “Come se si rispondesse a una fame antica. La fame di scaricare altrove i propri problemi o di trovare una soluzione all’incomprensibilità della vita.” Ora anche lei ha paura di quel nome, lei che adesso è sola in quella stanza con la sua sofferenza, lei che sa che dovrebbe chiamare qualcuno ma non ce la fa, lei che, rannicchiata su se stessa, cerca di smettere di pensare perché le fa troppo male, cerca di dormire, respirare e dormire. Per riposare, finalmente. “Adesso non c’è più poesia.”
Il 12 maggio 1995 muore, in circostanze dubbie, Mia Martini, una della voci più straordinarie del panorama musicale italiano. L’autopsia parlò, all’epoca, di una overdose di medicinali. Mimì era stata sempre una donna apparentemente forte e piena di gioia di vivere ma mai aveva sanato la ferita causata dall’abbandono paterno; aveva sempre portato nel cuore il sole della sua terra e quando cantava era capace di trascinare chiunque l’ascoltasse nel mondo meraviglioso creato dalla sua voce. Tormentata ma entusiasta è stata capace di cadere e risollevarsi più volte, di superare tanti momenti critici nella sua vita artistica e privata, rialzandosi ogni volta più forte e più coraggiosa di prima. Ma tutti abbiamo un limite oltre il quale non si riesce a sopportare, oltre il quale è difficile prendere altri schiaffi. Mimì donava l’amore di cui era capace attraverso la sua musica, ma aveva bisogno di riceverne altrettanto. Ed invece, soprattutto il suo mondo, quel mondo dello spettacolo così legato alla superstizione, per invidia ha ripagato la sua generosità di donna e di artista con la subdola e infida maldicenza, affibbiandole la nomea di iettatrice. Una cosa assurda, che farebbe anche sorridere, se non fosse che la paura e la cattiveria si autoalimentano e sanno diventare pericolose, molto pericolose. Fino a spegnere il sole dentro, e poi a distruggere la vita.
Aldo Nove, scrittore e poeta di successo, racconta le ultime ore di Mimì, immaginandola sola, a parlare – come Archiloco più di duemila anni fa – col suo cuore impazzito, con i ricordi felici, con quelli terribili. Alle prese con perché senza risposta, a tentare di non avere freddo, a fingere di dimenticare il buio. Ma “È notte dappertutto.”
Il ritmo sincopato, la prosa lirica asciutta e paratattica, destinata alla descrizione di quelle ultime ore, danno il senso del tempo del cuore accelerato e quello del respiro spezzato di chi sente l’angoscia premere sul petto. Questi momenti si inframmezzano al racconto dei ricordi, nella ricostruzione dolente di una biografia fatta di luci ed ombre, racconto che ha altro linguaggio, quasi fanciullo nella sua spiazzante semplicità. È un pugno allo stomaco doloroso leggere questo libro, significa immaginarsi nella sofferenza generata dalla cattiveria e dalla stupidità, significa cum-patire, sentire insieme, e stare male con Mimì. Un libro, dunque, per chi l’ha amata e ancora la ama, perché magari lei forse può ancora sentirlo quell’amore di cui si nutriva e che in vita non le è bastato. Ma un libro anche per conoscere un aspetto ulteriore della mediocrità umana, della piccineria italica che ha preferito mostrarsi ignorante e abbandonarsi ad un retaggio assurdo come la superstizione, piuttosto che riconoscere la bravura altrui. Un libro, infine, per chi ha conosciuto notti come quella immaginata da Aldo Nove, “la lunga notte dell’anima” per dirla con San Giovanni della Croce, ma senza l’incontro finale e consolatorio con la luce, le notti di chi ha conosciuto il dolore che fa paura, o la paura che fa male. Che è la stessa, terribile, cosa.
Aldo Nove, Mi chiamo…, Skira, Milano, 2013.
(Alessandra Farinola)