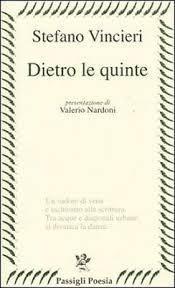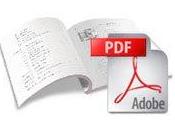Gobba a levante è l’ultimo libro di poesie, in ordine di tempo, di Nicola Romano. Una raccolta in cui i testi si sfrondano quasi all’essenziale, il lessico si fa liquido e scorrevole, elegante nella proposizione proprio per quel raro concedersi alla parola inusuale spesso utilizzata nelle precedenti raccolte. Anche nella misura metrica si avverte una mutazione: l’endecasillabo, verso principe nella poesia del Nostro, non è più esplicitato quasi pedissequamente, ma ha acquistato la naturale abilità di virare verso un andamento più libero grazie all’associazione con quinari e settenari e all’uso dello jambement. Poesia della maturità, che diviene pensosa, greve del vissuto, quello gioioso e quello dolente, ma anche quello meditativo e quello spirituale. Il linguaggio è diretto, privo di orpelli e sostenuto da una scelta lessicale raramente esornativa. Gobba a levante è il quotidiano che si fa poesia umbratile e assorta.
Se nella nota introduttiva alla raccolta Paolo Ruffilli parla di “mitologia del quotidiano”, io oso affermare che Nicola Romano in queste poesie ha delineato una sorta di mitografia personale, un disegno entro il quale il vissuto dell’autore e quello della realtà sociale che lo circonda generano una verità mitopoietica, quella del tempo in cui viviamo, quella che produce i miti correlati alla realtà attuale: l’ambizione, l’ingiustizia, il catastrofismo, la sovraesposizione mediatica. Un “mare magnum /che già promette buche e spaesamenti/col primo notiziario delle sette”, come denuncia il poeta ne Il lamento del giusto. Occorre dunque aspettare per trovare “le chiavi/ per aprire quei cuori serrati”, ma l’attesa è dura per chi “attende risposte in sintonia/con i percorsi azzurri del suo cielo” e allora è necessario tenersi la chiave di quella stanza “dove matura anima e pensiero”, la stanza della poesia.
Gobba a levante, luna calante, recita un detto popolare. E nella metafora assunta da Romano a titolo della raccolta è iscritto il cammino esistenziale che inizia con un raggio di sole frantumato sulla pelle come “un dolore antico/che concupisce/e prende da lontano” e che continua nell’incertezza di “aver compreso i segni del viaggio”. Siamo al centro dell’avventura umana, nel tempo dei bilanci, nel luogo in cui “non si disvela/l’esatta dimensione del presente”, nel silenzio delle parole perdute “nel secchio oscuro delle incomprensioni”. Ma l’artista non si adatta al disagio dell’esistenza, attinge all’immaginario collettivo per lasciare affiorare la sua energia creatrice e generare la suggestione, l’emozione che scava e fa emergere la forza che risana. In questo quotidiano andare si alternano le due fasi cardinali dell’esistenza: il buio e la luce, la rotazione vitale che il poeta sostanzia con la scelta di termini contrapposti: il sole e la luna, l’alba e l’oscurità, “sciabole di luce e annottamenti”. La luna è presenza costante nel dettato lirico di Romano, ma anche nella sua simbologia notturna il poeta non legge presagi di oscurità perenne, intravede piuttosto il riposo, la saggezza della pausa che prelude alla nuova fase. La luna è la Dea Madre e si correla alla fertilità, all’amore, alla donna, è la Dea Triplice, archetipo femminile nelle tre declinazioni di giovane-madre-vecchia: nascita, equilibrio e riposo.
Ed il tema nodale di questa raccolta è la sostanziale presa di coscienza dell’inevitabile percorso a cui siamo assoggettati; in questo senso il discorso poetico di Romano si fa universale. “Come chiamare vita questa vita/che impassibile volge e si consuma/col tempo di una bolla sopra il lago”. E’ l’aporia, l’impossibile risoluzione di un dubbio espressa attraverso il traslato poetico. Nel turbine dello spaesamento di fronte all’irrisolvibilità della problematica esistenziale il poeta trova la sua maniera di adattarsi: “Disponiamoci adesso a nuovi giorni/coi nostri pochi sogni a buon mercato”. Ma non è della poesia risolvere le querelles filosofiche, semmai lo è porvisi di fronte e indagarne le questioni con onestà, chiedersi sommessamente, con pudore “Chissà chi lascerà maggiore segno/se l’assorto viandante per quartieri/o queste pietre cariche di tempo”. Il tratto più importante del percorso umano è stato superato, i germogli sono ormai frutti, le rondini hanno lasciato il nido per cercare il proprio cielo, ma “abbracciati al mondo che rimane” c’è ancora tempo per aspettare nuove lune, per esplorare altri luoghi “a dispetto degli anni scartocciati nel taschino”. Rari sono i luoghi in cui resistere, scrisse Zanzotto, uno è quello della poesia.
Anna Maria Bonfiglio