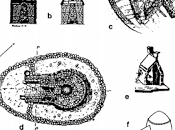Sono sempre stati due i solchi della poesia di Antonella Anedda: cronaca personale – come era evidente nel suo primo libro, Residenze invernali – e Storia, come stabiliscono le sue Notti di pace occidentale. Tra questi due estremi, con la sola eccezione di Dal balcone del corpo, si è sempre posata la voce della Anedda. Una voce estremamente descrittiva, compatta, come scolpita nel marmo. Non a caso per lo stile della Anedda è stato usato l’aggettivo “epico”, è stato tirato il nome di Omero. Una voce capace anche di accensioni liriche, di improvvisi scarti.
Sono sempre stati due i solchi della poesia di Antonella Anedda: cronaca personale – come era evidente nel suo primo libro, Residenze invernali – e Storia, come stabiliscono le sue Notti di pace occidentale. Tra questi due estremi, con la sola eccezione di Dal balcone del corpo, si è sempre posata la voce della Anedda. Una voce estremamente descrittiva, compatta, come scolpita nel marmo. Non a caso per lo stile della Anedda è stato usato l’aggettivo “epico”, è stato tirato il nome di Omero. Una voce capace anche di accensioni liriche, di improvvisi scarti.
In trent’anni di scrittura la poesia della Anedda ha abitato nella Storia: “Anche questi sono versi di guerra / composti mentre infuria, non lontano, non vicino” (da Notti di pace occidentale), e nella cronaca personale: “Luci d’inverno. / Nella sala degli infermieri luccicano carte di stagnola / l’odore del vino sale nell’aria” (da Residenze invernali, con forse un riferimento chissà quanto involontario a un film di Bergman). E questi due piani non si sono mai confusi, non c’è stato alcun tentativo da parte della Anedda di diventare personaggio della Storia che raccontava, o di usare la Storia come fondale del proprio vissuto, della propria espressione personale. La voce di questa poetessa ha sempre cercato il profilo di una testimonianza.
Un terzo solco infine è possibile indicare: la letteratura, la possibilità di scrivere sistematicamente, volontariamente, attraverso testi di altri autori usati come lievito, miccia, per nuovi testi. Il Catalogo della gioia era su questo solco, più sottile e frastagliato.
In Salva con nome qualcosa cambia, sembra prodursi uno scarto. Lo stesso titolo – che richiama il comando con cui il pc mette in memoria un documento appena creato o modificato – ha qualcosa di ironico. Un’ironia per niente allegra, che pare essere una vera e propria presa di distacco. Un distacco determinato non dal disincanto quanto dalla stanchezza, dal bisogno di aderire alla propria quotidianità, allontanandosi.
Che la Storia sia lontana (oppure: che la Storia sia stata allontanata), lo si capisce dalla seconda prosa della raccolta, Senza nome. Sartiglia, che segue un brevissimo scritto nel quale la Anedda dichiara di non volere più nome. In Senza nome. Sartiglia si legge una dichiarazione ancora più forte: la necessità di limare ogni tratto della propria identità fisica. Diventare allora solo corpo, anonimo, pura funzione. Già, ma quale funzione? Quale azione almeno? Cucire.
E Cucire è il nome della sezione più significativa dell’intera raccolta. È in queste pagine che si legge della volontà che dà forma al libro: “Cuci una federa per ogni ricordo, mettili a dormire, / dai loro il sonno di un lenzuolo di lino”.
La Anedda ha dato sempre prova della sua capacità narrativa, e non è un caso che spesso i suoi versi cerchino di sfondare verso la prosa lirica, o meglio verso la prosa ritmica. Dopo trent’anni di scrittura, la Anedda è però arrivata all’auto da fè, “La casa è l’architetto del suo panico / ogni stanza la geometria dello spavento / ogni mattone compone un alfabeto di rovina”, ha obliterato l’epicità, “Staccatemi dal tempo voi che siete già morti / perché non c’è più spazio”. Salva con nome è un romanzo di formazione cui è stato posto il segno meno. Il movimento del distacco porta a una cronaca annichilita. Non si riesce a leggere diversamente la seconda parte della sezione Cucire (per riportare due soli versi di grado zero, ai limiti della sciatteria: “Le minime di abbasseranno, / sarà più freddo della media stagionale).
Che qualcosa si sia rotto e che la frantumazione della memoria individuale siano definitive viene registrato nella poesia che apre l’ultima sezione della raccolta, Terra: “Se devo scrivere poesie ora che invecchio / voglio vederle scorrere, perdersi in altri corpi / [...] / mentre preparo un brodo con gli occhiali offuscati / appunto un verso su un foglio e a volte mi ferisco/scambiando la penna col coltello”.
Questa è la chiave di volta. E solo con questi versi si capisce la ragione per cui Salva con nome non possa essere definita una raccolta di poesie, non in senso stretto almeno, ma sia una raccolta di documenti che comprende anche delle fotografie (di volti senza nome, di nuovo). Non è un caso che i testi migliori, più nitidi e chiari nella loro referenzialità, nella dizione bassa, siano dei brevissimi racconti. Lontani dal lessico lirico, che pure si affaccia spesso tra i versi, e distanti anche dal ritmo della prosa lirica cui la Anedda ci aveva abituati.
Salva con nome segue dopo cinque anni Dal balcone del corpo, e in una certa misura ne è la naturale continuazione. Nella raccolta del 2007 si era raggiunta una soglia, una misura incredibilmente equilibrata tra le spinte della storia individuale e le urgenze della Storia. I molti Cori che puntellavano la struttura narrativa di Dal balcone del corpo (“Lascia che dicano: noi”) si sono quasi completamente ritratti in Salva con nome, e hanno lasciato spazio a narrazioni adespote, a una cronaca diffusa di luoghi: la Sardegna, certo, poi Vallesana, e di nuovo l’isola, l’idea dell’isola, attraverso l’ultima prosa, l’ultimo breve racconto per immagini, Visi. Collages. Isola della Maddalena.
E proprio nell’ultima prosa compare una seconda parola chiave: collages. La Anedda sembra essersi investita il ruolo, quasi crepuscolare, di estensore di cronache. Come se non volesse più indagare le radici della propria storia (“Lasciami libera da me – di cui conosco i nomi/e le separazioni) e avesse ora solo un calmo bisogno di tratteggiarne i contorni, come se fosse possibile solo questa sovrapposizione (senza ulteriore significazione) per poi accostarli. “Il loro, il nostro nome sarà spazzato via tra poco? // Soffiati via, poi ritagliati soltanto nelle foto”.