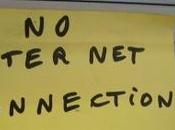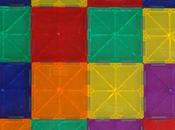Dove.
Potrebbe essere Praga, oppure Dublino. Forse meglio la mitteleuropa, dove molte più storie sono possibili. L’importante è che suggerisca qualcosa di indefinito, di appena un po’ flou, affinché il languore di immaginare i contorni faccia il resto del lavoro. E io immagino una città vecchiotta e un po’ statica, di quelle che faticano a cambiare, a sgranchirsi dalla loro Storia – o non hanno nessuna propensione a farlo. Un dove che sia a suo agio con la nebbia o le serate piovose tra lampioni stanchi, piazze in cui ci si può perdere, viuzze lastricate, vetrine di artigiani che lavorano fino a tardi alla luce gialla di lampadine impolverate, fermate d’autobus con donne cariche di involti, mendicanti agli angoli di palazzi dove un tempo ambasciatori e aristocratici davano le loro cene di gala, i loro balli in maschera. Mettiamoci incerti riflessi danzanti sull’acqua di un fiume, e chiamiamo questo fiume Moldava.
Quando.
In tempo di guerra, però in un momento in cui la guerra stagna un po’, bloccata sui tanti fronti dai pantani dell’inverno, e nelle città si sta a spalle incassate, vivendo un limbo irreale. Oppure – anzi meglio – nell’ultimo periodo di un anteguerra in cui si sta in attesa di una catastrofe che cambierà la vita per sempre, e mai come in quei momenti la stessa vita sembra più precaria e più assurda, tutta da vivere con spavalda disperazione. Un novembre avanzato, perché ottobre sarebbe troppo colorato dalle foglie dei grandi alberi dei parchi, e dicembre troppo inquinato dalla finta allegria di un Natale di guerra. Novembre va bene perché è più ravvolto su se stesso e i suoi grigiori; più interminabile e più avaro.
Chi.
Un uomo. Una donna. Prima l’uomo, però, perché deve essere lui il personaggio centrale. Lo è perché sa portare bene la nebbia, come fosse l’unica cornice possibile al suo andare a lunghi passi nel cappotto liso, dietro occhiali cerchiati in oro (montatura vecchia, datata tempi migliori), una borsa da medico appesa alla mano, l’altra in tasca, la testa bassa, dentro i pensieri e la scarsa voglia di salutare chi incontra. Facciamo di lui un eroe in ombra, facciamone non un ebreo – che sarebbe approfittare della retorica – ma un medico caduto in disgrazia per motivi politici e costretto a vivere di poco esercitando in un desolato ospedale per poveri (è già abbastanza retorico così). E chiamiamolo Stefàn, un nome che si addice alla sua indole gentile, alla sua malinconica tenacia, alla sua dignitosa infelicità.
Lei è una ragazza. La sua funzione è quella di amare Stefàn, perché un uomo così non può non essere amato da una donna altrettanto gentile e schiva, tenace e infelice. Non ha un nome, non mi viene; mi immedesimerei troppo, e l’ho già fatto assegnandole un lavoro oscuro da bibliotecaria. Abituata a toni di voce sommessi, ad atmosfere mistiche, alle strettezze, al cappotto pesante che punge senza scaldare. Per questi motivi è evidente che avrei potuto farne anche una violinista o una violoncellista, sarebbe stato altrettanto plausibile, e forse ancora più romantico.
Che si incontrino una sera di nebbia, di quelle che non si vede a un passo. Che si innamorino (ma perdutamente, è essenziale) sul portone di quella biblioteca all’ora di chiusura. Che si rifugino in due stanzette spoglie, con il rubinetto che gocciola e la portinaia malevola che li spia. Che resistano ai controlli di polizia, agli arresti preventivi, al confino, alle umiliazioni. Che riescano a ritrovarsi ogni volta che è possibile per ascoltare abbracciati qualcosa di Chopin o di Edith Piaf alla radio, molto sottovoce, scambiandosi sogni impossibili come quello di vivere sotto il sole di un’isoletta del Mediterraneo, coltivando olivi, allevando capre.
Basta, ho detto fin troppo. Adesso abbiamo una città, Praga, una data, novembre 1939, una coppia di rinnegati, nebbia quanto basta per nascondere il non detto ma non tanto che non si possa, volendo, portarlo alla luce. Come andrà a finire, non lo so. Io mi fermo qui, metto in tavola. Voi, servitevi pure.