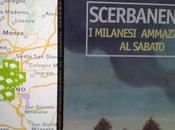Esce oggi Piccone di Stato – Francesco Cossiga e i segreti della Repubblica (collana Igloo, Nutrimenti Editore) ed ecco dunque di seguito le righe che introducono la narrazione.
Esce oggi Piccone di Stato – Francesco Cossiga e i segreti della Repubblica (collana Igloo, Nutrimenti Editore) ed ecco dunque di seguito le righe che introducono la narrazione.
Doveva succedere. Perché è sempre così che accade, dopo. Dopo il cordoglio, dopo la tumulazione, dopo l’esaurimento dello spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Doveva succedere che gli irriducibili, coloro che non dimenticavano gli anni bui della strategia della tensione, ricorressero alla rodata arte del tazebao e lo scrivessero sui muri che, per loro, Francesco Cossiga era stato e rimaneva il ‘Kossiga’ in versione nazistoide dei tempi di Francesco Lorusso e Giorgiana Masi. Così, in barba a qualsiasi buonismo post mortem – e anche all’imposta comunale sulle pubbliche affissioni – gli animatori di un centro sociale di Cremona erano stati denunciati per “vari reati, amministrativi come penali” dai lavoratori pensionati europei. Che ci pensasse l’autorità giudiziaria a trovare la punizione adatta e, se non lo avesse fatto, sarebbe stata a propria volta accusata di omissione d’atti d’ufficio.
Ma c’era anche chi, più celebrativo, non dimenticava nemmeno che il trofeo ‘Presidente della Repubblica di Vela Latina’, giunto a fine estate 2010 alla ventottesima edizione, venne assegnato per la prima volta nel 1982 sempre da lui, l’allora dimissionato presidente del Consiglio dei ministri, in panchina dopo la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e il caso Donat Cattin e in attesa del soglio senatoriale, seguito a ruota da quello quirinalizio. E così, dunque, che non si perdesse tempo e alla cerimonia di premiazione si dedicasse al suo celebre padrino – il Francesco Cossiga compito e istituzionale – l’edizione corrente.
Due estremi, questi, per iniziare a raccontare un uomo e un politico di non facile decifrazione. Un personaggio che tra i suoi soprammobili teneva una cazzuolina d’argento a ribadire le mai celate simpatie massoniche. E che nella vita, se non avesse scelto la carriera nelle stanze dei bottoni, avrebbe voluto fare il direttore d’orchestra (”ma dopo tutto devo dire [che] tra fare musica a certi livelli e governare un paese, cosa che ho fatto, non c’è poi tutta questa gran differenza”). Oppure il gesuita, se non fosse stato per il padre Giuseppe, anticlericale, che lo richiamò in Sardegna nel periodo in cui il giovane Francesco studiava a Milano, all’Università cattolica del Sacro Cuore.
Di sé, Francesco Maurizio Cossiga, nato a Sassari il 26 luglio 1928, aveva fatto parlare molto trasformandosi in un personaggio quasi folcloristico. Aveva fatto parlare delle ciabatte a fiori mostrate al ‘collega’ Ferdinando Adornato e delle sue fughe irlandesi sulla scia delle bevute di James Joyce. Della statua di Pinocchio in legno e di un originale Babbo Natale bianco vestito, in opposizione al mito introdotto dalla coca-cola che l’aveva ritratto – consacrandolo a livello mondiale – in panni rossi. Delle librerie della sua abitazione romana anni Venti, che si trovava al civico 77 di via Ennio Quirino Visconti, nel cuore del quartiere Prati. Librerie quanto mai variegate, che contenevano testi sulla massoneria e sul diritto costituzionale, ma anche i thriller di John Le Carré, di Frederick Forsyth e di un più autoctono comico prestato alla narrativa di genere, come Giorgio Faletti. Cossiga mostrava con orgoglio il suo cane-robot, battezzato con il nome di Aibo, e i trenta telefoni cellulari con personale rete di cifratura per evitare intercettazioni.
Ogni tanto accennava al difficile matrimonio con Giuseppa Sigurani, sassarese anche lei, da cui aveva avuto due figli (Anna Maria, nata nel 1961, e Giuseppe, del 1963) e da cui aveva divorziato nel 1998 per ottenere, da cattolico osservante, l’annullamento alla Sacra Rota nel 2005. Ma estemporaneamente gli era capitato di rispolverare il ricordo degli amori giovanili, a iniziare dall’austriaca Erika, con la quale però si limitò a recitare il rosario in una chiesa di Vienna facendosela poi soffiare da un di lei connazionale. E poi tornava spesso anche sulla sua passione per le parole diffuse via etere, che da radioamatore lo portarono a diventare conduttore (o, come diceva lui, “lanciatore di dischi”) sulle frequenze di Radio due, con lo pseudonimo ammiccante di Deejay K, creazione del giornalista Claudio Sabelli Fioretti.
In tasca conservava una tessera da giornalista pubblicista rilasciatagli dall’Ordine del Lazio e del Molise, frutto di una collaborazione con il quotidiano Il Riformista, e non nascondeva la propria civetteria nell’ammettere di essere uno degli uomini che “meglio conosce la mappa del potere in Italia”, per quanto “non sono l’uomo più potente d’Italia”. La sua carriera politica, iniziata a Sassari nella Fuci (la Federazione universitaria cattolica italiana) e poi decollata quando ancora militava nei ranghi dei ‘giovani turchi’ (rampante generazione di democristiani che intendeva soppiantare i più attempati rappresentanti locali), proseguì riuscendo nell’intento di scalzare il vecchio establishment democristiano per occupare gli antri del potere politico ed economico dell’isola.
Dopodiché fu una continua ascesa. Un’ascesa che comprese le cariche di deputato (dal 1958) e senatore (nel 1983), sottosegretario alla Difesa con delega per l’Arma dei carabinieri e la Sovrintendenza dei servizi segreti, ministro della Funzione pubblica, ministro dell’Interno, presidente della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, presidente del Consiglio del ministro (dal 4 agosto 1979 al 3 aprile 1980 e dal 4 aprile 1980 al 17 ottobre dello stesso anno) con l’interim del Ministero degli Affari esteri, e presidente del Senato. Infine il settennato al Quirinale, iniziato il 24 giugno 1985 e interrotto il 28 aprile 1992, a pochi mesi della scadenza naturale. In tutto questo periodo ebbe modo di votare per l’elezione di otto capi di Stato – lui compreso – e i travagli che lo riguardarono compresero anche ventinove capi d’imputazione mossigli nel corso del tempo.
Con la sua morte, c’è chi ha ipotizzato nel giro di qualche anno il verificarsi di un nuovo ‘caso Dardozzi’, con un archivio personale che a un certo punto salta fuori per gettare nuovi elementi sul tavolo delle ricostruzioni storico-politiche (e magari anche giudiziarie) della cosiddetta ‘prima Repubblica’. Ma a dar retta al Cossiga del 2000, questo non avverrà. “Io le cose le dirò da vivo, perché ‘dopo’ uno non ne se assume più la responsabilità”. Vedremo, dunque, se terrà fede a questa affermazione, ma se venisse smentita ci sarebbe poco di cui sorprendersi, dato che l’ex capo dello Stato sembrava giocare a sconfessare se stesso. Del resto era stato proprio lui che, il 9 marzo 2008, a trent’anni dal sequestro di Aldo Moro, aveva detto di aver “tenuto un diario giornaliero su quella vicenda, chissà che non lo pubblichi”. Per intanto, accanto – e soprattutto oltre – i commossi coccodrilli pubblicati a partire dal 17 agosto 2010, giorno della sua morte, un esercizio utile è rileggere ciò che affermò e scrisse in vita. Un esercizio utile a comprendere se davvero fu uno statista, come si è detto con i toni che si ritengono dovuti agli estinti. Oppure se ha ragione chi dice che statista non lo fu per niente e che giocò con le istituzioni a detrimento dello Stato e dei suoi cittadini.
A partire dalla comunicazione ufficiale del suo decesso, è stato un flusso ininterrotto di parole. E di certo nella memoria collettiva più di altri aspetti sono rimaste le provocazioni. Tra quelle meno citate, un disegno di legge del 2002, composto da 138 articoli, per trasformare la Sardegna in comunità autonoma come la Catalogna. Ma dopo l’invenzione del ‘presidente picconatore’ ai tempi del suo settennato da capo di Stato, dichiarò che se fosse tornato indietro avrebbe evitato le virulente esternazioni che avevano contraddistinto la sua permanenza al Quirinale.
Va aggiunto però che così pentito per le sue intemperanze non sembrava esserlo, dato che non aveva più abbandonato le polemiche, quasi si sentisse autorizzato a proseguire perché “godo di quella libertà che è dovuta all’età, all’aver ricoperto tutte le cariche e all’incombente pericolo di morire di cancro”. Era il 2002 quando pronunciava queste parole e la sua tempra gli avrebbe concesso ancora tempo per sbizzarrirsi sui giornali e nei palazzi della politica, dopo aver resistito – e continuando a farlo – a diversi incidenti, un tumore al colon, un processo degenerativo alla colonna vertebrale, una frattura all’anca, la depressione (”è da intellettuali”) iniziata dopo il caso Moro e una forma di stanchezza cronica (”queste malattie colpiscono solo gli eletti”) diagnosticata dopo un lungo peregrinare per specialisti.
Nei giorni successivi alla sua morte, si accese – per quanto spenta velocemente – una specie di polemica. Da un lato il giornalista Marcello Veneziani scriveva sulle colonne del Giornale che il presidente emerito alla fine si era arreso alla sepsi rifiutando le cure. Dall’altro gli replicò il senatore sardo Piero Testoni ricordando che la fede cattolica del presidente emerito mai gli avrebbe consentito di optare volontariamente per la propria fine. Forse Testoni aveva ragione, se si ricorda la veemenza di Cossiga sul caso di Eluana Englaro e contro la sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione che, constatato lo stato vegetativo della donna, autorizzava l’interruzione dell’alimentazione artificiale. Ma è anche vero che Francesco Cossiga non fu mai un uomo di una sola parola. O, per usare una sua frase, “chi non cambia mai idea o è un cretino o un imbroglione. La realtà è in continuo movimento e il perseguimento degli stessi obiettivi può richiedere strategie assai diverse, a seconda del momento in cui si decide di agire. Un politico rigidamente coerente con sé stesso non è un politico”.
Una natura doppia, dunque, o forse due personalità speculari. Un Francesco Cossiga che sembrava pensarla diversamente da se stesso. Ma se anche non fosse stato così, di certo era in grado di esprimersi in termini del tutto opposti. Dove sta dunque la verità nelle infinite dichiarazioni che il presidente emerito rilasciò a partire da quando svestì i panni super partes di capo dello Stato e si mise a tirare picconate a destra e a manca?