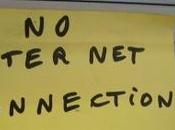Due orizzonti: il primo verso la metà del racconto quando il
protagonista ed una delle sue vittime guardano dall’alto il quartiere
natale sul punto di scomparire a causa della riconversione urbanistica.
Il secondo piazzato alla fine del film a fermare per sempre il crinale
di un paesaggio montano appena offuscato dalla bruma del mattino.
Immagini che nel visualizzare un mondo concreto ma lontano esprimono
alla perfezione la distanza che divide l’umanità dal sogno dell'agognata
felicità. Una condizione non esclusivamente ad appannaggio dei due
protagonisti, lo strozzino che infierisce sulle sue vittime con varie
mutilazioni e patimenti, e la donna che ad un certo punto afferma di
essere sua madre, costringendolo ad accettarla nella propria casa, ma
anche di coloro che nel corso della vicenda saranno sacrificati a quel
rapporto. Un paradiso perduto che lungi dall’essere l’eldorado di soldi e
di piacere confezionato dalle sovrastrutture del potere riguarda
piuttosto la sfera intima e personale, andando a minare gli equilibri
familiari e legami ancestrali come quello che si instaura tra genitori e
figli, con la morte o la menomazione di uno dei suoi componenti. Nel
far questo, nel voler dimostrare a che punto di degradazione è arrivato
l’uomo e la sua azione distruttrice, capace di relegare la dimensione
umana al di sotto del profitto e degli interessi economici, Kim Ki Duk
agisce in maniera sistematica, alternando l’umiliazione fisica dei vari
debitori all’apatia del loro aguzzino, praticamente inesistente se non
fosse per quelle manifestazioni omicide. E se altre volte il regista
coreano ci aveva regalato possibilità di evasione anche estetica in
questo caso a prevalere è il senso di oppressione e di ineluttabilità
che Kim Ki Duk ci trasmette con immagini strette ed anguste, sature di
oggetti ed illuminate di grigiore, oppure con piani americani che
fissano i personaggi al paesaggio circostante. Ed è soprattutto nella
continua proposizione di uomini e donne che appaiono incastrati nelle
loro macchine da lavoro, con argani e catene che sembrano imprigionarli
alla ripetitività delle loro azioni, che il regista legittima la visione
di un uomo diventato ingranaggio del sistema. Non più essere dotato di
libero arbitrio ma pedina necessaria a realizzare un disegno a lui
sconosciuto, come testimonia la mancanza di spiegazioni ed anche di
visibilità del boss del protagonista, praticamente celato allo
spettatore all'infuori di una breve comparsata.
Due orizzonti: il primo verso la metà del racconto quando il
protagonista ed una delle sue vittime guardano dall’alto il quartiere
natale sul punto di scomparire a causa della riconversione urbanistica.
Il secondo piazzato alla fine del film a fermare per sempre il crinale
di un paesaggio montano appena offuscato dalla bruma del mattino.
Immagini che nel visualizzare un mondo concreto ma lontano esprimono
alla perfezione la distanza che divide l’umanità dal sogno dell'agognata
felicità. Una condizione non esclusivamente ad appannaggio dei due
protagonisti, lo strozzino che infierisce sulle sue vittime con varie
mutilazioni e patimenti, e la donna che ad un certo punto afferma di
essere sua madre, costringendolo ad accettarla nella propria casa, ma
anche di coloro che nel corso della vicenda saranno sacrificati a quel
rapporto. Un paradiso perduto che lungi dall’essere l’eldorado di soldi e
di piacere confezionato dalle sovrastrutture del potere riguarda
piuttosto la sfera intima e personale, andando a minare gli equilibri
familiari e legami ancestrali come quello che si instaura tra genitori e
figli, con la morte o la menomazione di uno dei suoi componenti. Nel
far questo, nel voler dimostrare a che punto di degradazione è arrivato
l’uomo e la sua azione distruttrice, capace di relegare la dimensione
umana al di sotto del profitto e degli interessi economici, Kim Ki Duk
agisce in maniera sistematica, alternando l’umiliazione fisica dei vari
debitori all’apatia del loro aguzzino, praticamente inesistente se non
fosse per quelle manifestazioni omicide. E se altre volte il regista
coreano ci aveva regalato possibilità di evasione anche estetica in
questo caso a prevalere è il senso di oppressione e di ineluttabilità
che Kim Ki Duk ci trasmette con immagini strette ed anguste, sature di
oggetti ed illuminate di grigiore, oppure con piani americani che
fissano i personaggi al paesaggio circostante. Ed è soprattutto nella
continua proposizione di uomini e donne che appaiono incastrati nelle
loro macchine da lavoro, con argani e catene che sembrano imprigionarli
alla ripetitività delle loro azioni, che il regista legittima la visione
di un uomo diventato ingranaggio del sistema. Non più essere dotato di
libero arbitrio ma pedina necessaria a realizzare un disegno a lui
sconosciuto, come testimonia la mancanza di spiegazioni ed anche di
visibilità del boss del protagonista, praticamente celato allo
spettatore all'infuori di una breve comparsata. Con uno stile minimale ma denso di significati, basterebbe pensare all’immagine che ad un certo punto ci offre una sorta di ricomposizione familiare con la parti in causa adagiate insieme su un lembo di terra in riva ad un fiume oppure a quella della sequenza finale che senza rivelarne il contenuto sembra il presagio di una condizione umana inevitabilmente segnata dal sangue, Kim Ki Duk dimostra di essere ancora in grado di scrivere pagine di cinema che restano impresse. Se la sofferenza è una costante e l'amore una semplice illusione, "Pietà" sembra essere un grido d'aiuto ed insieme un gesto di compassione nei confronti di chi non ha smesso di soffrire.