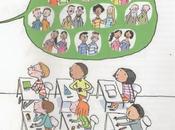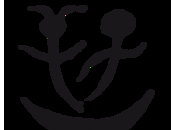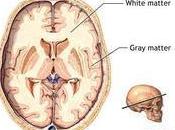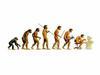Continuiamo a parlare di Postmoderno. Nell’articolo precedente, dopo una breve analisi etimologica, abbiamo cercato di definire le sfumatissime differenze di significato tra Postmodernismo e Postmodernità, individuando nel primo dei due termini l’apparato teorico-filosofico che sostiene il Postmoderno e nel secondo l’epoca storica – quella in cui viviamo – che da questo stesso apparato è definita e scandagliata. Ancora una volta ci eravamo fermati con il dubbio di non aver fatto sufficientemente chiarezza, di aver lasciato punti in sospeso e spazi bianchi. Ancora una volta abbiamo ceduto il passo all'«incertezza» traballante. E siamo sicuri che ai più non sarà risultata gradita la nostra difesa; vale a dire che, parlando di Postmoderno, un minimo di indeterminatezza è inevitabile perché essa è interna, non tanto al discorso critico del singolo osservatore, quanto piuttosto all’oggetto stesso della ricerca. Tradotto rozzamente; le teorie Postmoderne (aggettivo sostantivato) non sono mai conclusive, perché il metodo stesso di ricerca e di analisi postmoderno (aggettivo semplice) fa della “non conclusività” un suo punto di forza e una sua conquista. Speriamo adesso che un’indagine leggermente più approfondita dei lineamenti della Postmodernità e dei contenuti teorico-filosofici del Postmoderno riesca, se non a eliminare ogni incertezza - abbiamo già detto che sarebbe una forzatura teorica -, quanto meno a rendere l’incertezza stessa meno incerta.
Continuiamo a parlare di Postmoderno. Nell’articolo precedente, dopo una breve analisi etimologica, abbiamo cercato di definire le sfumatissime differenze di significato tra Postmodernismo e Postmodernità, individuando nel primo dei due termini l’apparato teorico-filosofico che sostiene il Postmoderno e nel secondo l’epoca storica – quella in cui viviamo – che da questo stesso apparato è definita e scandagliata. Ancora una volta ci eravamo fermati con il dubbio di non aver fatto sufficientemente chiarezza, di aver lasciato punti in sospeso e spazi bianchi. Ancora una volta abbiamo ceduto il passo all'«incertezza» traballante. E siamo sicuri che ai più non sarà risultata gradita la nostra difesa; vale a dire che, parlando di Postmoderno, un minimo di indeterminatezza è inevitabile perché essa è interna, non tanto al discorso critico del singolo osservatore, quanto piuttosto all’oggetto stesso della ricerca. Tradotto rozzamente; le teorie Postmoderne (aggettivo sostantivato) non sono mai conclusive, perché il metodo stesso di ricerca e di analisi postmoderno (aggettivo semplice) fa della “non conclusività” un suo punto di forza e una sua conquista. Speriamo adesso che un’indagine leggermente più approfondita dei lineamenti della Postmodernità e dei contenuti teorico-filosofici del Postmoderno riesca, se non a eliminare ogni incertezza - abbiamo già detto che sarebbe una forzatura teorica -, quanto meno a rendere l’incertezza stessa meno incerta.
Partiamo allora da un’affermazione sulla quale quasi tutti, dai detrattori ai più accaniti sostenitori, convengono di buon grado; Postmoderno è una pessima definizione. Troppo provvisoria, sfuggente, improbabile, per certi versi quasi tautologica. Eppure, allo stesso modo, anche se con gioia molto meno condivisa, la stragrande maggioranza dei critici accetta il fatto che oggi non esista una definizione migliore per parlare della società in cui viviamo e per raggruppare le teorie filosofiche che l’hanno contraddistinta.
Entrato in circolazione, nei dibattiti critici, intorno agli anni Cinquanta il termine Postmoderno è divenuto, negli anni Settanta circa, di uso comune, con un’accezione che, se non ci possiamo azzardare a definire del tutto positiva, possiamo sicuramente considerare più neutra. Non a caso notiamo che le costruzioni formate sul modello di Post-moderno sono proliferate negli ultimi anni; post-ideologico, post-industriale, post-mortale, post-democratico, post-umano. Questo mette in mostra un fatto fondamentale; nella nostra società sono in corso stravolgimenti e cambiamenti di proporzione fino ad oggi sconosciuta. Cambiamenti talmente repentini e massicci che gli osservatori, anche i più acuti, fanno fatica a decifrare e catalogare con accuratezza. Postmoderna doveva essere proprio questa condizione di precarietà, quest’incapacità di racchiudere le cose dentro involucri saldi e solidi. Postmoderno è un atteggiamento, un modo di vedere le cose. Ed è seguendo questa traiettoria allora, forse per metonimia, che Postmodernità è diventato l'appellativo per l’epoca stessa in cui quest’atteggiamento è divenuto fondamentale. Anthony Giddens usa «tarda modernità», Ulrich Beck «modernità riflessiva», Georges Balandier «surmodernità», ma, secondo il parere di un maestro come Zygmunt Bauman, Postmodernità rimane la definizione preferibile.
La Postmodernità dunque - diciamolo ancora una volta - è l’epoca in cui viviamo. L’epoca in cui prende piede il modello economico post-industriale teorizzato da Daniel Bell negli anni Cinquanta (The coming of Post-industrial Society). L’epoca in cui il capitalismo si è affermato come modello vincente. L’epoca che Ernest Mandel definisce «terzo stato dell’espansione capitalista». Un'epoca caratterizzata dallo slittamento dei processi iniziati nella Modernità verso il loro doppio, frammentario e frammentato, etereo e intangibile; lo smantellamento dei meccanismi di produzione, la terziarizzazione della società, lo sviluppo dei sistemi di trasporto, la compressione dello spazio e del tempo dovuta ai nuovi sistemi di comunicazione, la globalizzazione degli scambi di merci e denaro, la delocalizzazione delle imprese, la definitiva consacrazione del modello capitalistico, la secolarizzazione delle istituzioni, la spettacolarizzazione dell’esistenza legata ai nuovi media.
Tutto questo comporta una fortissima precarietà di fondo; affettiva, sentimentale, conoscitiva, ermeneutica (James Ballard parla di death of affects, crisi delle emozioni). L’uomo del tardo XX secolo è esposto al bombardamento di immagini e loghi, alla virtualizzazione delle sue condizioni di vita, in una società attraversata, ad alta frequenza, da flussi e spostamenti inarginabili (sono i flussi di persone, immagini, tecnologie, capitali e idee di cui parla l’antropologo indo-americano Arjun Appadurai), trasformata dalla globalizzazione economica e culturale, ridotta a una serie di frammenti apparentemente identici tra loro, a una serie di splendide rovine. E tra questi frammenti e queste rovine si muove il cittadino Postmoderno, come un turista o un parvenu, stringendo rapporti liquidi con le cose e con i suoi simili, rapporti senza legami stretti, dispersi in un mondo di infinite possibilità e libertà (Cfr. Z. Bauman, Il disagio della Postmodernità, Bruno Mondadori), in cui la rappresentazione della realtà sembra essere più reale della realtà stessa.
Secondo Jean Baudrillard (La società dei consumi, Il Mulino), in un mondo frammentario e senza legami, di pura rappresentazione, i modelli finiscono con il sostituire le cose, e il soggetto è spinto ad abbandonare la propria condizione di individuo, declinando le proprie scelte personali, per ridursi a personaggio all’interno del discorso autoreferenziale attraverso cui la società mostra e produce se stessa; un mondo di feticci e simulacri, in cui non c’è alcuna distinzione tra significante e significato, in cui il segno è già di per sé ipersignificativo, è già messaggio. È il famoso capitale «giunto a un tale livello di accumulazione da diventare immagine» (Guy Debord, La società dello spettacolo, Massari editore). Ma che ci piaccia o no, questo è il nostro mondo, l’epoca in cui viviamo, il nostro modello di vita occidentale.
Alla fine di questo terzo appuntamento sembra necessario precisare che l’indagine sui lineamenti e sugli aspetti più importanti della Postmodernità, seppure riportati in maniera molto sintetica, diventa determinante, in primo luogo per capire e comprendere i contenuti di base del pensiero postmoderno, dato che ne costituisce il background naturale, in secondo luogo perché proprio in reazione a questo modello di società nasce tanta di quella letteratura che oggi, a pieno titolo, definiamo e consideriamo postmoderna. È il caso dei romanzi e racconti di DeLillo, Vonnegut, Ballard, Barth, Auster. Ma anche di molta letteratura fantascientifica che, da Aldous Huxley a Philip K. Dick a William Gibson, in rapporto a questo contesto storico-sociale ha preso piede e forma. La direzione che si è dunque scelta per questa rubrica - contestabile per carità - è di procedere dall’analisi del mondo in cui viviamo verso le teorie filosofiche e soprattutto estetico-artistiche che in esso sono nate e si sono sviluppate.
Media: Scegli un punteggio12345 Il tuo voto: Nessuno Media: 5 (1 vote)