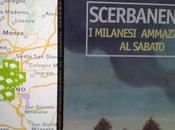Geologia di un padre, edito da Einaudi, narra di una distanza, definita geologica, colmata post-mortem nel ricordo. Come pensa di essere riuscito a superare qualche possibile ambiguità della memoria?
Geologia di un padre, edito da Einaudi, narra di una distanza, definita geologica, colmata post-mortem nel ricordo. Come pensa di essere riuscito a superare qualche possibile ambiguità della memoria?
Apprezzo questo concetto di ambiguità della memoria, ma penso di non averlo voluto superare. Ho semplicemente cercato di impiegare i ricordi nella mia personalissima prospettiva, dunque in modo del tutto soggettivo, tant’è vero che, in una pagina piuttosto esplicita, dichiaro di non volermi servire della documentazione che pure avevo sottomano. Insomma, ho preferito attenermi agli appunti, alle note, ai ricordi, alle indicazioni delle persone che erano state vicine a mio padre. In verità, poi, mi è capitato di leggere una magnifica recensione nella quale Federico Francucci nota come io mi contraddica e attinga a piene mani agli archivi dell’Istituto Antifascista di Milano, per esempio a proposito del cugino antifascista di mio padre. È vero che, non essendo uno studio scientifico bensì una prosa, il mio libro va contro le regole che mi ero dato. Ma, ripeto, quello che mi stava a cuore era soprattutto cercare di ricreare la presenza di mio padre, dunque non tanto sciogliere le ambiguità della memoria, ma scegliere, scegliere invece di sciogliere, quelle più rappresentative.
I capitoli del romanzo sono 83, come gli anni di suo padre. Oltre la funzione estetica, confluiscono anche in una numerologia con significati simbolici più complessi?
Rispondo con due indicazioni. La prima è che io ho fatto ricorso da sempre a simili apparati numerologici: il mio primo libro aveva novanta testi divisi in due parti da quarantacinque; Addio al calcio, scritto trent’anni dopo, imita i minuti di una partita di calcio, e quindi ricorre di nuovo al numero novanta, diviso in due per rappresentare i due tempi da quarantacinque. Io però, più che altro, riporterei tutto ciò agli schemi dell’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, ndr), il famoso gruppo di scrittori che ruotava in Francia intorno a Queneau e Perec; questo per dire che nelle mie scelte non c’è altro, nulla di dantesco, nulla di simbolico. Una cosa comunque va precisata: dopo aver fatto la mia scelta, e quindi dopo la pubblicazione del libro, pochi mesi fa ho scoperto due titoli. Uno, di cui ora non ricordo l’autore, fa ricorso allo stesso meccanismo, e, cosa incredibile, si fissa proprio sul numero 83. L’altro, invece, è una piccola autobiografia scritta da Derrida quando aveva 59 anni, e divisa, appunto, in 59 capitoli. Però, è un’autobiografia, mentre la mia è una biografia. Non avrei avuto alcuna difficoltà a segnalare queste fonti. Lo faccio sempre, e anzi mi diverte. Però non sono fonti, le ho scoperte dopo. Diciamo che mi ha colpito scoprire che quest’uso dei numeri e di alcune corrispondenze sia un procedimento tutto sommato abbastanza praticato, e che era già stato praticato, seppure a mia insaputa.
Il romanzo si apre con un figlio che rimembra il padre. Possiamo dire che si chiude con un figlio che diventa egli stesso padre?
Devo premettere una cosa: il romanzo si apre con un’introduzione scritta da mio padre, cosa in realtà impossibile, ma ottenuta grazie a una selezione di alcuni suoi disegni, dei quali io vado, lo confesso, molto fiero, dal punto di vista tipografico. Volevo a tutti i costi inserire del materiale illustrativo, in quanto nel romanzo mio padre appare come un uomo che viveva per i suoi disegni. Inoltre, attraverso la prefazione, ho potuto recuperare il titolo che mi era stato bocciato da tutti, dai miei figli, da mia moglie, dagli amici, dagli editori, cioè L’uomo di Pofi (che dà il titolo alla prefazione, ndr). Allora ho avuto l’idea di questa introduzione “muta”, scritta da una persona morta da anni, che, però, in qualche maniera, servisse a orientare il lettore. Com’è stato esattamente osservato, il libro si chiude con un figlio che diventa egli stesso padre, però un padre diverso. Ho sempre prediletto le strutture ad anello, o meglio, ad elica, a spirale, che compie lo stesso giro, però spostandosi di livello, tenendo conto di questa progressione che non contiene in sé nessuna ascesa, ma un mero sviluppo cronologico.
La paura della perdita ci costringe a portare nel presente, con moto perpetuo, le vivide immagini di un passato che vorrebbe offuscarle. Perché ha deciso di condividere con la prosa questa storia e non in versi?
È una domanda molto interessante per me. Io ho cominciato a scrivere in prosa su sollecitazione. Amo molto la poesia d’occasione, la poesia sur commande, come dicono i francesi. Mi piace perché mi obbliga a trovare qualcosa che altrimenti non avrei mai individuato. Quindi laddove molti vedono artificio e volontarismo, io invece apprezzo la possibilità di esplorare qualcosa che magari avrei ignorato. Ecco, nel 1990, mi pare, Gianni Celati mi telefonò perché scrivessi due racconti per una rubrica che teneva su un giornale. Io caddi dalle nuvole, gli dissi «Non ho mai scritto racconti». «Lo so bene – mi rispose – proprio per questo mi piaceva che ci provassi». Quei racconti sono poi confluiti in un libro di poesie, nel quale ho mescolato addirittura versi e traduzioni; era intitolato Esercizi di tiptologia e uscì nel 1992. Un mio amico musicista gli diede una definizione che mi piacque molto, disse che era un testo così anomalo, confuso, che ricordava un ornitorinco. In effetti, a me è sempre piaciuto rompere i generi, da qui l’uso delle immagini. Sviluppando il “concetto dell’ornitorinco” sono arrivato all’idea di una scrittura anfibia, nel senso che veramente oscilla tra versi e prosa. E ormai ho quasi “pareggiato i conti”, visto che i miei libri di poesia sono cinque, mentre quelli di prosa sono quattro (anche se credo che il prossimo sarà di poesia). C’è insomma un oscillare che ho ritrovato in uno dei miei maestri, ossia il grande scrittore ceco Hrabal, che scrisse alcune opere prima in versi, per poi tradurle in prosa.

Sì, ma prima ancora di internet la linea della commistione tra testo e immagine risale al Settecento, con Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne. Segue Breton, con Nadja, negli anni Venti del Novecento, e infine il Winfried Sebald, lo scrittore tedesco che è diventato punto di riferimento inimitabile. A tutto ciò si aggiungono le infinite possibilità dei link, di internet, che io trovo affascinanti. Ho un atteggiamento di estrema apertura, perché, devo dire, la mia formazione è stata sperimentale. Pur essendo in dissidio con le avanguardie, se c’è una cosa che ho trattenuto del loro passaggio è stato proprio il piacere di sperimentare, di giocare. Mi limito a un esempio: in genere le copertine dei miei libri le faccio io, quindi, laddove posso, io mi impossesso totalmente dell’oggetto. Molto spesso scrivo la quarta di copertina, scelgo le fotografie, addirittura il mio primo libro di prosa, Nel condominio di carne, aveva in copertina una radiografia di una mia gamba che aveva come titolo “autoritratto rettificato”.
«Ospitati dentro caseggiati di pietra, separati dal suolo, sono riposti, sì, entro bare di legno, ma bare foderate di zinco. Così facendo, viene impedita loro ogni via di fuga». Lei ha voluto aprire una via di fuga per suo padre?
Grazie, è un’immagine bellissima, quella della via di fuga. È proprio così, non avrei saputo dirlo con parole migliori. È così, proprio una via di fuga.
Sartre sosteneva: «Non esiste un buon padre, è la regola; non bisogna prendersela con gli uomini, ma con il legame di paternità che è marcio». La solitudine dei figli è la trasfigurazione del male?
Io trovo che Sartre abbia ceduto un po’ troppo rapidamente alla propria esperienza. È una bella frase, e io del resto cito quella, ancora più dura, di Joyce, che descrive il padre come “un male necessario”. Devo dire però che io non sono affatto d’accordo con questa affermazione, anzi, ho voluto dimostrare che, con tutti i difetti dovuti alla sua generazione, alla fine mio padre ha cercato di essere un buon padre, anche se non so se ci sia riuscito. Il che naturalmente nulla toglie al fatto che esistono purtroppo anche dei pessimi padri, come, probabilmente, quello di Sartre.
Per accedere alle altre interviste dello Speciale dedicato al Premio Campiello 2013, cliccare sul nome dello scrittore: Beatrice Masini, Giovanni Cocco e Fabio Stassi.
[Seguiteci su Facebook, Twitter, Google+, Issuu e Pinterest]
Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora