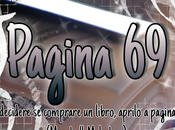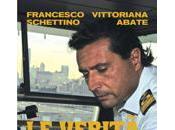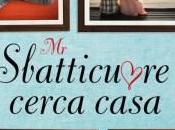Come dicevo nel primo numero della rivista, il pulp nasce come genere di serie B volto a soddisfare la sete di violenza, sesso e parolacce di un pubblico popolare. Un genere scritto per soldi, venduto su riviste scadenti. Ma il pulp col tempo si è affermato, si è evoluto. E più o meno dagli anni 90 il pulp è diventato uno dei modi più efficaci in ambito narrativo, insieme al noir, per rappresentare la realtà dei nostri anni. Vi siete mai chiesti perché?
Semplice: è la realtà dei nostri giorni ad essere pulp.
Scrivere una storia pulp, oggi, vuol dire trattare in modo crudo il lato peggiore della realtà. Non esistono forse in gran quantità omicidi, violenze, droghe, sesso promiscuo o estremo e altre cose simili, ingredienti basilari del pulp? Certo. E sono anche banalizzate dai mass media, rese accettabili da un linguaggio asettico, monotono e artificiale. Ed ecco che il pulp, con la sua crudezza, riesce a mostrare di nuovo la realtà (o comunque una parte di essa) per quello che è: violenta, sordida, rancorosa, promiscua, corrotta. Non c’è più il gusto voyeuristico del primo pulp per alcuni elementi tabù; a quello oggi ci pensa la televisione, con una cronaca nera sempre più vicina al
gossip e al morboso. Oggi il pulp è solo rappresentazione cruda di una realtà cruda, e per questo è finito col fondersi inevitabilmente col filone del romanzo sociale. Basti pensare a
Fight Club, romanzo che fa della critica sociale il suo leitmotiv. O anche a
Il Lercio,
Trainspotting, o per citare un autore nostrano
Matteo Strukul, che con la sua
Ballata di Mila fa un attenta analisi del suo territorio. Per non parlare del cinema, e chi più ne ha più ne metta.
A questo punto restano solo due cose da fare: congratularsi col pulp, per la maturità raggiunta, e preoccuparsi della realtà, che non è tanto dissimile dai romanzi.
Aniello Troiano