Non si infila nelle spire della coscienza degli sporchi, sebbene, a prima vista, sia a loro più affine. Questo personaggio, invece, ossessiona i puri. Li tormenta perché in realtà egli è un puro, un diafano di cuore, un coraggioso della noia, un animale ferito che si muove nell’assolata desolazione dell’esistenza italiana (ero destinato alla sensibilità, ero destinato a diventare uno scrittore, ero destinato a diventare Jep Gambardella). Non esiste un animo cinico se prima non si è avuto, e lo si conserva gelosamente, un cuore tenero; non esiste un uomo con una visione disincantata, nichilista, spiazzante, se prima, lì, non vi era un giovane che, con la sua folta chioma, nuotava nel blu azzurro facendo innamorare le floride, maliziose ragazze.
E non esiste erotomane stanco e annoiato ma sempre alla ricerca di un letto da scaldare, se prima non si è avuto un imberbe che si innamorava dell’amore e poi della donna, che credeva unica, che lo faceva innalzare sul creato, sussumere, in un attimo, di avere appreso il senso del vivere.
La persecuzione che Jep Gambardella infligge ai puri è questa: una lezione, cruda e senza compromessi, di che cosa vuol dire aver perso la giovinezza e sentire, tuttavia, un piccolo fremito d’amore per l’alba romana, le rovine della Capitale, e gli occhi, gli occhi di quella ragazza che chiunque ha incontrato su uno scoglio, un’estate, al riparo dai doveri della vita, e che ti ha dato l’impressione che l’amore era possibile e il mondo una cosa solo da vivere alla grande.
Jep comincia ad essere il re dei mondani la prima volta che rimane deluso (sono precipitato abbastanza presto in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità, volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito), quando la donna con gli occhi grandi e i capelli lunghi e biondi gira la sua bocca non ricambiando il bacio (che cosa ho sbagliato?), e lui, lì, rimane basito dall’amara, innocente fregatura delle femmine.
La delusione se la porta dietro in eterno, e, per non provarla più, si muta in cinico, perché, in fondo, il cinismo è la corazza dei perdenti (non posso perdere più tempo a fare cose che non mi va di fare); perché la sconfitta, sublimata dall’arte, è affascinante, misteriosa, inconoscibile, non banale (gli sparuti costanti tratti di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile).

Rick Blaine, interpretato da Humphrey Bogart, è uno dei grandi personaggi della storia del cinema che condensa il cinismo e l’amore.
Tutti gli sconfitti sono i grandi personaggi delle letterature e l’autore non fa che inseguire l’imperante stratagemma di tale retorica, come con Tony Pisapia de L’uomo in più o con Tony Pagoda di Hanno tutti ragione.
Jep si inserisce nella tradizione dei disillusi italici creati da Svevo, Pirandello, Brancati, Volponi, senza menzionare i personaggi del passato e immenso cinema italiano. Ma, indubbiamente, colui al quale egli è più vicino è il Didimo Chierico di uno storico malinconico come Ugo Foscolo che così descriveva il suo Jep ante litteram. Teneva irremovibilmente strani sistemi; e parevano nati con esso: non solo non li smentiva co’ fatti, ma come fossero assiomi proponevali senza prove: non però disputava a difenderli, e per apologia a chi gli allegava evidenti ragioni rispondeva in intercalare: opinioni. Il relativismo saggio e un po’ vigliacco, motore della filosofia dell’uomo consapevole.
La grande bellezza è la storia di uno scrittore che vive un ossimoro permanente: soffocato e tenuto in vita dalla crisi della pagina bianca, la maledetta anemia che prende alle mani e al cervello di ognuno che si senta minimamente portato alla faticosa arte che distribuisce sofferenze e, talvolta, gioie eterne. La sua presentazione registica vorrebbe avvenire in maniera epica, alla Melville, alla “chiamatemi Ismaele”, il resto, come viene cantato dal protagonista della storia, è puro chiacchiericcio, miserabile e terribilmente umano.
Arriva sempre nella storia artistica di un artista la voglia di lasciare il segno, l’agognata aspirazione a perseguire furiosamente il grande romanzo patrio, la pietra miliare che farà assurgere alla fama perpetua chi lo scrive. Jep Gambardella, il protagonista bigger than life, non scrive più perché ha capito di non riuscirci o, semplicemente, perché è più facile far credere agli altri di essere un talentuoso che ha preferito divertirsi piuttosto che svelare la sua essenza di impostore (come la maggior parte degli artisti).
L’uomo è un marchingegno complesso; cunicoli, pesi e contrappesi, clessidre per misurare il tempo presente, quello vissuto e quello della memoria che distoglie e distorce; beh, tutto questo viene licenziato da Jep come fosse un’eventualità a cui lui non può di certo aggiungere nulla. Nessuna ambizione di descriverle queste clessidre, troppo intelligente e disincantato per avere la volgare brama di essere un Dante capace di restituirci il quadro e la polvere del saliscendi mercuriale della breve esistenza. Il niente è più duro, un abisso da cui non si risale, ma lo si preferisce al tutto, all’insieme, complesso e difficile. Un po’ come rifiutare la relazione con una donna troppo intelligente, che ti metterebbe a contatto con le fragilità proprie del maschio ridicolo.
Jep si aggira nelle speranze inoptate di una città, Roma, trasfigurata dai trucchi cinematografici di un regista che omaggia Fellini, Terrence Malick, e il suo stesso cinema barocco e farcito di contemporaneo e fumettistico atteggiamento verso la realtà.
Jep non vuole crescere, probabilmente; Jep non è contento ma, in fondo, si costringe a non pensarci. Troppo semplice contrapporre le brutture del presente con la nostalgica voglia di rivivere un amore giovanile. Il senso della storia di Jep, invece, non sta lì, sebbene tale dualismo serva allo scheletro superficiale che ogni storia pretende. La sua storia è la storia di un uomo che ti sbatte in faccia la verità, la sua verità, e il camuffamento della messinscena fa il resto, in modo che lo spettatore si immedesimi, cadendoci, in questo ominicchio dal cuore grande. Il suo cinismo, le sue massime da film di Sergio Leone, la sua rodata attitudine alla vita, la sconfitta elevata a fascino, lo rende maledettamente attraente. Cominci anche te a fare valutazioni distaccate,tranchant e definitive sulla tua vita, sulla vita degli altri, sul tuo Paese e sul mondo.
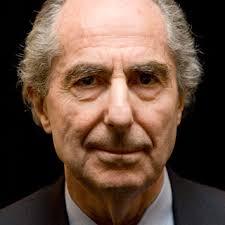
Philip Roth, lo scrittore americano che sa ha saputo costruire svariati personaggi sgradevoli e affascinanti, comici e tragici.
Le rughe non sono più segno di vecchiaia ma contezza di aver capito qualcosa. Ti puoi prendere beffe di chi si prende sul serio, e Jep non si prende mai sul serio, simile al Barney di Richler o ad una vecchia carampana alla Philip Roth, ci delizia mondando il suo corrotto e bisunto trascinarsi con perle di laica predicazione sapienziale.
Quando fa a pezzi la scrittrice di sinistra, rade al suolo il certo mondo che in Italia tenta di contraffare la società, spacciando mezze calzette per grandi scrittori, ignobili cialtroni dediti all’arraffo della credibilità confusi come fossero giornalisti autorevoli. Jep è parte di quel mondo, campa di rendita con un solo unico romanzo scritto, di cui tutti parlano ma che probabilmente nessuno ha letto, un po’ Raffaele Dudù La Capria un po’ Roberto D’Agostino. Egli ha scelto, però. È il Marcello Rubini de La dolce vita che tra il mondo coltissimo, raffinato e decadente di Steiner ha definitivamente preferitoPaparazzo e le orge sul lungo mare.
Tra il disimpegno e il suo opposto, Jep vira sul primo, ma rimane sempre lui, condannato ad essere uno scrittore, a preferire l’odore delle case dei vecchi rispetto alla vertigine stordente di un ballo ritmato dalle narici infuocate di cocaina. Si immerge nel mondo del flaubertiano nulla ma ha qualcosa a cui non rinuncerà mai, il sensibile anelito alla profonda vita. Dissimula perché il mondo delle pailettes e delle Serene Grandi gli ha dato la fama, il sesso, il successo, i soldi, spendendo poco in termini di fatica e sudore. Tra il Bancarella e l’andare a cena in posti famosi a salutare cantanti famosi, sceglierà sempre la seconda via, affliggendosi con una smorfia alla bocca, e l’etilico liquido con ghiaccio, a pensare al suo destino disatteso di grande scrittore celebrato nelle antologie degli studiati narratori e poeti.
Jep balla e ballerà sempre Raffaella Carrà che canta l’amore sfrenato, con i colori e i suoni del falsamente depravato, ma nel mezzo della pista, ogni tanto, complice un po’ di alcol, ripenserà a quella canzonetta che fa vibrare l’animo (ecco cosa è la vibrazione!), alla sabbia sulla bocca e ai turbamenti, a Bruno Lauzi e a Ti Ruberò(ti ruberò a tutti quelli che non sanno più sognare come noi).
Jep possiede l’amore perduto, motore della sua diversità in mezzo alle nane e ai poeti con la capigliatura scapigliata e dannata; alle Dolores Ibárruri di Prati Fiscali, di sinistra e raccomandate, scioccamente presuntuose e realizzate dalla Signora TV, un po’ troie con il libro intonso in mano; ai mezzi falliti che cercano di incidere con assurdi monologhi teatrali; ai prosseneti che si preoccupano penosamente della figlia spogliarellista.
Questo è il mondo, dice Jep, non l’ho scelto, ci sono capitato, non chiedetemi di più voi spettri del passato, però non andate via perché senza di voi io non sono nessuno, sono come quelli che frequento e che disprezzo e di cui non posso fare a meno.

Nel film di Sorrentino, dove la memoria è perno della storia, non poteva mancare la citazione di Marcel Proust.
La stancante presa di coscienza della sua anima appesantita, senescente, il suo fisico cadente come fosse un Pantagruel scorreggione e sozzo, rendono simile la parabola a quella di un paese, l’Italia, che vive sulle macerie retrive e ineliminabili, che non conosce gli anfratti dove brulica la massa (mai è mostrato nel film anche un misero brandello della maledetta cinta romana, da Tor Bella Monaca ai quartieri di Pasolini), un Paese che esclude i giovani senza cattiveria ma solo perché li ignora e li include a cottimo, rendendoli nevrastenici, tarantolati, macchiette – la bambina seviziata e obbligata al martirio dell’arte del murales; il figlio viziato, toccato, che si tinge di rosso, che imita l’arte credendola vita, che interroga Proust come un oracolo; il quarantenne che attacca bottone riuscendo a dire, rimanendo serio: “Proust è il mio scrittore preferito, insieme ad Ammanniti”. Personaggi, questi giovani, di cornice, schiacciati dal rutilante mondo degli adulti ben arroccati sui loro terreni interessi, sociali economici culturali. Il botulino, in siffatto paese, non è un calcio alla crisi da chi non accetta la realtà, ma è la linfa vitale di questa generazione vecchiarda che si riunisce in una comunità di straccioni che richiedono di immobilizzare la giovinezza attraverso una puntura e le parole del medico cazzaro.
Pur partecipando alla giostra reazionaria e conservatrice in plastica, Jep custodisce la giovinezza che, in lui, è qualcosa di sospeso, etereo, sognante e non vero. La sua bellezza, la bellezza di lei, sono solo pretesti che mandano avanti la pagliacciata ripetitiva; al contrario, il vero agghiacciante e tanto fascinoso fulcro della vicenda umana sta solo in Jep. Con la sua pochezza e la sua grandezza, con le sue idiosincrasie e il gusto di viverle, e l’ultima, inesauribile e circolare menzogna: “Ho una mezza idea di riprendere a scrivere”.




