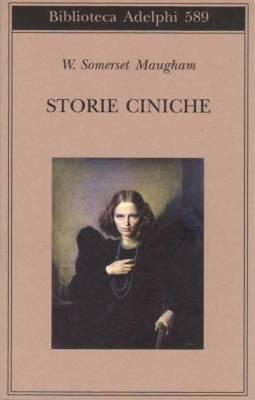 Storie ciniche, ovvero inclementi ritratti novecenteschi
Storie ciniche, ovvero inclementi ritratti novecenteschi
Gli undici racconti raccolti in Storie ciniche di William Somerset Maugham (traduzione di Vanni Bianconi, edito da Adelphi) sono stati scritti nel periodo tra le due guerre mondiali e occorre tenerne conto per cogliere tutta l’irriverenza degli intrecci e delle note di costume, che costituiscono il valore precipuo di questi testi, dal momento che della credibilità di alcuni dei frequenti dialoghi, delle volute stilistiche e ancor meno degli sperimentalismi Maugham, a differenza di tanti suoi contemporanei, sembra curarsi poco, attratto com’è dallo spettacolo bizzarro e involontario offerto dai suoi simili. Per intenderci, è una lettura che entusiasmerà sicuramente i tanti che hanno apprezzato la Zia Mame di Patrick Dennis, pubblicato anche questo da Adelphi.
Spesso è lo stesso alter ego dell’autore a narrare le vicende in prima persona – senza curarsi affatto che tale scelta strida un po’ con la sua onniscienza – e il suo sguardo attento e disincantato, o appunto cinico se si preferisce, si rivela spesso la lente migliore attraverso cui comprendere il comportamento di pettegole e annoiate nobildonne e di gentiluomini veri o presunti (Maugham ha sempre frequentato l’alta società, sia poiché di famiglia abbiente, sia perché il successo dei suoi scritti gli consentì sempre una vita agiata). Quale allora il segreto della sua popolarità? La novità della sua opera? Probabilmente l’atteggiamento bonario e divertito cui non giudica ma ritrae le debolezze altrui: non c’è mai condanna per i vizi, semmai per l’idiozia, quella sì davvero imperdonabile. Eppure la sua risposta è comunque un’alzata di spalle: «se uno dovesse prendersela per la stupidità umana passerebbe la vita in uno stato di ira cronica».
Diversi i racconti che ruotano intorno all’infatuazione di donne di mezza età per baldanzosi giovinetti (La promessa, Jane, La virtù): sebbene spesso siano sentimenti sinceri a innescare la scintilla il finale è quasi sempre drammatico, ma spesso diverso da come ce lo aspetteremmo – Maugham cerca sempre di spiazzare il lettore nelle battute finali, e sovente ci riesce. In altri sono, invece, gli interessi economici a generare una commedia degli inganni a cui, quasi a premiare la scaltrezza, viene concesso il lieto fine (Apparenza e realtà) o comunque una dignitosa resa (La pelle del leone). Soggetto privilegiato delle ironiche invettive di Maugham restano però le donne, attrici talmente abili da finire per credere loro stesse ai propri autoinganni, come Louise, la protagonista dell’omonimo racconto, o le amiche di Le tre donne grasse di Antibes; ma a rassicurarci che l’autoillusione non sia solo prerogativa femminile c’è il capitano Forestier della Pelle del leone.
Anche quando la scrittura tende a occhieggiare a generi diversi, come il giallo o il noir, la messinscena (e non la critica, è bene ribadirlo) dell’ipocrisia della vita sociale ne è lo sfondo imprescindibile; ne sono esempi la Coppia felice, Un filo di perle, Il sogno e soprattutto Prima della festa (il racconto più compiuto, e non a caso il più lungo, insieme a La virtù): in quest’ultimo, si ritrovano in un salotto madre padre e due figlie, di cui una è vedova da poco e rivela i retroscena tutt’altro che limpidi sulla morte del marito.
Quanto della distanza che Maugham riesce a mettere tra sé e gli altri, così come della sfiducia che sembra nutrire nel matrimonio, derivi dalla sua presunta omosessualità non è facile definirlo; il suo è, in ogni caso, un punto di vista mai banale attraverso cui rivivere alcuni aspetti dei primi decenni del Novecento e, inevitabilmente, riconsiderare gli “scandali” della contemporaneità.
![[Rubrica: Italian Writers Wanted #11]](https://m21.paperblog.com/i/289/2894652/rubrica-italian-writers-wanted-11-L-NfHdN5-175x130.png)





