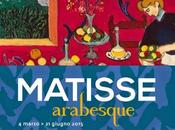Un giorno è capitato che io m’innamorassi.
A volte succedeva e durava poco. Poi finiva ed era come se non fosse mai successo.
Sapete, come quando da bambini costruivamo i castelli sulla sabbia e dopo, il mare li inghiottiva senza aspettare, senza chiedere il permesso.
Ecco, io m’innamoravo così, di solito.
M’innamoravo come i castelli di sabbia divorati dalle onde oppure come quelle traversate di alcuni clandestini, che finiscono e nessuno se ne accorge, quelle che la disperazione è troppa e annegano i corpi e cadaveri rimangono per sempre sul fondo degli oceani.
M’innamoravo di nascosto e non me ne accorgevo.
Poi un giorno, capitò che io m’innamorassi e quella volta fu diverso.
Diverso come quando è estate e si sente l’odore della pioggia, e le scarpe non servono, e si cammina a piedi nudi sull’asfalto bagnato.
Capitò che io m’innamorassi e allora dissi me ne vado. Me ne vado perché qui c’è troppo silenzio.
Avete presente il Sud? Il Sud profuma di erba. E qualche volte di pecore, specie quando il gregge attraversa la strada e devi fermare l’automobile per farlo passare. Il Sud mi piace, mi piacciono i tramonti in campagna e i sentieri con le pietre, le distese di cielo sui campi di papaveri quando passano veloci, la mattina, dai finestrini in corsa.
Però, quando quel giorno capitò che io m’innamorassi, dissi me ne vado, anche se il Sud è casa mia.
E poi c’era troppo silenzio. Ma non era colpa del Sud. Il silenzio è una difficoltà di certe anime in disagio.
Nella società di oggi essere felici è una specie di dovere. E quando c’è silenzio, il dovere pesa, pesa quanto la grandine sull’uva a Settembre.
Pesa che non ce la fai a sopportare l’immobilità, perché siamo soltanto povere e fragili piume, troppo leggere per soccombere sotto quest’impercettibile e meschina schiavitù gravitazionale.
Oggi chi non è felice, finge.
Fingono tutti, ogni tanto, per non mostrarsi deboli, per non restare soli.
Ciò che conta non è più chi sei ma che cosa sai fare, e oggi chi è felice, sa fare, sa fare molte cose.
Fare figli. Fare soldi. Fare fortuna. Fare viaggi. Fare l’amore.
Ed io, be’ io non sapevo fare molte cose.
Sapevo soltanto ascoltare le cicale quando fa caldo e vivere d’intense solitudini, sapevo guardare il cielo e parlare con gli alberi.
Poi sapevo innamorami.
M’innamorai di lui e fu per vendetta. La vendetta di chi cerca, illuso, di sopravvivere a se stesso, a quella solitudine che avanza e rimane, conquistandosi le ore e le storie e le vite e per sempre. Era la mia evasione, la seconda evasione eterna dopo quella che mi liberò dall’utero materno, la seconda evasione crudele che mi fece dire me ne vado. E me ne andai a rincorrere le nuvole, come i bambini che rincorrono gli aquiloni a primavera, come le foglie che d’autunno cadono e si perdono nel vento.
Mi guardò mentre lo guardavo e fu dramma.
Dramma come la vita.
Ero immersa, come tutti nella banale quotidianità dell’esistenza e, stanca, mi lasciavo manipolare dalla brutale impersonalità del sistema.
Il semaforo era rosso. Un groviglio di anime attendeva impaziente il momento giusto per attraversare la strada. Gli sguardi s’incrociavano senza comunicare e ognuno si manteneva fermo nella propria ristretta porzione di spazio. Sembravamo ombre ritagliate da un giornale, appiccicate frettolosamente l’una accanto all’altra sotto un cielo grigio e bidimensionale. E c’era silenzio, quel silenzio rassicurante dal quale cercavo di scappare, che avvolgeva le strade, imprigionando i movimenti e fissando le verità. Ero stanca di aspettare, aspettare lì ferma, mentre il divenire informe del mondo avanzava, avanzava incontrollabile e noi non volevamo accorgercene, per paura di rimanere coinvolti.
C’era un bisogno disperato di certezze. Così banali, così scontate, così sicure, così inumane.
Sembrano la consolazione di chi non può sapere, l’illusione dell’eterno, la presunzione dell’assoluto. Abbiamo inventato l’orizzonte perché anche il mare potesse avere un limite. Abbiamo rinchiuso il vento. Abbiamo imposto un nome a tutto. Abbiamo catalogato le nostre vite sperando di non confonderci nel caos. Le nostre case hanno i muri così come i nostri sogni hanno i confini.
Abbiamo costruito i navigatori satellitari perché perdersi non fa più parte dei piani. Eppure c’è chi perdendosi, scoprì l’America.
E mentre osservavo quegli uomini identici fra loro, annientati dal conformismo e incapaci di ribellarsi, lo vidi. Lo vidi che, sul ciglio della strada, distribuiva ai passanti le ultime pillole di utopia.
Allo scattare del verde quel groviglio statico di ombre divenne un flusso dinamico che avanzava sincronicamente mentre la pioggia ricominciava a bagnare le strade. Correvano tutti a cercare riparo, chi sotto le grondaie di rame, chi dentro l’autobus dell’ultima ora.
E mi sembrò di averlo perso tra la folla, lui che non si lasciò trascinare, come gli altri, dalla diabolica simultaneità di quei passi tutti uguali.
Mi voltai indietro, cercando il suo sguardo tra gli sguardi, e mi sorrise.
Era bello. E non bello come sono belli tutti, ma bello per davvero, bello come sono belle le rivoluzioni, bello com’è il cielo quando capita al tramonto di ammirarlo da lontano e passano d’un tratto gli aeroplani che dimenticano, incuranti, le loro bianche scie in mezzo ad una distesa di perfezione.
Mi avvicinai e gli dissi ciao. Indossava una strana giacca a quadri sopra una camicia stropicciata e al polso portava un braccialetto di ferro che ricordava l’India. I riccioli gli cadevano morbidi sulla fronte e nei suoi occhi si leggevano le arrischiate storie di un bohémien dissidente. Era un artista. Mi fece vedere alcune delle sue opere, quelle che aveva disposto con cura sulla sua bancarella d’esposizione vicino al semaforo. C’erano immagini che evocavano suggestioni psichedeliche, disegni dove la matita si perdeva nella carta e storie raccontate dalla luce. C’erano fotografie di corpi e ritratti di bambini. Quella che, più di tutte, mi colpì fu l’immagine di uno spazio vuoto. Era una stanza dalle mura pulite che sembrava irreale nella sua perfezione. La voce di lui entrò, d’un tratto, in quell’istantanea, riempendola di vita. É una metafora, disse. É la storia del nostro presente, silenzioso e fermo come le pietre, immobile e perfetto come la morte. Mi fece notare una porta semichiusa sullo sfondo, dalla quale entrava una timida freccia di luce. Era l’evasione. L’eroica fuga dalle millenarie menzogne, dall’immobilità stagnante, dai sistemi convenzionali. Dall’abitudine. Disse che potevo portarla via con me, perché tutti, ogni tanto, abbiamo bisogno di scappare.
Poi raccolse i suoi lavori e mi prese la mano. Passeggiammo per ore, dimenticai di tornare a casa, dimenticai che pioveva.
Gli dissi che scrivevo poesie e che ogni tanto parlavo con gli alberi. Non sembrò sorpreso, rimase affascinato. Disse che la mia voce sembrava una canzone e che i miei capelli profumavano di mare.
Poi restammo insieme. Non ce lo dicemmo con le parole e neppure con gli sguardi.
Forse lo capii dai suoi respiri e lui dalle mie mani.
Ci addormentammo su una panchina in mezzo al buio e in quel momento compresi che le nostre solitudini si erano incontrate.
Si chiamava Adrien ed era Francese. Parlava l’italiano con un accento buffo e, certe volte, quando sorrideva, sembrava un clown parigino della Belle Époque.
Andai a trovarlo spesso e trascorremmo insieme delle giornate intense.
Sperimentare l’intensità del tempo non capita sempre. Soprattutto di questi tempi.
La gente fugge dai momenti pieni, temendo di rimanere schiacciata e, rifugiandosi in quelle sterili routine, sperimenta la vacuità dell’esistenza e la tranquillità della sicurezza che rende tutto più prevedibile e controllabile.
Adrien era diverso. M’insegnò a respirare l’ingovernabilità delle forme, mi fece scivolare dentro quel magmatico fluire che è vita, vita crudele e mortale, vita che scorre e non si ferma, che attraversa, impetuosa, la fragilità dei nostri cuori. Adrien era innamorato dell’incostanza di quella corrente e m’insegnò a essere coraggiosamente felice, felice come quando passano gli stormi in mezzo al cielo o come quando piove a Maggio. Felice come atto estremo di estrema ribellione, come una scelta anarchica, come una consacrazione all’arte.
Lo seguii in quel suo viaggio folle e senza senso, abbandonai la mia casa, il mio paese e anche quella specie di lavoro in biblioteca che ero riuscita a conquistarmi.
Ci trasferimmo in Francia per qualche tempo. Io scrivevo poesie e lavoravo part-time come cassiera in una libreria.
Adrien si dedicava alla realizzazione di opere d’arte. Tenne degli workshop di fotografia e una volta decidemmo di organizzare una serata di reading. Invitammo giovani artisti, che avevamo conosciuto in qualche mostra vintage, e ci cimentammo nella lettura di poesie.
Ci innamoravamo ogni giorno e ogni giorno prendevo consapevolezza dell’amore.
Amore che è fatica e imperfezione, che non ha confini né pretese d’eternità. Che dura quanto dura il vento ed è la furia dell’uomo ma anche la sua debolezza più antica.
Amore che è carne, pura e vivissima carne, che pulsa e muore, che, lacerata dal tempo, si secca e, bagnata dal mare, rivive. Amore è quest’umana lotta tra vita e follia, è questa ebbrezza letale che scorre e scroscia e trascina e spoglia le nostre certezze, così assolute e così assenti. Non c’erano radici di metafisica purezza alla base dell’amore, ché questa è un’emozione tangibile, precaria come la vita, sporca come la carne, dolorosa come la morte, crudele come la notte, straordinaria com’è tutto ciò che nasce, s’ammala e muore su questa terra inquieta e dannata, esiliata per sempre dal cielo beato, dal sogno ingannevole, dalla tranquilla ed eterna stagione di un dio.
Andammo a vivere a Londra dove Adrien riuscì a organizzare una mostra importante. Sarebbero venuti artisti di fama internazionale e lui era emozionato.
Gli tremavano le mani e la notte prima non riuscì a dormire. Io lo osservavo in silenzio dal buio della stanza mentre realizzava nervosi collage di disegni. Il fumo della sigaretta si consumava a poco a poco attraversando, furtivo, la luce fioca che illuminava il tavolo da lavoro.
La mostra fu un grande successo.
Festeggiammo, ci ubriacammo e facemmo l’amore. Quella notte durò per sempre.
Io scrissi un libro visionario e Adrien mi disse che voleva viaggiare su una mongolfiera.
Le nostre giornate trascorrevano così, suggellate dalla nostra inarrendevole anarchia. Eravamo diversi dagli altri. Eravamo liberi. Condividevamo sogni e ascoltavamo canzoni, credevamo ancora nell’immaginazione nonostante il mondo avesse dichiarato guerra all’originalità.
Non so dove sia Adrien oggi, ci salutammo quando io partii per Buenos Aires. Trascorremmo l’ultima notte insieme in Italia, vicino al mare. Era autunno e le foglie avevano preso il colore del tramonto. Mi disse che non mi avrebbe dimenticata e poi restammo in silenzio a dirci addio.
Ogni tanto penso a lui quando guardo il mare, me lo immagino in giro per il cielo con la sua mongolfiera, pronto a sfidare il vento e gli aeroplani.
Devi avere il coraggio di scappare quando c’è troppo silenzio. Ed io scappai, scappai lontano senza fermarmi, scappai dall’omologazione e seppi difendermi ogni volta dall’abitudine ammuffita.
E se vi capiterà d’innamorarvi, innamoratevi. Adrien m’insegnò la libertà e io m’innamorai.
L’evasione vi guarirà dal conformismo. E sarete salvi. Salvi per sempre, oltre quei margini sbiaditi, oltre le convenzioni stanche.
A volte mi manca. Mi manca quel suo sorriso sghembo, mi mancano i suoi riccioli bagnati dalla pioggia. Mi manca quel ragazzo che mi regalò il suo cuore e m’addestrò alla vita.
di Maria Elena Petrelli, VIII classificata, Sez. Racconti All rights reserved
Nota biografica dell’autore
Nasce a Lecce il 27 Luglio 1993 e vive a Carmiano ( LE).
Frequenta l’ultimo anno del Liceo Classico “G. Palmieri” ed è alle prese con la scelta dell’Università.
Ama viaggiare, leggere e ascoltare la musica anni ’70.
Scrive dall’età di quattro anni.