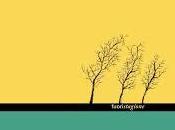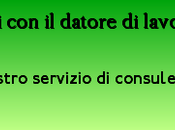Sebbene al Ravenna Nightmare, conclusosi il 2 novembre con la serata di premiazione, abbia ricevuto addirittura una Menzione Speciale della Giuria, la visione di Go Down Death è risultata in fin dei conti la più indigesta dell’intero concorso. Spiace un po’ dover essere così severi, se si considera che l’emotività in sala del regista statunitense Aaron Schimberg, un mingherlino dall’aria nervosa, impacciata e introversa, aveva suscitato in noi una certa empatia. Senza contare poi che proprio durante il Q&A le sue osservazioni, sollecitate da alcune domande del pubblico, hanno confermato la presenza di uno sguardo partecipe e non superficiale sulle miserie umane; qualità, questa, già in parte suggerita dalla vitalità delle intuizioni cinematografiche riversate nell’ultimissima parte del film. E’ un peccato, semmai, che per arrivare a quei venti minuti conclusivi, si debba passare per circa un’ora di straziante monotonia.
Dai cartelli iniziali si desume che Go Down Death sia concepito quale compendio delle macabre e morbose fantasie di Jonathan Mallory Sinus, un ipotetico scrittore. La libertà di questa traccia offre a Schimberg lo spunto per affrescare diversi quadretti, la cui impronta vagamente surrealista si fonde con disperate ricerche di affetto, scampoli di dissolutezza e divagazioni funeree. Gli ingredienti per incrementare l’inquietudine dello spettatore ci sarebbero eccome: dai desolanti dialoghi nelle stanze di un approssimativo bordello agli stranianti sviluppi delle scene nel bosco, dalle scabrose nenie che i personaggi intonano a turno (composte dal cineasta stesso, tra l’altro) a certi lombrosiani figuri operanti nel villaggio. Ma la ripetitività dei dialoghi e delle inquadrature affossa progressivamente la bontà degli intenti. Il gusto “lynchano” di certi siparietti si perde in discorsi queruli e in una ricerca figurativa sugli spazi, sul loro deragliamento dalla realtà, non più ispirata come all’inizio. Dopo un po’ si ha infatti l’impressione che, ad essere intagliati in atmosfere da frontiera americana, non siano realmente le derive di un immaginario surrealista pervasivo e tagliente, quanto piuttosto le riprese di un modesto teatro underground virato al nero, in una cornice dalle scenografie lievemente ansiogene. Troppo poco per giustificare una costruzione filmica dall’incedere così monocorde e pesante.
Verso la fine del lungometraggio la creatività del regista, fin lì così compressa, pare risvegliarsi. Il primo spunto degno di nota si lega all’intrigante sequenza in cui un pubblico becero, composto dai soggetti osservati in precedenza, giudica sguaiatamente le azioni dei pochi personaggi prigionieri di un altro schermo cinematografico, lasciando alla violenza di un gorilla il compito di venire incontro alle loro pulsioni più nefaste; unica eccezione al conformismo imperante, quel bambino dall’aria cresciuta che nei precedenti dialoghi con un medico, da parte sua cinico e fondamentalmente disinteressato alle altrui sofferenze, aveva fatto trapelare una diversa sensibilità. Quasi il ritratto di un’innocenza a rischio. E a seguire vediamo partire una finta sit-com intellettuale destrutturata abilmente in fase di montaggio. Ecco, invenzioni di questo genere lasciano intravvedere nel giovane autore una poetica dai tratti anche crudi, sinceri, ma non ancora in grado di coprire i cali di interesse e di ispirazione che, nella durata forse inopportuna di tale lavoro cinematografico, si fanno pesantemente sentire.
Stefano Coccia