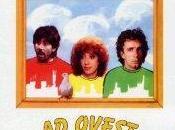— La questione, caro signor Annibale, è semplice, semplice. Noi, in questa faccenda, se non si rimedia, ci si fa una di quelle figure da vergognarci, tutte le volte che metteremo il capo fuori di casa nostra, a dire che siamo abitanti di questa ricca, di questa industriosa, di questa nobile Terra.
— Verità sacrosanta!
— Come! un paesucolo di duemilacinquecento abitanti appena, un borghettaccio d’affamati come Nebbiano, un branco d’accattoni deve avere la sua brava statua di marmo al suo concittadino…. al suo illustre concittadino! e noi, tremilacentosei anime, nè anche un piolo di pietra serena da mostrare a un forestiero che capiti nel nostro Paese?
— È una vergogna!
— Continueranno a vituperarci, e avranno ragione; ci chiameranno incivili, e nessuno potrà dar loro torto; ci additeranno come ingrati verso i nostri grandi, e non avremo argomenti per tappar loro la bocca; ce ne diranno di tutti i colori, caro signor Annibale, e noi dovremo abbassar la testa perchè….
— Quanto agli affari del decoro, dell’onore e di tutta questa roba da signori e da poeti, io, caro Falsetti, me n’occuperei poco. Si lascian dire e buona notte. Penso, piuttosto, ad un’altra cosa; penso all’utile che potrebbe venirne al nostro amato paese…. penso…. Ma che mi burla!… Ma ci pensa, lei, dato che si potesse arrivare allo scopo di erigere sopra una delle nostre piazze un monumento da fare strepito, il vantaggio che ne potrebbero ricavare gli alberghi, le trattorie, i caffè….
— O i vetturini?
— Giusto! o i vetturini?
E, infiammati dall’amore del luogo natìo, i due conoscenti, dopo essere arrivati perfino a credersi amici nel calore della discussione, si esaltarono talmente che, in pochi minuti, giunsero, d’amore e d’accordo, alla conclusione che anche il loro paese avrebbe avuto una statua, e che la statua sarebbe stata equestre.
— Sissignori, equestre! — esclamò il signor Annibale, guardando spavaldo e minaccioso ai colli di Nebbiano. — E crepino d’invidia tutti quelli che ci vogliono male!
— O equestre o nulla! Quel che ci va, ci vuole!
— Al naturale o più grande del vero?
— Più grande del vero, diavolo mai!
— Due volte?
— È poco.
— Quattro?
— Siamo d’accordo.
— Sta bene.
— Qua la mano.
— Ecco la mano.

Firenze
E, nel fervore dell’entusiasmo, non si erano accorti nè anche del signor Leopoldo il quale, seguendoli a breve distanza e avendo inteso tutto, alzò la voce plaudendo, e dichiarò solennemente che, se aprivano una sottoscrizione, lui si sarebbe subito firmato per cinque lire.
— Bravo signor Leopoldo!
— Grazie, signor Leopoldo. E ora, non per presunzione…. ma, se noi tre ci mettiamo all’opera sul serio, l’affare è fatto.
Con delle tempre d’uomini a quel modo, c’era poco da scherzare. Il giorno dopo fu messo insieme, nella giornata, un comitato di sette persone; e la sera erano già riuniti a discutere nello scrittoio del computista Machioni il quale, avendo un figliolo avvocato, s’era messo generosamente a loro disposizione, calcolando che da cosa nasce cosa. Fatta la nomina delle cariche e aperta la discussione, fu, per prima cosa, deliberato all’unanimità che la statua sarebbe stata equestre sul serio e, possibilmente, di bronzo; e fu anche convenuto che il monumento sarebbe sorto sulla Piazza del Plebiscito, sebbene alcuni avessero addotto delle buone ragioni per preferire la Piazza Cavour. Furono sciolti inni al patriottismo, al progresso dell’umanità, alle glorie paesane, e venne fissato il modo di raccogliere la somma occorrente, mandando in giroschede di sottoscrizione, ma facendo assegnamento, più che sopra ogni altra cosa, sulle tombole pubbliche, sulle fiere di beneficenza, sulle accademie che gratuitamente avrebbe dato la banda cittadina, e sulle recite dei dilettanti filodrammatici della Società Ernesto Rossi.
Intanto, seguendo il nobile esempio del signor Leopoldo, e dopo avere spiegato a quattro membri del Comitato che equestre voleva dire «a cavallo», firmarono tutti per una offerta di cinque lire.
— Mi pare — disse il presidente, stropicciandosi di compiacenza le mani — mi pare che il più sia fatto. E ora, prima di sciogliere l’adunanza…. Corpo di Bacco!… mi pareva d’avere qualche altra cosa da dire, ma ora…. con la testa un po’ confusa…. Ah! eccola. Dicevo io… E questo monumento, a chi lo facciamo?
Il silenzio che si sparse fra i radunati, dimostrò che l’osservazione era stata trovata acuta e meritevole d’attenzione; e atteggiati in pose da crepuscoli michelangioleschi, rimasero tutti fermi a pensare. Dopo un quarto d’ora buono, il professor Bandernoli, uomo di grande dottrina accoppiata a una rara modestia e a una condotta esemplare, chiese la parola.
— Parli.
— Fra le molte glorie paesane, tra le più immacolate, tra le più fulgide gemme intellettuali della seconda metà del secolo passato, io non esito, o signori, a pronunziare un nome…. il nome del canonico Palandri !
Una gran risata troncò la parola al Bandernoli il quale, roteando inveleniti quegli occhi abitualmente carichi di miele, batteva i pugni sopra la tavola, chiedendo di essere ascoltato.
— Ma no, ma no, caro Professore…
— Ma, via, Professore; un canonico a cavallo!
E giù, un’altra gran risata.
— Si abbandoni l’idea del cavallo — urlò il Bandernoli, scattando come una molla — si abbandoni l’idea del cavallo! Davanti a un nome come quello di un Agostino Palandri, si abbandona qualunque idea preconcetta;… e il riso, o signori, è una irriverenza indegna; è una profanazione sacrilega…. è…. oh! E io… io me ne vado.
— No, no, Professore.
— La preghiamo, signor Professore.
— Senta, senta; mi dia retta, Professore.
— Non sento e non do ascolto a nessuno. Scancellino il mio nome e quelle cinque lire, e io me ne vado.
E se ne andò davvero. Ma il giorno dopo, il vuoto lasciato dal professor Bandernoli fu riempito col nome di Celestino Chiavacci farmacista; nome caro ad Igèa per le sue inimitabili imitazioni delle pasticche Gérodel. Vorrei tesserne qui il meritato elogio, ma la sua rara modestia e il sentimento della mia incompetenza mi costringono a tacere.
Passarono tre mesi di inutili premure. Il professor Bandernoli non fu possibile tirarlo nuovamente alla fede.
— Faremo da noi! — disse il presidente.
E invitò il comitato per una nuova adunanza, nella quale, ai tre soli membri che intervennero, ritornò il fervore nell’animo e la sicurezza d’arrivare vittoriosamente allo scopo prefisso. Il maestro della banda mandò a dire che aderiva all’invito del Comitato purchè pensassero loro alla illuminazione e alle spese di servizio. Il direttore della filodrammatica Ernesto Rossi scrisse di accettare, chiamandosi onorato, ma libero da spese. Un gruppo delle più distinte gentildonne avevano espresso con una bella lettera la loro ammirazione per la nobile idea, e promettevano di mettersi subito all’opera per raccogliere doni e organizzare una fiera di beneficenza.
Tutte queste comunicazioni del presidente furono accolte da entusiastici applausi. E l’adunanza fu sciolta fra vivaci strette di mano, rallegramenti reciproci e allusioni di disprezzo, e abbastanza palesi, al professor Bandernoli e a quelli straccioni di Nebbiano.
Due mesi più tardi l’idea della statua equestre era andata all’aria. Girando per il paese si sarebbero ravvisati, anche senza conoscerli personalmente, i membri del Comitato e i loro aderenti, dallo sconforto che appariva sui loro volti. Uno scultore amico del presidente aveva scritto che, dando egli quasi gratuita l’opera sua, il monumento, tutto compreso e calcolato, sarebbe venuto a costare dalle cinquanta alle sessantamila lire.
— Sorbe! — disse il Falsetti, tastandosi il portafogli nella tasca di petto.
— Alla macchia! — esclamò il signor Annibale, schiacciando una cimice di bosco, quando il Machioni andò a dirglielo in giardino, dopo desinare.
— Ci ho gusto! — brontolò il professor Bandernoli, pensando che, soppresso il cavallo, forse si apriva uno spiraglio di probabilità per il suo canonico Palandri.
Il paese, in genere, sentì male la cosa. Le signore, poi, erano inconsolabili, e specialmente quelle che avevano già dato delle ordinazioni alla modista o alla sarta per andare in giro a raccogliere offerte.
— E allora, signori miei, che si fa? Mi pare che ogni esitazione sia inutile.
— Pur troppo!
— Bisogna piegare il capo dinanzi alla ineluttabile difficoltà, e rinunziare coraggiosamente all’idea del cavallo.
Questo diceva una sera il presidente ai membri del Comitato, che, mogi mogi, lo stavano a sentire. E l’adunanza si sciolse malinconicamente silenziosa.
La popolazione, adagio adagio s’era tutta interessata della grave questione; e, in ogni bottega e in ogni luogo di riunione serale erano discussioni, dove più dove meno, secondo l’ambiente, aspre e tumultuose. I socialisti tacevano minacciosi; gli anarchici preparavano i sassi da tirarsi alla statua appena fosse stata messa al posto; i clericali soffiavano discordia da tutte le parti dopo che era stata messa in ridicolo l’idea del Canonico equestre; i vetturini, i caffettieri e gli albergatori, brontolavano perchè svanite le loro più belle speranze d’un monumento sbalorditoio da chiamare gli Inglesi nel loro paese a branchi come le pecore; le persone civilmente equilibrate…. quelle non dicevano nulla perchè non ce n’era nè anche una.
Cioè!… No, non è vero. Dicendo che non ce n’era nè anche una, ho esagerato. Ce n’erano tre. Ma tutt’e tre si guardarono scrupolosamente di far palese il loro pensiero, per lo spavento di vedersi diradare gli avventori in bottega.
Il medesimo scultore aveva scritto al Presidente che per la sola statua in piedi, a grandezza naturale, ci sarebbero volute circa ventimila lire.
— Troppe! sempre troppe, permio baccone! — osservava il presidente ai membri del Comitato che lo stavano a sentire con la coda fra le gambe — sempre troppe, dopo le defezioni di chi ci aveva, con tanto slancio, promesso il suo appoggio…. Chi lo sa! Lo scultore, questo ve l’assicuro io perchè ci diamo del tu, lo scultore è un galantuomo dicerto. Mah! Io m’informerò meglio, sentirò magari da qualchedun altro, ma, secondo me, con tutti questi affari d’Affrica, ci deve essere stato un rincaro nel marmo.
La banda civica era entrata in un periodo di dissoluzione e, come quei vermi che a spezzarli diventano due, già dal suo seno era sorta una fanfara di dissidenti, tutti suonatori di strumenti d’ottone. I filodrammatici Ernesto Rossi si erano sciolti dopo che il loro presidente aveva preso le difese di quelli di Nebbiano quando ne bastonarono quattro quella sera che si azzardarono a passare dal paese in barroccino. Le signore dissero che a stare in mezzo a quella cagnara ci andava del loro decoro e dichiararono che, se qualcuno voleva la fiera di beneficenza, se la facesse da sè.
Quando fu tastato il Sindaco per sentire se si sarebbe adoprato a ottenere dal Comune un sussidio per un monumento da erigersi alla memoria di…. di…. (a questo ci si sarebbe pensato dopo), il Sindaco rispose che ben volentieri lo avrebbe fatto, ma a cose definitivamente stabilite. Il deputato al parlamento e il consigliere provinciale, badando a non perder voti nel caso di nuove elezioni, promisero il loro caloroso appoggio, lodando la patriottica iniziativa, degna veramente del nobile collegio che altamente si onoravano di rappresentare.
Ma, nonostante la buona volontà spiegata da tutti, le cose non andavano punto bene. Il presidente fu costretto a dimettersi per causa di gravi scissure sorte in seno del Comitato dopo quella benedetta questione fra la Misericordia e la Pubblica assistenza…. una questionaccia, via…. Già è meglio non parlarne.
Ne fu sostituito un altro: il veterinario Trabalzi, una specie d’uomo di paglia, come lo credevano il Falsetti e il Machioni; ma il bravo Trabalzi aveva le sue idee e le sostenne. Accettò, ma, a condizione che si parlasse d’un busto e non d’una statua, poiché lui a fare il pagliaccio non c’era avvezzo e, quando s’era ingolfato in una impresa, lui non era uomo da tornare indietro.
Sotto una mano di ferro come quella del nuovo presidente, pareva, dopo un paio d’adunanze, che le cose accennassero a una piega migliore; ma tutti i nuovi progetti andarono in fumo quando un altro scultore ebbe scritto che un busto di marmo sopra una colonnetta di bardiglio, sarebbe costato duemila lire circa.
— Che ladri questi scultori! — disse il presidente Trabalzi, sbacchiando con impeto la lettera sul tavolino.
— Quanto a quello che lei chiama «un ricordo marmoreo qualunque» — aggiungeva in un poscritto lo scultore — gradirei una spiegazione. Se si trattasse d’un medaglione, si può andare, secondo le dimensioni, dalle cinquecento alle mille lire. Trattandosi di altra cosa, me lo sappia dire, e io sarò fortunato di mettermi a sua disposizione.
— Che concludiamo, signori? — domandò il presidente Trabalzi, interrogando l’accigliato uditorio..
In poche battute fu concluso tutto e, questa volta, finalmente, in modo definitivo. L’uomo da onorarsi col monumento era stato trovato. Il busto sarebbe stato eretto al nonno del Trabalzi, a quel gran benefattore il quale, sessant’anni addietro, aveva impiantato la florida industria delle mattonelle lucide di asfalto impenetrabile per le terrazze scoperte.
Venuti ai voti, furono tre favorevoli e tre contrari, essendosi astenuto, per un riguardo delicatissimo e che gli fece tanto onore, il nipote del grande industriale. A una seconda votazione: lo stesso; a una terza: lo stesso. Bisognò abbandonarne l’idea. Rifece allora capolino il nome del canonico Palandri, ma gli fu opposto, e prevalse subito, quello di Garibaldi, non tanto per fare un dispetto al professor Bandernoli, quanto perchè si era venuti a risapere che uno scalpellino d’un paese sopra a Firenze, che si chiama Fiesole, ce n’aveva uno di pietra serena avanzatogli dal tempo della Capitale e che avrebbe potuto rilasciarlo, messo e murato al posto, per trentacinque lire, cioè quante erano quelle già versate dal Comitato nelle mani del Cassiere.
Il giorno per l’inaugurazione: la festa del titolare; il posto dove collocarlo: una nicchia nella facciata del palazzo comunale. La sera di poi gli affari del Comitato si trovarono al medesimo punto di quando avevano incominciato, perchè il Sindaco si oppose energicamente al progetto di deturpare con una nicchia la facciata storica del palazzo comunale, e non ci fu verso di poterlo smuovere.
— Mettiamolo di faccia, nella casa del Tempesti.
— Già! e io vi lascio sfondare il muro. Quanto mi date? — rispose il Tempesti quando il Comitato, rappresentato dal suo segretario, andò a domandargliene.
Dopo una violenta protesta, nella quale ne toccarono di mattonella anche gli abitanti di Nebbiano, il Comitato si sciolse e, alla unanimità, fu deciso di spendere le trentacinque lire in una bella cena, mandando al diavolo tutti quelli che per filantropia o per amor patrio si occupano di far del bene al proprio paese.
— Una bella cena da Beppe del Cervo d’Oro! e questa è la minuta. Tieni, Bavetta (Bavetta era il giovane di banco del computista Machioni) portagliela e digli che stasera alle nove precise saremo da lui.
Bavetta tornò dopo poco a dire che stava bene ogni cosa e che alle nove potevano andare. Ma una mezz’ora dopo, Beppe del Cervo d’Oro, il quale aveva fatto meglio i suoi conti, mandò un ragazzo a dire al Presidente che scorciassero la minuta o allungassero il prezzo perchè lui, per cinque lire a testa, tutta quella roba non gliela poteva dare.
( Renato Fucini, Il Monumento, tratto da “All’aria aperta”, 1897 )