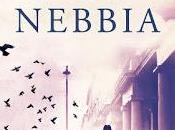Quando il sole piomba infocato sulle groppe stridenti delle cicale, e il ramarro, celere come l’ombra d’una rondine, attraversa a coda ritta la via; o nel tempo che la bufera arriccia e spolvera all’aria l’acqua delle grondaie ficcandoti nell’ossa il freddo e la noia, lo spaccapietre è al suo posto. Un mazzo di frasche legate a ventaglio in cima d’un palo lo difende dal sole nell’estate; un povero ombrello rizzato fra due pietre e piegato dalla parte del vento, lo ripara dalla pioggia nell’inverno. Il barrocciaio che la mattina passa scacciando con una frasca i tafani di sotto alla pancia del mulo trafelato, gli dà il buon giorno; il contadino, tornando la sera fradicio e intirizzito dai campi, gli augura la buona notte.

Lucca – Scalpellini al lavoro nelle strade del centro di Lucca – Foto tratta da “Come eravamo-Lucca” – Ed. Il Tirreno
E all’ombra di quelle frasche o sotto il riparo di quell’ombrello, seduto sopra una pietra bassa e quadrata, consuma le sue lunghe giornate, finché la massa di macigni che la mattina stava alla sua sinistra non è passata all’altra parte, ridotta dal suo pesante martello in minuti frantumi di breccia acuta e tagliente.
Allora egli è contento, perché ha guadagnato gli ottanta centesimi che gli paga puntualmente l’accollatario del mantenimento della via. Ma non sempre gli va così. Non perché l’accollatario, che è un vero galantuomo, sia capace di defraudarlo; ma perché molte sono le cause che possono assottigliargli il guadagno o allontanarlo affatto dal lavoro. Di frequente la pietra che ha da spezzare è troppo forte, e il lavoro non gli comparisce; qualche volta gli si guasta il martello, e perde tempo a riadattarlo; non di rado nell’inverno il maltempo infuria così impetuoso che lo scaccia dal lavoro; spesso, quando il sole d’agosto è troppo rovente, è costretto a cercare d’un albero e quivi all’ombra riposarsi, perché sente che le forze gli mancano; qualche altra volta, col braccio tremante per la stanchezza, e questo accade più spesso, cala il martello in falso e si percuote sul dito, ammaccandoselo sempre dolorosamente, non di rado fino al sangue. E in quel caso gli tocca a fasciarsi o a correre alla più vicina fontana, se pure non deve abbandonare il lavoro, perché lo spasimo non gli permette di continuare. E i cinquanta e gli ottanta centesimi allora non vengono, e la fame si ferma alla sua casa e lo veglia e l’assiste e non l’abbandona, finché non l’ha ricondotto estenuato e pallido presso il monte di pietre che da otto giorni l’aspetta lungo la via.
E quella sera mangerà; mangerà poco, perché poco potrà lavorare; ma l’accollatario, che per fortuna è un vero galantuomo, gli misurerà puntualmente il lavoro fatto, e puntualmente gli darà i suoi venti o trenta centesimi trascurando i rotti in più della misura, perché lui a queste piccolezze non ci bada; ha trattato sempre bene chi lavora, e se ne vanta.
Io ne conosco uno di questi splendidi esemplari di carne da lavoro. Ah! ma questo che conosco io è stato sempre un signore, il Creso degli spaccapietre, perché fino a sessant’anni sonati, stomaco di cammello e muscoli di leone, ha guadagnato sempre il massimo che può fruttare il suo lavoro, e la polenta gialla o il pane bigio non sono mai spariti altro che per eccezione dalla sua tavola.
E i suoi colleghi lo rammentano con ammirazione, e raccontano ai loro amici attoniti come tutto l’inverno del ’57 fu capace di spezzare due metri cubi arditi di pietra ogni giorno che Dio metteva in terra, senza mai fumare, senza bere un dito di vino e senza ammalarsi.
Ma le sue mani paiono due pezzi informi di carne callosa, il suo viso, screpolato piuttosto che solcato da rughe, pare un pezzo di pane da cani, e i suoi occhi, dopo tanti anni di sole, di polvere e d’umidità, sono contornati di rosso e gli lacrimano di continuo nelle occhiaie infiammate, che la notte gli bruciano e non gli dànno riposo. Ha le gambe torte e rigide dal lungo starsi a sedere, la schiena fortemente curvata, il corpo intero di mummia, lo spirito consumato dai dolori.
Se gli domandi delle sue sventure, egli ti agghiaccia col racconto freddo e conciso che, tra un colpo e l’altro del suo martello, te ne fa come di cose che debbano necessariamente accadere.
La sua figliola maritata partorì alla macchia dove era andata a far legna, e fu trovata morta lei e la creatura; il genero, che pareva tanto un buon giovane, scappò con una donnaccia e finì per le prigioni dopo avergli lasciato un nipotino che era la sua consolazione. Ma anche quello il Signore lo volle per sé, perché si vede che non lo credeva degno di tanta fortuna.
Quando parla della figliola e del genero, non dà segni di commozione; ma se rammenta il su’ povero Gigino posa il martello, si prende la testa fra le mani e, dondolandola come fa l’orso nella gabbia, racconta la sua fine pietosa.
Aveva già cominciato a menarlo con sé a spezzare, perché era un ragazzetto che per la fatica prometteva dimolto, quando un giorno, povero Gigino! non potendo più reggere dalla sete che lo tormentava dopo aver mangiato una salacca senza lavare, entrò in un campo e s’arrampicò sopra un ciliegio. Sopraggiunse il contadino gridando da lontano; il bambino per scender presto, cadde, si fece male a una gamba, non poté fuggire e fu mezzo massacrato dal contadino che lo raggiunse. Parte per lo spavento, parte per le percosse, dopo quindici giorni gli morì di convulsioni, che tutti non fecero altro che dire «Peccato!», perché delle creature belle a quella maniera non era tanto facile vederne. Finito il racconto, rimane un momento fermo a pensare; poi ripiglia il martello e continua il suo lavoro.
La sua donna è cieca da un occhio, e di quella disgrazia la colpa l’ha tutta lui, perché, se ci avesse badato, non sarebbe accaduta. Quando le gambe la reggevano, la mattina andava a chiedere l’elemosina, e, se aveva fatto qualche tozzo di pane, verso il mezzogiorno glielo portava dove era a spezzare e si fermava lì a tenergli un po’ di compagnia; e qualche volta, in tempo che lui mangiava, si metteva lei a spezzare, tanto per non perder lavoro.
Una mattinaccia, in tempo che la su’ donna svoltava la pezzòla del pane, passò un signore in calesse che buttò via un mozzicone di sigaro acceso, il quale andò a cascare vicino al monte de’ sassi. La donna si chinò per raccattarlo e porgerlo al marito, e in quel tempo una scheggia d’alberese la colpì nell’occhio e l’accecò senza rimedio. Da quella mattina non è stata più lei: gli dole sempre il capo, non si regge più ritta dalla debolezza e non sa come curarsi, perché il dottore non gli ha ordinato altro che carne e vino generoso. E ora passa le sue giornate sull’uscio, seduta a chiedere la carità ai viandanti; ma da che hanno fatto la strada ferrata non passa quasi più nessuno, e spesso, dopo essersi accostata, mezza cieca, a chieder l’elemosina a chi le viene incontro per chiederla a lei, vede andar sotto il sole senza aver fatto né un centesimo né un boccone di pane. Allora, s’accuccia per abitudine accanto al fuoco spento, dove, aspettando il marito e dicendo la corona, s’addormenta.
Un giorno che, meno brusco del solito, mi parlava delle sue miserie, dei suoi bisogni e delle sue privazioni, gli domandai quasi scherzando:
«Dimmi: se tu potessi in questo momento ottenere tutto quello che ti paresse, che desidereresti?».
«Una fetta di pane bianco per darlo inzuppato alla mi’ vecchia che non ha più denti!»
Ma quando quest’uomo s’ammalerà, il medico, andando a suo comodo dopo la terza chiamata, lo troverà agonizzante; il prete invitato per carità a spicciarsi, vorrà finire il suo desinare e lo troverà morto; il becchino, guardandogli i piedi scalzi e il camicione topposo, gli reciterà la breve orazione: «Accidenti a chi ti ci ha portato!».
(Renato Fucini, Il matto delle giuncaglie, in Le veglie di Neri: paesi e figure della campagna Toscana, 1882)