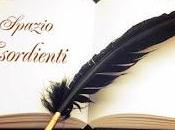Salento d’argilla: embrici
10 dicembre 2014 di Redazione
di Riccardo Viganò

I motivi dell’uso tradizionale di coppi, più raramente di mattoni, nell’edilizia salentina sono da motivabili dall’esiguo costo dei materiali impiegati. Il loro era un utilizzo diffuso in tutte le categorie sociali e, in particolar modo, anche per le coperture degli ultimi piani dei palazzi nobiliari.
Girolamo Marciano (1571-1628) nel secondo volume della sua imponente opera “Origini e successi della provincia di Terra d’Otranto” (Napoli, 1855) , descrive le dimensioni, i confini, l’ambiente naturale e umano di Terra d’Otranto annotando interessantissime notizie su fenomeni geologici, litologici e carsici propri della provincia. Parlando dell’argilla dice:
«Si trova anche in questa Provincia la Rubrica Sinopia eccellentissima, e la fabbrile dell’una e dell’altra specie in abbondanza, e l’argilla, ovvero creta bianca, della quale si lavorano e fanno i tetti per coprire le case, che il volgo chiama imbrici, imitando l’etimologia ed il nome latino Imbrices, ab imbrium defensione […]»
Pochi, tuttavia, ne conoscono il ciclo produttivo e chi vi lavorava. Di norma la modellazione del coppo o “imbrice”, operata da un ceramista definito a volte “inbriciaro” avveniva a stampo, mediante l’utilizzo di un telaio in legno nel quale l’argilla, grossolanamente depurata e frammista a paglia, veniva pressata e appiattita fino ad essere ridotta ad una sfoglia. Al di sotto del telaio veniva posta una forma semicilindrica sulla quale l’argilla lavorata era stesa per assumerne il contorno.
Sfilata la forma ne restava il coppo modellato nella sua curvatura e l’artigiano lo lasciava immobile fino a essiccatura completata. Fino agli inizi del XX secolo, nel periodo stagionale estivo-autunnale, capitava spesso di avvistare in lontananza nelle campagne delle sottili colonne di fumo azzurrognolo. Questo fumo, il cui odore impregnava l’aria per settimane, proveniva dalle fornaci per laterizi. Esse erano poste fuori dai numerosi centri produttivi e per la maggior parte dislocate nell’area meridionale della penisola salentina dove l’argilla abbondava. Grossi centri di produzione erano Lecce, Salice, Novoli, Nardò, Torre Paduli e, in particolare, San Pietro in Lama conosciuta appunto come “San Pietro degli imbrici” e Cutrofiano ovvero quel notissimo grande centro pre-industriale di produzione di massa.
La produzione del laterizio non aveva bisogno un’altissima tecnologia a differenza della ceramica di uso comune o per la più pregiata maiolica. Le fornaci per laterizi, che assomigliavano a delle carbonaie, erano fosse rotonde o quadrate realizzate scavando nel terreno, a poca profondità , e nel cui interno venivano disposti, impilati a strati, i coppi sfasati tra loro e posti di taglio per poter permettere il passaggio tra di loro dei gas caldi. Il combustibile per la cottura degli imbrici e dei laterizi consisteva generalmente in carbone di legna il quale veniva mescolato ai coppi che, a loro volta, venivano ricoperti da altro combustibile e da una coltre di terra mista a cenere che fungeva da isolante termico. L’accensione avveniva in un angolo del cumulo da dove il fuoco, a differenza delle fornaci ceramiche, procedeva lentamente a seconda dei fori realizzati nel manto protettivo che consentivano il tiraggio. Da questi fori l’addetto alla fornace regolava lo stato di avanzamento della cottura. Quando notava all’interno una massa incandescente, chiudeva i fori con delle secchiate di terriccio e di seguito ne apriva degli altri. Questa procedura veniva seguita fino a che il fuoco non aveva cotto tutto il cumulo. La durata della cottura poteva dipendere dal quantitativo ma, comunque, non superava le venti ore. Dalle irregolarità del tiraggio e della temperatura potevano dipendere quelle caratteristiche diversità di colore che, a volte, erano molto accentuate. Queste irregolarità provocavano quei contrasti cromatici molto spesso accentuati. Dalle fosse, una volta raffreddate, uscivano coppi dalle tonalità variegate che spaziavano dal nocciola al rosso scuro al rosa.
Una volta vendute e collocate, i tetti apparivano screziati assumendo una pregiata e armoniosa tonalità. Le figure professionali legate a questo ciclo produttivo venivano chiamate, come già detto, “imbriciari”, ma di solito non era l’unica categoria professionale legata all’argilla ad esserne interessata. Di certo i “cotimari” e i “cretaluri” non disdegnavano la produzione di laterizi in generale. Anzi, i più importanti “faenzari” utilizzarono le loro fornaci anche per questo uso al fine di rimpinguare le entrate della loro attività. Come dimostrano gli atti processuali presso il Giudicato di pace di Nardò nel 1834, si legge che il faenzaro neretino Giuseppe Perrone intenta una causa per “settecento mattoni cotti e crudi non pagati”.