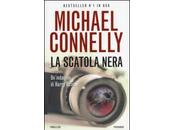Ho appena appreso della morte di Cossiga. Le immagini del TG 3 vanno agli scontri di piazza del degli anni settanta, insistono sui fotogrammi della manifestazione del 12 maggio del ‘77, quando venne uccisa Giorgiana Masi. Il poliziotto travestito da ‘dimostrante’, con la pistola in mano, che si muove tra i suoi colleghi, guardando dall’altra parte della ‘barricata’. Chi ha sparato il colpo che ha ucciso la studentessa non s’è mai trovato, ma la rivendicazione della strategia di provocazione, che cercava il morto, Cossiga, che allora era ministro dell’interno, l’ha fatta. Dopo 30 anni. Per vincere la guerra degli anni 70 fu necessario mentire, stravolgere, ‘travestire’ il senso delle parole. Cossiga ha ammesso di aver appiccicato il concetto di terrorismo addosso ai gruppi sovversivi dell’estrema sinistra, quelli che hanno provato a rovesciare l’ordine costituito con la lotta armata. Per fermare quella marea del dissenso non era sufficiente l’uso disinvolto e deciso della violenza dello stato, era necessario decostruire il soggetto sovversivo, consegnarlo ai media e all’opinione pubblica come mostro assetato di sangue, votato al terrore, determinato da forze oscure e incomprensibili, che si alimentavano di follia e crudeltà. Se questa strategia fu il frutto esclusivo della sua mente o fu abilmente suggerita da consiglieri americani o della P2 non ci è dato sapere, di sicuro c’è che funzionò e i suoi effetti continuano a funzionare, nonostante il pericolo sovversivo sia scomparso e l’inventore dello slittamento semantico della parola “terrorista” ne abbia svelato la strumentalità e falsificazione. Continua a funzionare anche in ambito cinematografico.
Ad onor del vero un certa ambivalenza linguistica la parola “terrorista” la possedeva sin da prima degli anni ‘70. Nel 1963 De Bosio, anche sulla scorta di esperienze dirette, dirigeva Il terrorista, in cui Gian Maria Volontè interpretava un partigiano azionista che aveva deciso di proseguire la lotta ai tedeschi, attraverso l’uso di azioni dinamitarde, tese a provocare il maggior numero di vittime tedesche e a diminuire il senso di sicurezza nella città occupata. Il film si sofferma sul rischio, poi determinatosi, di colpire anche persone non direttamente coinvolte nell’esercito nazista (o, addirittura, totalmente estranee). Il terrore (tra i tedeschi) era proprio uno degli effetti che quelle azioni si prefiggevano, ed un rischio di produrre danni collaterali era presente. Dunque, il nome “terrorista” non era improprio, e non conteneva intenti diffamatori nei confronti del protagonista. Sebbene la sovversione dell’estrema sinistra in Italia non utilizzò mai tecniche di violenza indiscriminate o potenzialmente tali, a differenza dell’estrema destra che le elesse propria principale forma di lotta, s’invalse l’uso (e Cossiga se ne intestò la titolarità di tale falsificazione) di accomunare sotto la stessa etichetta di “terrorismo” ogni azione violenta diretta a destabilizzare l’ordine costituito. Al punto che oggi s’utilizza questa parola comunemente in tale variante. Difficilmente il cinema è riuscito a riportare la dialettica sulla questione alle sue reali posizioni. Molto più comunemente ha aderito alle versioni più distorte o superficiali. Tale criticità trova probabilmente una motivazione nella saldatura che la DC e il PCI ebbero su tale fenomeno, propendendo entrambi per una lettura ‘misterica’ (e falsificatoria) del fenomeno. Anche se occorre dar adito al PCI di aver raggiunto un livello raffinatissimo in tale operazione. Ne è forse l’esempio più lampante il film Piazza delle cinque lune (2003), che vede collaborare due esponenti di opposti versanti politici, essendo la regia curata da Renzo Martinelli e la consulenza storica dal parlamentare comunista Sergio Flamigni, già membro della commissione Moro ed autore del documentatissimo volume La tela del Ragno. In questo film trova sfogo tutta la teoria ‘complottista’, che svuota il fenomeno sovversivo, di ogni valenza politica endogena.
Per chi non s’è voluto adeguare alle letture dominanti, ma neppure azzardarsi ad affermare apertamente l’autonomia del fenomeno sovversivo, restava aperta la strada della lettura interiore e metaforica del fenomeno. Su questo versante si collocano due opere di Marco Tullio Giordana. Con La caduta degli angeli ribelli (1981) si estremizza la lettura psicologica delle motivazioni politiche. Ne fuoriesce un quadro estetizzante di ammiccamenti tra il dandy e il nichilista, che diceva pochissimo, e in modo fuorviante, sul fenomeno politico. Giordana aveva già trattato l’argomento con Maledetti vi amerò (1980), ambientato all’indomani dell’omicidio Moro, in epoca di riflusso. Questa volta, con molta più maturità, si guarda alle rovine di una generazione che aveva provato a cambiare il mondo, ma ne esce profondamente decomposta, e così poveramente defluisce negli anni 80. In questo film l’omicidio Moro assume il ruolo di evento di rottura, una sorta di punto di non ritorno, che impone ad ognuno di collocarsi su un versante della faglia, consapevoli che entrambi i fronti erano privi di speranza, riproponendo un’operazione già tentata, anche con successo, da Monicelli con il suo Caro Michele (1976), film sulla generazione post-68, tratto dall’omonimo libro del 1973 della Ginzburg. In tempi più recenti un’altra pellicola riparte dalla vicenda della morte di Moro per riprovare a narrare quegli anni, è Buongiorno, notte (2003) di Bellocchio. Qui, se da un lato si riesce a cogliere con straordinaria intensità la portata storica di quell’evento, dall’altro non si riesce ad emanciparsi da una lettura fortemente psicologica della natura degli autori di quel gesto (vengono ripresi come ipnotizzati a recitare collettivamente a guisa di ‘mantra’ uno slogan politico). Rischiando di perdere la ricchezza di complessità che s’era addensata sulla protagonista (la sceneggiatura prende spunto anche dal libro della BR Traghetti del 2003, Il prigioniero), combattuta tra dubbi e contraddizioni sulla sua militanza politica, sostenuta sia dal desiderio rivoluzionario, sia dalla pietas umana. Tra i film che scelgono uno sguardo interno/metaforico si iscrivono anche La tragedia di un uomo ridicolo (1981) di Bernardo Bertolucci e Colpire al cuore (1982) di Gianno Amelio. Il film di Bertolucci squaderna una dura critica sociale alla borghesia, ma i sovversivi, ‘gli altri’, non vengono mai inquadrati; sembra inverarsi la paura di rappresentarli di cui parlava Gaber nel suo Io, se fossi dio (1980), in cui ricorda come venissero definiti anche “gli innominabili”. Al film di Amelio va riconosciuto il merito speciale di aver realizzato un’opera straordinariamente matura, nonostante fosse il suo primo film in cui, con mano leggera, ma sicura, riesce ad evidenziare la frattura sociopolitica della lotta armata, attraverso un’efficacissima metafora famigliare che restituisce la devastante verticalizzazione dal politico al personale; riuscendo dove aveva fallito Dini Risi con il suo Caro Papà (1979).
Chi non ha scelto di stare dentro questo schematismo duale ha preferito svolgere opere di impianto documentale come Giuseppe Ferrara con i suoi Il Caso Moro (1986) e Guidò che sfidò le Brigate Rosse (2007), anche se nel primo caso il rilievo storico conferito ai documenti provenienti dalla commissione parlamentare sul caso Moro è pur sempre una scelta dalla parte della verità di stato (ovvero del duopolio DC-PCI); oppure trattare l’argomento con atteggiamento disinvoltamente superficiale, è il caso di L’anno del terrore (1991) di John Frankenheimer e Concorso di colpa (2005) di Claudio Fragasso.
Solo di recente il cinema ha cominciato ad assumere uno sguardo autonomo (dalla verità di stato) sul fenomeno della sovversione armata, utilizzando significativamente anche gli sguardi dei protagonisti di quella storia, è il caso di La prima Linea (2009) di Renato de Maria, che prende origine dal libro del fondatore di Prima Linea Sergio Segio, Miccia Corta (2005), in cui si ripercorrono le ultime azioni degli uomini che erano appartenuti a questo gruppo, rievocando anche le loro motivazioni e i loro percorsi. Dal canto loro, gli esponenti del governo hanno provato, secondo le loro possibilità, ad ostacolare questa pellicola che ha il merito di riprendere la narrazione di un fenomeno, rendendosi libera di scegliere le proprie fonti. In fondo era questo il segnale che volle lanciare Cossiga negli ultimi anni. L’uomo che utilizzò la violenza sui dimostranti e sui poliziotti, che falsificò le idee dei suoi avversari, che in nome della ragione di stato fu pronto anche al sacrificio della vita di Moro, riconosceva che quel tempo era finito (pur continuando a difenderne la legittimità politica e riproponendone la validità all’occorrenza), che quelle ragioni avevano cessato di esistere, che occorreva rendere omaggio alla verità. E’ tempo che anche il cinema italiano racconti questa storia.
Pasquale D’Aiello