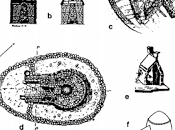Anna Lombroso per il Simplicissimus
Anna Lombroso per il Simplicissimus
Uno spettro si aggira per il mondo. Forse una febbre: in India decine di migliaia di persone si mobilitano contro la corruzione che si è annidata nelle istituzioni, nella macchina della pubblica amministrazione e nei partiti politici. In Grecia, in Cile, in Gran Bretagna, in Spagna, in Israele fermenti vivi vitali e rabbiosi denunciano insoddisfazione di bisogni primari. Se per primari non intendiamo solo il pane, ma anche l’istanza consapevole di volersi riprendere il futuro. E vale anche per il nord Africa infiammato da incendi che rivendicano equità e democrazia.
C’è una cifra universale di opposizione a contro il modello di sviluppo che nell’affermarsi ha scardinato sta distruggendo le basi stesse della convivenza civile, della democrazia a disingannando quella illusoria aspettativa di un capitalismo ben temperato fino a diventare se non equo, almeno “armonioso”. Caduta la speranza “ragionevole” di un sistema economico capace di combinare le esigenze del profitto con quelle della società – addirittura visto con una certa benevolenza, dicono gli studiosi, perfino da Marx con l’esempio del direttore d’orchestra che non ha bisogno di possederla, a proposito di una possibile evoluzione pacifica manageriale verso il socialismo – è precipitata anche la visione di una possibile e prossima età dell’oro planetaria.
All’utopia si è sostituita la collera. E per quanto ci riguarda ne siamo tutti un bel po’ responsabili: il dispotismo della realtà come uno stolido bulldozer ha raso al suolo qualunque cultura politica in grado di opporre resistenza, ha annientato ogni traccia di memoria che non sia metabolizzabile dal primato dello spettacolo e del consumo, ha messo ai margini ogni soggetto sociale che non fosse integrabile. Nella convinzione diffusa di interpretare così la forza delle cose. Eh si, è il mercato, bisogna essere realisti, è necessario avere un approccio dogmatico e regolativo, come se il pragmatismo dovesse necessariamente sconfinare nell’accorto e “modernista” cinismo. È così che la politica è venuta meno alla sua missione e alla sua vocazione: la resa al reale è quanto di più impolitico si possa immaginare se per politica s’intende l’arte della trasformazione della realtà.
Si essere indignati non basta. È importante simbolicamente segnare il territorio di tutti in modo che nessuno si permetta di impartirci dall’alto di qualche luogo istituzionale o da qualche giornale influente e autorevole, la lezione sul bene comune, sull’impegno civile e sulla buona cittadinanza, perché ogni legittimazione è finita. E ormai preferiamo gli apolidi, gli esuli mentali, come forse con una certa fierezza mi sento anche io.
Ma per uscire dal disagio dell’inciviltà bisogna oltrepassare la collera, sottrarsi alla pedagogia della disumanità e alla somministrazione avara di segmenti oculati di diritti. Un tempo per farlo ci si metteva dalla parte “sbagliata”, da quella di chi non ha garanzie o rappresentanza e è escluso dalla partita della democrazia mediatica plebiscitaria e disciplinare dalla quale è assente qualsiasi responsabilità civile e politica. Adesso non dobbiamo interpretare il ruolo della emarginazione e della esclusione: si estende sempre di più la schiera dei penalizzati, di chi sente una tremenda “perdita” di sicurezze e privilegi, concreti e ideali.
I diritti cui aspirare e da conquistare e quelli ottenuti non sono più acquisiti in forma universale, ma semmai concessi e somministrati in modo selettivo. Chiamiamolo come vogliamo, è in corso un cruento conflitto sociale e di classe, nel quale i detentori del potere, che ha sempre le stesse fattezze, fanno professione di ruere in servitium dei mercanti e del mercato, in un totale vuoto di idee che non sia la difesa dell’iniquità, nell’assenza di un progetto che non sia accumulazione, facendo legge del principio: guai agli ultimi.
Sarebbe grottesco, ridicolo, il loro dibattersi come pesci nella rete di una finanza criminale, minacciati dal nostro malcontento, impauriti di cedere anche le briciole dei loro beni per via di quelle che quella sciagura in sottanina chiama le tasse esotiche. Ma c’è poco da ridere, se la nostra indignazione si consuma alla tastiera. Se chi dovrebbe rappresentarci teme uno sciopero. È il momento di una secessione dalla complicità, dell’arrendevolezza, è il momento di cantare un’altra canzone, fuori dal loro coro. Nei consumi, nelle letture, nel disubbidire al video e a certe leggi, nello scegliere la parte giusta, che poi è sempre la stessa, nel combattere l’evasione anche sottraendosi a piccole occasioni redditizie e a certe, apparenti, innocenti evasioni, nel non soggiacere alla fascinazione della furbizia, anticamera dell’abuso e dell’illegalità.
Si è molto più scaltro riprendersi la vita, il pensiero e le ragioni del futuro, ci hanno derubato per troppo tempo e non possono più fare i furbi con noi.