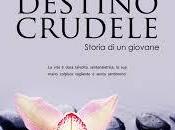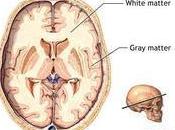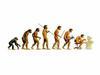[Seconda puntata della Rubrica Nella pancia del drago]

Suvvia, oh valenti, seguitemi ancora un poco nelle mie digressioni. Nessuno vuol dire che un fantasy può essere tale solo se segue le orme di Tolkien – anche se ritorna la provocazione del «either imitating him or else desperately trying to escape his influence.»; né si può dire che Mr Tolkien (aridaje) fosse veramente il primo ad aver scritto un fantasy “mimetico” in un “secondary world” (si potrebbe citare il “nonno” di Lovecraft, Edward Plunkett alias Lord Dunsany, a inizio Novecento; e il contemporaneo di Tolkien, Mervyn Peake, con la sua trilogia ambientata su Gormenghast nel 1946). Il Nostro, però, fu forse il primo a farlo con la consapevolezza di un accademico, conscio dei suoi strumenti e degli effetti che avrebbe ottenuto. E qui veniamo al tema della puntata di oggi.
Alla University of Oxford, nel primo dopoguerra, Tolkien era – come il suo collega e amico C.S. Lewis – un affermato medievalista. Al contrario di Lewis però, come veicolo per carpire la mentalità e lo spirito dell’epoca, egli non era affascinato tanto dalle storie e dai miti in sé, quanto dalle varianti delle lingue in cui erano stati scritti. Partendo da queste complementari e opposte scuole, le vie accademiche dei due si divisero e il Nostro divenne uno dei più affermati filologi del tempo, di rimando il più influente scrittore fantasy della storia e il più efferato martellatore di… nomi astrusi.
È mai possibile che filologia e fantasy possano essere campi così correlati? È noto che all’origine del corpus della sua opera, prima ancora dei primi miti di uomini, elfi e nani ambientati nella sua Terra di Mezzo, Tolkien inventò i ceppi e gli alfabeti delle lingue che questi parlavano. Le lingue non erano un vezzo con cui incipriare un mondo, ma generavano il mondo stesso. Con sue parole: «The stories were made rather to provide a world for the languages, than the reverse. To me a name comes first and the story follows.» (Letters 219; Edward James).
La filologia “parallela” di Tolkien si spingeva nell’oscurità della semiologia e ancora oltre, sino al mistero della magia stessa; non quella fantasy, bensì quella umana: creare un nome è prendere possesso di un’idea e renderla tangibile. Il medesimo credo nella potenza evocativa del linguaggio, permea l’intera struttura di in un altro classico contemporaneo del fantasy: la Saga di Terramare di Ursula K. Le Guin. I maghi di Terramare, Ged-Sparviere in primis, hanno potere sul volto del mondo tramite la conoscenza del “vero nome” delle cose. Queste “sillabe della creazione” sono assieme significante e significato del reale. Non che la realtà, non-nominata, smetta di esistere; ma soltanto tramite l’atto del nominarla essa viene interiorizzata come concetto e perciò come oggetto modificabile: coscienza sul sé e sul mondo (se si fa caso, anche i cattivoni della saga dei Gentlemen Bastards di Scott Lynch sono stregoni chiamati Bondsmagi, dove la pronuncia bond ricorda il participio passato di “to bind” – legare, costringere – e ciò che si lega non è altro che la vittima tramite la conoscenza del suo “vero nome”).
Ma che vuol dire, che per scrivere un buon fantasy bisogna fare tutta sta trafila? No – ammesso e non concesso che tendere alla perfezione con i giusti strumenti sia l’unico slancio che giustifichi l’infoltire i già sovraffollati archivi delle testimonianze letterarie umane... Ehm, ma in mancanza di ciò, basterebbe cercare una coerenza perlomeno fonetico/estetica nella creazione dei nomi della propria opera: in un fantasy di ambientazione paleolitica forse sarebbe meglio evitare di chiamare il proprio guerriero Neanderthal Johnny.
«Ah, ok, ho capito, allora devo dare un nome fantasy classico tipo, Lexotan!»
Sì, se il vostro protagonista è un mago del vento e nella lingua del suo mondo Lex vuol dire “aria”, tan “padrone”, e o è un genitivo. Altrimenti Lexotan – nelle mente del lettore – rimarrà il nome di un farmaco ansiolitico e il vostro elfo potrebbe di rimando caratterizzarsi in maniera bislacca (sempre meglio del nano Maalox).
Problema nuovamente molto italiano: ogni parola di origine germanica ha, per la nostra lingua romanza, un suono “fantasy”, forse solo perché il genere, dall’epica classica al contemporaneo, ci è arrivato perlopiù tramite autori che in quelle radici lo hanno calato. Certo, sarebbe difficile non rompere il patto magico con il lettore chiamando il nostro stregone di Terramare Franco, ma mischiare in una parola un numero casuale di K, H e W non otterrebbe migliori risultati.
Il nocciolo della questione è sempre il medesimo: i nomi servono al fantasy come strumento fautore della coerenza interna del mondo che si vuole creare, in cui il lettore sarà calato e in cui là dovrebbe rimanere sinché non stacca gli occhi dalla pagina e, possibilmente, anche dopo. Questo insight integrale nella realtà secondaria è l’unica strategia per creare nel lettore ciò che Tolkien chiamò “Enchantment”; e in risposta, uno dei suoi primi critici, perso nelle dozzine e dozzine e dozzine di nomi di generazione in generazione di Sindarin, chiese disperato al cielo: «[but for fuck sake!] Who cares about the cats of Queen Beruthiel!?»
Ci siamo arrivati: questo l’urlo della critica dalle origini sino a Pdor! Figlio di Kmer! Della tribù degli Star! Parlare, però, dei gatti di Beruthiel – ovvero di un particolare apparentemente non correlato alla trama del racconto – equivale in Martin alle venti pagine di appendice/guida al lettore con i nomi di tutti i membri delle casate nobiliari dei Sette Regni e, nella Rowling, ai quadri dei vecchi presidi di Hogwarts appesi nell’ufficio del preside: il modo più efficace per dirci che là, nell’altro mondo, la vita funziona esattamente come qua nel nostro e perciò possiamo rilassarci, e crederci nonostante ci siano draghi e magia (ciò che ci importa, in realtà, è soltanto che Cersei Lannister giaccia con il fratello).
Dal momento in cui il nostro linguaggio ha inventato la coniugazione verbale al passato e al futuro, abbiamo imparato a concettualizzare il tempo delle nostre azioni, a ricordarci di cosa è successo prima di noi – persone in primis – chiamando il tutto per nome e facendolo rivivere tramite le storie, infinite storie che altro non sono che la stessa (e torniamo a Fantásia).
Questo è l’Enchantment, la mimesi tramite il linguaggio stesso. Ma dall’angolo limaccioso, gli Urban-fan, con la Austen di protesta sotto braccio, mi guardano torvi: vuol dire che il mio Johnny – caduto in un portale dimensionale mentre apriva il frigo nel suo attico a Manhattan e finito nel mondo degli ippogrifi zombie (che poi sfrutteranno il varco per conquistare gli Stati Uniti in stile United States of Zombieland) – non è un protagonista fantasy di un romanzo fantasy? Vuol dire che l’Urban-fantasy non crea mimesi? (No, no, digli di no – mi fa segno il tizio con gli occhialetti, lo sguardo folle e il Compendium alla Terra di Mezzo stretto sotto braccio).
Certo che crea mimesi, ma l’architettura concettuale di Tolkien (e precursori) è ancora la chiave, perché dedicando alla fantasia un mondo a parte, egli si cacciava volontariamente dall’Eden e donava alla letteratura una nuova sensibilità che non possiamo più ignorare (quanto il mercato abbia fatto la sua parte, lo lascio a voi). Perciò, anche se un fantasy, come l’Urban, torna volontariamente agli espedienti dei primi romanzi fantastici – brecce, viaggi e compenetrazioni del fantastico nel reale – nessuno ha più la pretesa di considerare quel reale “il nostro” continuum spazio temporale; bensì uno adiacente, parallelo, uguale al nostro se non fosse per quei fastidiosi ippogrifi zombie che vengono vomitati dal frigo di Johnny; la domanda “what if?” riconosciuta nella sua dignità e messa a disposizione dell’infinito. In parole tutt’altro che povere: Multiverso.
«Ah, ok, ho capito, fantasy toklieniano… Aridaje.» E mica è finita qua: vogliamo parlare delle mappe a inizio libro? Alla prossima!
Ci ritroviamo on line il 03/05/2013 con la puntata n. 3 della Rubrica Nella pancia del drago: Sii un bravo cartografo.
Fantasy e mappe: un binomio indissolubile. Uno strumento per l’orientamento del lettore gentilmente fornito dall’editore o più una questione atavica di afferrare il Nulla con le mani e fare del vuoto materia pulsante? (That’s power-writing!)
Per consultare tutte le puntate della Rubrica Nella pancia del drago, clicca qui.
Media: Scegli un punteggio12345 Il tuo voto: Nessuno Media: 5 (1 vote)