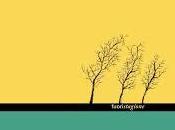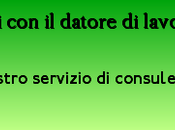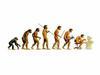Quando, poco più di un anno fa, uscì in Italia Sono stato a Lisbona e ho pensato a te (La Nuova Frontiera, 2011, trad.: G. L. De Rosa) i critici evocarono ora Pier Paolo Pasolini (per l’ambientazione proletaria) ora Italo Svevo (per il tabagismo nevrotico del narratore). Insomma, il protagonista si chiamava Sergio, ma richiamava alla memoria uno Zeno Cosini brasiliano e operaio che un giorno, così come aveva smesso di fumare, decide di far le valigie ed emigrare in Portogallo. Forse sono solo associazioni casuali, fenomeni che Starobinski direbbe di “falso riconoscimento” o “persistenza retinica”. E casuale è anche l’associazione mentale che mi ha spinto a riprendere in mano questo romanzetto breve del brasiliano Luiz Ruffato, ora che in Portogallo (e non solo, a giudicare da certe notizie) si nota un’inversione di rotta nell’emigrazione internazionale, con gli immigrati brasiliani che tornano in patria e i portoghesi che li seguono, nuovamente in cerca di fortuna oltreoceano.
Quando, poco più di un anno fa, uscì in Italia Sono stato a Lisbona e ho pensato a te (La Nuova Frontiera, 2011, trad.: G. L. De Rosa) i critici evocarono ora Pier Paolo Pasolini (per l’ambientazione proletaria) ora Italo Svevo (per il tabagismo nevrotico del narratore). Insomma, il protagonista si chiamava Sergio, ma richiamava alla memoria uno Zeno Cosini brasiliano e operaio che un giorno, così come aveva smesso di fumare, decide di far le valigie ed emigrare in Portogallo. Forse sono solo associazioni casuali, fenomeni che Starobinski direbbe di “falso riconoscimento” o “persistenza retinica”. E casuale è anche l’associazione mentale che mi ha spinto a riprendere in mano questo romanzetto breve del brasiliano Luiz Ruffato, ora che in Portogallo (e non solo, a giudicare da certe notizie) si nota un’inversione di rotta nell’emigrazione internazionale, con gli immigrati brasiliani che tornano in patria e i portoghesi che li seguono, nuovamente in cerca di fortuna oltreoceano.
Ben presto un libro del genere potrebbe essere letto anche come pezzo di archeologia sociale, come un romanzo di Graça Aranha sull’immigrazione tedesca in Brasile di cent’anni fa, come repertorio di curiosità già passate alla storia: cose antiche quali la certezza di trovare un lavoro, il sogno di ricevere un salario in euro sia pure tra i più bassi del continente, la concorrenza agguerrita dell’immigrazione qualificata e poliglotta proveniente dall’est. Insomma un’Europa che forse sta scomparendo inesorabilmente e che Ruffato racconta senza sentimentalismi né immotivate nostalgie, con l’occhio marziano e acuto dell’“extracomunitario”. La vita di Serginho – nato a Cataguases, Minas Gerais, come il suo autore – nella capitale portoghese attraversa le peripezie classiche dell’immigrato povero: la pensioncina da quattro soldi in centro, poi la grigia periferia, la ricerca di un impiego, il contrabbando di passaporti, il sesso a pagamento e l’alienazione dei sentimenti, la diffidenza degli autoctoni e persino le inattese asperità linguistiche, date le differenze fra il portoghese parlato di qua e di là dall’Atlantico.
Una fetta di vita ricca comunque d’incontri, figure e situazioni memorabili. Come la prostituta che sparirà nel nulla proprio quando lui se ne stava innamorando, o il conterraneo che gli spiega l’emigrazione in due parole: qui siamo “i brasiliani”, in tono dispregiativo; lì siamo “gli altri”, cioè niente. O ancora il poeta da osteria, l’uomo che da anni promette di sfilare il grande libro dal cassetto, e nelle ultime pagine offre una profetica performance sulla gradinata del Duomo, mettendosi in vendita al miglior offerente, perché l’Europa, dice, ci vuole in ginocchio (sebbene, nel frattempo, anche la sua paura per l’invadente superpotenza spagnola sia già finita sotto naftalina). Umanità varia che formicola in una Lisbona vista sempre con gli occhi del navigatore sperduto, nostalgico di un entusiasmo affievolito, viaggiatore aspirante turista, spesso e malvolentieri risucchiato nella folla dei turisti veri, quelli che, guida alla mano, sanno sempre dove andare e con chi.
Non so quanto tempo abbia vissuto Ruffato in Portogallo prima di scrivere questo libro, ma è la cosa migliore di uno straniero a Lisbona (inclusi film e altri oggetti d’arte varia) che mi sia capitata fra le mani negli ultimi anni. E l’interesse sociologico non deve far sospettare nessuna povertà di risorse letterarie. Nella prima pagina, l’autore presenta il proprio lavoro come “semplice” sbobinamento, soggetto a lieve editing, di una testimonianza presa dal vero e registrata in quattro giorni d’estate. Il lettore, travolto dal ritmo jazzistico e tutt’altro che improvvisato del monologo dell’emigrante, avrà i suoi buoni motivi per diffidare di questa ennesima variante del manoscritto ritrovato.