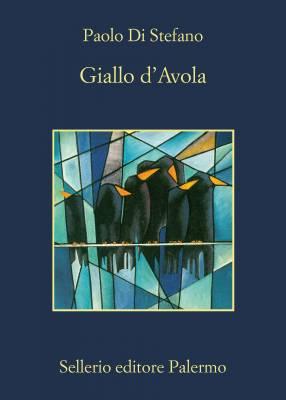 Lei ha scritto romanzi, poesie, racconti, ha curato reportage e volumi di saggi. Nella sua attività, come è venuto configurandosi il rapporto tra racconto, testimonianza e memoria?
Lei ha scritto romanzi, poesie, racconti, ha curato reportage e volumi di saggi. Nella sua attività, come è venuto configurandosi il rapporto tra racconto, testimonianza e memoria?
È una bella domanda che entra nel cuore del mio lavoro. Ho sempre lavorato sulla memoria e sempre più il mio lavoro nasce dall’esigenza di far affiorare alla coscienza memorie comuni disperse (individuali o collettive) per rendere giustizia a persone e fatti che non meritano di essere dimenticati: questo avviene particolarmente nei miei ultimi due libri, La catastròfa, sulla tragedia mineraria di Marcinelle dell’8 agosto 1956, e Giallo d’Avola, che racconta un clamoroso errore giudiziario avvenuto tra il 1954 e il 1961. Certo, la memoria si lega anche alla testimonianza e alla voce di quelli che raccontano: la memoria non va disgiunta dalla grana della voce (con le sue inflessioni, i toni, le incertezze, i colori dialettali o regionali straordinari dell’oralità) di quelli che raccontano e che io vado a rintracciare con pazienza e discrezione. Nella composizione dei miei romanzi (era già accaduto con Tutti contenti) utilizzo tutti questi materiali “sonori” che mi si presentano come fossero già in natura, documenti per così dire poetici. Si tratta di non tradire la memoria dei testimoni non solo per quel che dicono ma anche per lo stile in cui lo dicono, che in letteratura è la questione cruciale. Questo comporta uno sforzo enorme, ma mi pare l’unico modo per rendere giustizia ai fatti e alle persone.
In che misura le sue origini siciliane la accompagnano nell’atto della scrittura? Esiste davvero, secondo lei, una geografia della narrazione?
Sempre più, scrivendo, mi accorgo che tendo a tornare alle mie origini: sono la vera cosa che mi interessa. Capire da dove vengo. Io ho vissuto in Sicilia solo nei miei primi tre anni, eppure più scrivo e più torno alla mia terra, forse scrivere mi serve per tornare lì. Nei miei libri c’è sempre la Sicilia, magari vissuta da lontano, ma c’è sempre. Non riesco a evitarla, è come un’ossessione. In Giallo d’Avola ho scavato nel fondo oscuro di un fatto antico per scavare dentro me stesso: c’è l’eco della mia famiglia, il mondo, la povertà dei miei nonni, l’ambiente e la parlata che appartengono ai miei avi. La mia geografia profonda è quella, anche se è una geografia paradossalmente spaesata. Una narrazione senza geografia e senza storia (anche quando geografia e storia sono immaginarie) non è concepibile, perché geografia e storia sono la materia di cui sono fatti i personaggi. Per questo la ricchezza del paesaggio italiano non finisce di dare spunti enormi al racconto.
Come critico, a che tipo di narrazioni pensa si dovrebbe consegnare il racconto del nostro tempo?
Non ho nessuna ricetta e nessuna preclusione: non penso che si debba consegnare a niente pregiudizialmente. Ogni scrittore lavora sulle proprie ossessioni, che sono individuali, e che comportano soluzioni e forme sempre diverse e personali. L’unico tipo di narrazione a cui ci si deve consegnare è la propria o quella che si sente come propria, anche se deve fare i conti con mille suggestioni letterarie che appartengono ad altri (gli autori preferiti, per dirla in modo banale). L’imitazione in letteratura è auspicabile, ma poi, a un certo punto, bisogna liberarsi dai modelli e andare per conto proprio in mare aperto. La qualità di un romanzo o di un racconto o di una poesia è nel rapporto personalissimo che riusciamo a stabilire tra un’idea, suggestione, visione, immaginazione e una forma. Se non si riesce a conquistare una singolarità di voce in questa relazione, si possono confezionare prodotti ben fatti, ma non c’è letteratura.

Giallo d’Avola è la storia di un clamoroso errore giudiziario, che viene raccontato puntualmente nelle sue pieghe più assurde. Ma è anche la storia di un sospetto e di un pregiudizio collettivo maturato in un luogo chiuso, quasi claustrofobico, come le montagne della Sicilia orientale (gli Iblei). È anche una specie di Fu Mattia Pascal di poveracci degli anni Cinquanta. C’è dunque una dimensione giudiziaria, che si intreccia con una dimensione psicologica (una scomparsa misteriosa, l’odio familiare, il senso di colpa…) e con una dimensione antropologica (l’ambiente siciliano di quel tempo, in cui intorno stava per esplodere il boom economico). C’è il piano dell’intreccio e c’è il piano corale: un insieme di voci che dicono e non dicono, che parlano e nascondono, che forse parlano per nascondere, per svelare la verità o per aumentare il fumo della menzogna. A me interessava far interagire tutti questi livelli, che comprendono anche un miscuglio paradossale – a volte tragico e a volte comico – di irrazionalità e illuminismo, di brutalità arcaica e di civiltà.
Se qualcuno le chiedesse quanta percentuale del “Di Stefano giornalista” c’è in Giallo d’Avola, e quanta percentuale c’è del “Di Stefano scrittore”, cosa risponderebbe?
La ricerca che ho fatto prima di scrivere può assomigliare a un’indagine da giornalista investigativo (sopralluoghi, raccolta di testimonianze dei sopravvissuti, lettura e analisi delle carte processuali), ma la scrittura e la costruzione della storia non hanno nulla a che fare con il giornalismo. Se la cronaca nel migliore dei casi tende al vero, la letteratura deve tendere a una verità che è molto più profonda della semplice ricostruzione dei fatti. La lingua, in un articolo di giornale, deve essere estremamente chiara, l’argomentazione deve essere lucida, consequenziale, e arrivare subito al cuore delle questioni. Un narratore lavora di empatia con i personaggi e lavora anche con una buona dose di invenzione, anche quando i fatti raccontati sono (tutti) veri. E il linguaggio non è colore, ma è la materia stessa di cui sono fatti i personaggi e le cose.
Perché era così importante, per lei, raccontare la storia, a suo tempo balzata agli onori delle cronache, di un “morto vivo” come Paolo Gallo?
Certo, c’era la curiosità di capire esattamente come andarono davvero le cose in quella storiaccia che io sentivo raccontare dai miei genitori e persino dai miei nonni, una storia inquietante e oscura su cui la collettività avolese aveva fantasticato, aggiungendo e togliendo a seconda delle proprie convinzioni. Il caso Gallo, che era balzato agli onori della cronaca nazionale e internazionale, è diventato un fuoco narrativo collettivo rimasto sospeso in un alone di leggenda popolare. Offriva in sé un materiale romanzesco straordinario: personaggi meschini e altri epici, donne velenose e altre piene di compassione, magistrati cialtroni e avvocati testardi e lucidissimi, bambini terrorizzati dal “mostro della montagna”. C’era anche la curiosità di capire che cos’è la “sicilitudine” di cui parla Sciascia e quella corda pazza pirandelliana che appartiene alla Sicilia e che nella storia del morto-vivo di Avola si esprime all’eccesso. Ma, come dicevo prima, era importante per me scavare in quei fatti, in quell’epoca e in quei personaggi anche per immergermi dentro le mie origini.
[Seguiteci su Facebook, Twitter, Google+, Issuu e Pinterest]
Media: Scegli un punteggio12345 Nessun voto finora





