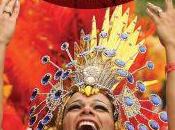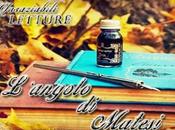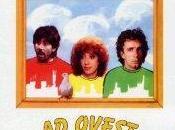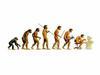[Articolo pubblicato nella Webzine Sul Romanzo n. 2/2013, La difficoltà dell'inizio. Il coraggio del primo passo]

Quest’atto di fede risale al Trecento e ha come protagonista Dante Alighieri, cui Bruno Migliorini dedica una trattazione autonoma nella sua Storia della lingua italiana: il volgare – quello illustre, l’idioma di cui va alla ricerca nel De Vulgari Eloquentia – era stato utilizzato soltanto dalla Scuola Siciliana; non aveva, insomma, una grande tradizione letteraria alle spalle e il confronto con la lingua latina non poteva sussistere: fu proprio questo uno dei motivi per i quali la prima generazione di umanisti rifiutò le proposte della Corona Fiorentina.
Dante era convinto – lo scriveva nel Convivio – che il nuovo idioma fosse destinato a diventare un «sole nuovo, lo quale surgerà là dove l’usato tramonterà, e darà luce a coloro che sono in tenebre e in oscuritade per lo usato sole che a loro non luce». Secondo il Trecentista, dunque, il volgare era in grado non solo arrivare nelle case di tutti – il Convivio è un’opera tendenzialmente divulgativa –, ma anche di sostituire la lingua garante dell’immortalità letteraria: il latino.
L’Alighieri non ha ripensamenti: con la Commedia, i percorsi linguistici teorizzati nel De Vulgari Eloquentia cambiano, ma è proprio dal plurilinguismo del poema in volgare – comunque ricco di latinismi e apporti linguistici di altri dialetti – che si evince la grandiosità della sua operazione. In un clima di grande incertezza e forti polemiche, infatti, Dante scommette sul nuovo idioma: la Commedia, summa dei saperi del tempo, è il ritratto di personaggi, paesaggi, credenze e culture, stati d’animo, situazioni e moti dell’animo che solo una lingua dal potenziale infinito avrebbe potuto descrivere. A opera compiuta, il poeta non solo termina l’itinerarium mentis in Deum, e contempla «l’amor che move il sole e l’altre stelle», ma dimostra anche ai detrattori che il suo azzardo non era stato un capriccio: rifiuta l’invito di Giovanni Del Virgilio, a contatto con i preumanisti padovani, di scrivere una tragedia in latino, convinto del suo atto di fede verso il volgare e che il poema lo avrebbe riportato a Firenze.
[Per continuare a leggere clicca qui, e vai a pagina 13]
Media: Scegli un punteggio12345 Il tuo voto: Nessuno Media: 5 (1 vote)