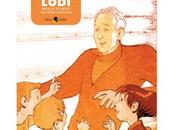Dirò semplicemente come ho incontrato Giuseppe. Parlo dell’incontro con la sua parola, quella che noi epigoni dei chierici, con animo incurante, chiamiamo poesia.
 All’inizio il contatto si è prodotto per effetto di un timbro di voce forte, senza enfasi, assertivo. Ho avvertito una sorta di impeto giovanile che tradiva un fremito di insicurezza sottostante. Ogni significato verbale mi sgusciava; è scivolato via come il nome stesso dell’Autore, quella prima volta, in un’atmosfera d’ombra.
All’inizio il contatto si è prodotto per effetto di un timbro di voce forte, senza enfasi, assertivo. Ho avvertito una sorta di impeto giovanile che tradiva un fremito di insicurezza sottostante. Ogni significato verbale mi sgusciava; è scivolato via come il nome stesso dell’Autore, quella prima volta, in un’atmosfera d’ombra.
L’ho ascoltato una seconda volta, standogli di fronte e mettendo a fuoco il volto che tradiva una strana gioia: come quella di un fanciullo che spiegasse a un pubblico di adulti i meccanismi dei suoi molti giocattoli, si compiacesse un poco della loro complessità e della propria bravura nell’illustrarne i congegni. E anche questa volta la decodifica si perdeva nel flusso sonoro della voce, nell’ambigua ironia di un sorriso che, strappato a un fauno della mia più antica memoria, ammiccasse dagli occhi vivi e autenticamente attuali di Giuseppe Carta.
La terza volta ho buttato l’occhio nel libro – ponderoso, osservavo – saltabeccando tra le sue molte pagine, con assaggi, pause, retrocessioni … Una parola olistica s’è interposta tra la fisicità dei segni e il mio primo intento decodificante: loico.
Una parolaccia, forse, per un poeta.
Torno a compulsare testi e lemmi. L’immagine della navigazione a vista con periscopio cade a pennello, dato che si presenta come la sintesi icastica dell’opera.
 Giuseppe Carta però fa riferimento a diversi livelli di “osservazione”: quello sopra il pelo agitato e ambiguo del mezzo (diciamo liquor vitae superior) e quello sotto, non meno turbato e oscuro (liquor vitae inferior). Tra queste molteplici dimensioni e stratificazioni mobili, pulsano altre stratificazioni dinamiche: le aspettative, le convinzioni e le credenze, le volizioni e le ripulse, le ambivalenze e le paure dell’uomo poeta; il quale per spostarsi verso l’alto, il basso, l’oltre e l’interno, non può mai uscire da se stesso, cioè dal coacervo bio-culturale – semeiotico e semantico – che compone la malsicura altalenante, ma graniticamente insistente, soggettività. La sua, certo. Però anche – stranamente – e forse soprattutto, la mia (mia e di tanti altri?), curiosa e possibilista, benché un bel po’ appesantita dalla storia vissuta e dalle immancabili già archiviate sconfitte .
Giuseppe Carta però fa riferimento a diversi livelli di “osservazione”: quello sopra il pelo agitato e ambiguo del mezzo (diciamo liquor vitae superior) e quello sotto, non meno turbato e oscuro (liquor vitae inferior). Tra queste molteplici dimensioni e stratificazioni mobili, pulsano altre stratificazioni dinamiche: le aspettative, le convinzioni e le credenze, le volizioni e le ripulse, le ambivalenze e le paure dell’uomo poeta; il quale per spostarsi verso l’alto, il basso, l’oltre e l’interno, non può mai uscire da se stesso, cioè dal coacervo bio-culturale – semeiotico e semantico – che compone la malsicura altalenante, ma graniticamente insistente, soggettività. La sua, certo. Però anche – stranamente – e forse soprattutto, la mia (mia e di tanti altri?), curiosa e possibilista, benché un bel po’ appesantita dalla storia vissuta e dalle immancabili già archiviate sconfitte .
E’attraente infilarsi nelle enunciazioni apparentemente ortogonali di Giuseppe Carta e prendere posto nel suo scafo metaforico, certo assemblato secondo intenti personali, ma con elementi calibrati nelle filiere del postmoderno ancora lucidi di fabbrica, quelli che ciascuno può riconoscere come i pezzi dell’alfabeto stilistico della koinè giovanil/culturale – ambiziosamente planetaria in corso.
E così armati …(armati?) andare … Andare? Ecco: a la vie comme a la guerre!
E al verso come alla vita, come alla guerra. Una guerra in punta di discorso e di verso, con le postazioni macchiniche multiformi e variamente disposte ad attacchi e difese, rinforzate col più astratto acciaio concettuale o simile. E queste agganciano e involgono nei loro ingranaggi le parole idee – e non le parole/effetto degli sbrendoli della carne e delle passioni personali – plastificandole in enunciati assoluti.
 Così l’unica oggettività, fisicamente tangibile concepibile e riferibile, risulta essere un io poetante con voce di testa, che si estroflette e si introflette, che osserva, considera, si adegua camaleonticamente a un moto immaginariamente cosale, da seguire tatticamente al solo scopo di controllarlo e magari volgerlo al conseguimento della propria vittoria finale, sempre annunciata, imminente e spostata, che è forse idea di possesso-dominio di tutte le istanze-idee più prossime, realizzazione di un Sé mitico, mitologico, plurale e contraddittorio.
Così l’unica oggettività, fisicamente tangibile concepibile e riferibile, risulta essere un io poetante con voce di testa, che si estroflette e si introflette, che osserva, considera, si adegua camaleonticamente a un moto immaginariamente cosale, da seguire tatticamente al solo scopo di controllarlo e magari volgerlo al conseguimento della propria vittoria finale, sempre annunciata, imminente e spostata, che è forse idea di possesso-dominio di tutte le istanze-idee più prossime, realizzazione di un Sé mitico, mitologico, plurale e contraddittorio.
Di modo che il crollo, la sconfitta quasi sfiorata non è mai ultima, ma la presa di una nuova postazione per il ri-cominciamento. Come è giusto che sia nella parola e nel verso; perché se si produce segno con senso, la fine è un’astrazione, un punto e a capo. E a una tale scacchiera di enunciati risulta consegnata la joie de vivre del nostro Autore.
Devo dire che quest’avventura sulle rapide “giuscartane” mi piace e mi coinvolge, perché quella specie di moto derisorio (anche auto derisorio), che serpeggia tra i gorghi e gli spruzzi, è una canoa calibrata sull’ironico … E l’ironia non nega il dramma del rovescio, anzi lo evoca e lo considera con una certa estraneazione, ma almeno lo salva dall’esondazione lacrimevole come dall’orgasmo sospiroso.
È noto che il meccanismo ambiguo e un po’ perverso di voler catturare col filo del verso qualche balenio dell’esistenza – ciò che un po’ strazia e un po’ chiama alla tenzone e al gioco – scovando nell’io psicologico-poetico- verbale il suo epicentro, minaccia a ogni sbalzo dì imboccare l’uscita melodrammatica.
Giuseppe Carta non se ne lascia sedurre e ci consegna talora il suo irridente ottimismo, talaltra il suo ugualmente smaliziato realismo, ancora il sogghigno del suo imprescindibile dubbio e anche l’ermetismo della voluta dissimulazione, tutti in abito di stile metafisico.
Si direbbe aver messo gli occhi su un poeta filosofo, senza la filosofia dei massimi sistemi e senza le risposte definitive di una ragione razionalizzante e ontologica. Ci si imbatte con una fenomenologia filosofica che vorrebbe artigliare gli “oggetti del desiderio” personale.
Questi “oggetti”, perciò- in quanto concepiti come oggetti appropriabili, ma inspiegabilmente e allusivamente riluttanti - restano “oscuri”, denudati di una loro specifica volizione, d’una loro autonoma umanità, rimanendo abitatori d’un “liquor vitae” di natura irrazionale e solo casualmente interattiva rispetto al pelago del poeta.
Per contro l’umanità dell’Autore, così pervicacemente perseguita e “difesa”, si alimenta di un solipsismo che non pare ancora consapevole di quale senso sia veicolo e, a sua volta, termine.
“Visioni dal periscopio emozionale“
Written by Bianca Mannu
2° e 3° foto by Sara Elena Meloni (SEM)