Un sabato fatto per l’uomo?
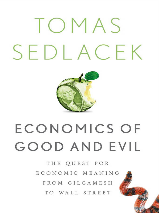 Alla fine di ogni settennio concederai la remissione. Questa è la regola della remissione: ogni creditore rimetterà ciò che verrà prestato al suo prossimo; non costringerà al pagamento né il suo prossimo né il suo fratello poiché è stata proclamata remissione in onore del Signore (Deuteronomio, 15:1-2 ).
Alla fine di ogni settennio concederai la remissione. Questa è la regola della remissione: ogni creditore rimetterà ciò che verrà prestato al suo prossimo; non costringerà al pagamento né il suo prossimo né il suo fratello poiché è stata proclamata remissione in onore del Signore (Deuteronomio, 15:1-2 ).
La prescrizione ebraica della shemittà, restringendo a sette anni l’orizzonte del sistema finanziario, teneva a freno la crescita. Però una società con delle scadenze obbligate non si sarebbe mai gettata nell’avventura speculativa di una bolla immobiliare fondata sui mutui inaffidabili di una classe media impoverita e non avrebbe mai attraversato una crisi come quella del 2007 .
Oggi la maggioranza degli economisti disdegnerebbe il confronto fra prescrizioni etiche o religiose e “realtà” scientifiche. La loro disciplina, tuttavia, prima di rendersi indipendente, stava all’interno della filosofia senza rappresentarsi come “una scienza matematico-allocativa, che considera le cosiddette ‘scienze morbide‘ con un disprezzo derivato da arroganza positivistica”.1 Il libro di Tomáš Sedláček, L’economia del bene e del male, merita di essere letto da chi desidera capire se in questa rappresentazione non si nascondano assunzioni etiche e filosofiche meritevoli di essere discusse.
Il Creatore del racconto biblico non si riposa il settimo giorno per essere più efficiente il resto della settimana, ma perché lo scopo della sua opera è il godimento del creato e non l’attività del creare (pp. 88 ss.). L’otium sabbatico non è una vacanza vuota nel processo indefinito dell’accrescimento dell’utile, ma un atto di libertà, precluso alle società che ubbidiscono all’imperativo della crescita economica. Perché diamo per scontato che la crescita sia un bene? 2
La religione dell’economia
Gli scienziati economici offrono visioni del mondo e servizi profetici sotto forma di previsioni macroeconomiche, rimodellano la società con ricette per contrastare la crisi e promuovere la crescita, indicano la via della prosperità (pp. 237 ss.) e ci chiedono “sacrifici“. Il loro linguaggio religioso non è accidentale.
Sedláček dedica un’ampia parte del suo testo a mostrare quanto pensiero economico si integri nelle religioni e nei miti. Il nesso mandevilliano fra vizi privati e benessere pubblico, che sta alle origini dell’emancipazione dell’economia dalla filosofia, era noto anche a Tommaso D’Aquino (multae utilitates impedirentur si omnia peccata districte prohiberentur). Questi, però, lo fondava sull’evidenza della provvidenza, cioè di un governo divino sul mondo. Anche la convinzione che il mercato si regoli da sé con una mano invisibile è una fede, sebbene non articolata filosoficamente in una Summa Theologiae (pp. 159 ss). Solo una fede, infatti, può farci chiudere gli occhi sulla miriade di regole che avviluppano anche i mercati più “liberi”.
Il sogno del Faraone (Genesi 41:17-24), interpretato da Giuseppe, si può leggere come un’allegoria della teoria del ciclo economico. Giuseppe impedisce che il suo presagio si attui suggerendo al monarca una politica di bilancio anticiclica di stile keynesiano.
La profezia di Giuseppe si è auto-falsificata perché è stata presa sul serio e prevenuta. Nessuno – neanche un profeta - può conoscere il futuro (pp. 64-65). Anche l’economia, in quanto scienza sociale, è riflessiva come i sogni del Faraone. I ricercatori sono parte del loro laboratorio. I loro atti cognitivi influenzano i soggetti che sono, a un tempo, il loro oggetto: la realtà effettuale delle cose è, a un tempo, la loro immaginazione. Per questo le scienze sociali ospitano sia previsioni che si autofalsificano, sia profezie che si autoavverano. Gli antichi, che in luogo degli economisti usavano gli oracoli, sapevano bene che delle profezie cattive possono realizzarsi perché qualcuno gli ha prestato fede, e che delle profezie buone, come quelle di Giuseppe o di Giona (p. 307) non si avverano proprio perché qualcuno le ha prese sul serio e ha adottato delle contromisure.
All’immaginazione appartiene anche il nostro medium comune, la moneta, il cui valore si fonda su una fede condivisa, un’astrazione sociale, un contratto non scritto (p. 81). Questa fede è diventata così potente che oggi la moneta aggiunge alle sue funzioni classiche – unità di conto, mezzo di scambio, riserva di valore – anche quella di stimolare, indirizzare o rallentare il sistema economico nel suo complesso (p. 84). Il mezzo è diventato il fine.
L’economia appare così forte perché si ritiene in grado di descrivere e prevedere l’andamento della società senza compitarlo nel linguaggio riflessivo e valutativo dell’etica, della filosofia e della teologia:
- il nesso di Bernard Mandeville fra i vizi privati e il benessere pubblico permette di rappresentare la società come un sistema che funziona senza bisogno di una guida morale e di studiarla in una prospettiva amorale, simile a quella dello scienziato della natura (p. 66, pp.184 ss.);
- come una scienza naturale, l’economia si vanta di leggere il libro della società in un linguaggio matematico.
I sistemi formali, però, usati acriticamente, non sono nient’altro che miti sofisticati.
L’uomo prescientifico non si preoccupava dell’evidenza scientifica; perciò non si doveva vergognare dei suoi articoli di fede (o pregiudizi, come diremmo oggi) e poteva professarli liberamente. Oggi sono nascosti in assiomi che sono postulati (e non professati con “io credo in…”) indimostrati; gran parte della fede scientifica, tuttavia, è perfino anteriore alla menzione di tali assiomi ed è più profonda, così profonda che non si nota nemmeno (p. 179).
Homines oeconomici
L’assioma dell’economia è l’astrazione dell’homo oeconomicus come massimizzatore egoista di utilità. A partire da questo assioma si costruisce un modello avalutativo della società che, espresso in linguaggio matematico, fonda l’autorità dell’economia in quanto scienza descrittiva, più forte delle prescrizioni della religione, dell’etica o della filosofia. Ma in che modo si definisce l’utilità?
Se la definiamo come ciò che deriva da beni commerciabili, otteniamo una prospettiva sulla società esplicativamente limitata. Se invece la definiamo in modo ampio, affermando che ciascuno la massimizza facendo quello che vuole perché ognuno fa quello che vuole, otteniamo una tautologia, non falsificabile ma empiricamente vuota. Qualsiasi comportamento, infatti, da quello del capitalista più avido a quello del martire più disinteressato, diventa allo stesso modo esito di una massimizzazione egoistica di utilità (pp. 223 ss).
L’orgoglio degli economisti, il fatto che il modello dell’homo economicus includa tutte le possibilità e dunque sia in grado di spiegare tutto, in realtà dovrebbe essere la nostra vergogna più grande. Se possiamo spiegare tutto con un termine o principio del quale non conosciamo il significato, dobbiamo allora chiedere che cosa in effetti stiamo spiegando (p. 226).
La vuotezza dell’economia si rende evidente nella sua pretesa di giudicare su tutte le discipline dello scibile in virtù del suo rango di superscienza. In questo modo si ricade nelle difficoltà illustrate dal Carmide di Platone. Com’è possibile governare i medici nella cura dei malati, gli insegnanti nel loro insegnamento, o i fisici nella loro ricerca, senza sapere nulla di medicina, di pedagogia o di fisica? Questa arroganza dottrinaria si sente giustificata quando il superscienziato è convinto di conoscere il segreto di ciò che determina ogni comportamento umano e ritiene erroneamente che questo lo esima dal conoscere e riconoscere le nozioni, le ragioni e le procedure di tutte le altre discipline.
La limitatezza dell’economia si mostra, invece, nella sua adesione alla via della crescita, cioè dell’indefinito aumento dell’offerta per una domanda assunta come indefinitamente differenziata e crescente. In questo modo si scarta la possibilità, variamente teorizzata da Platone, da Aristotele e dagli stoici, della moderazione della domanda (pp. 221-222) e dell’otium come libertà dal bisogno.
Gli esseri umani sono spesso avidi e indigenti: è dunque facile rappresentarli in competizione in un mondo dominato dalla scarsità. Ma, quando deve fare i conti con una condizione di abbondanza, assoluta o relativa, il modello economico perde la sua presa sulla realtà. Per riguadagnarla deve piegare il mondo alla sua dottrina, imponendo condizioni di scarsità e di indigenza artificiali, in nome di una crescita fine a se stessa - per farci passare la vita in occupazioni che odiamo allo scopo di acquistare cose di cui non abbiamo veramente bisogno (pp. 240 ss). Mentre in passato ci indebitavamo per povertà di cose, oggi lo facciamo per una povertà di spirito (pp. 226-228) a cui contribuisce, riflessivamente, il dominio dottrinario dell’homo oeconomicus.
L’ortodossia economica non è in grado di concepire esseri umani che facciano scelte indipendenti da avidità e bisogno: su di noi deve dunque assumere il peggio, rischiando di ottenere il peggio. La prospettiva del progresso economico contiene una promessa di prosperità: ma l’economia sa farci progredire solo rendendoci poveri.
Come è già stato osservato, Economics of Good and Evil non offre nessuna ricetta economica per uscire dalla povertà indotta dal nostro uso oracolare della scienza economica. Quanto però per l’economista è un limite, può essere per il filosofo un pregio: non possono essere gli oracoli a dirci chi siamo – dobbiamo imparare a farlo da noi.
(1) Tomas Sedlacek, Economics of Good and Evil. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street, Oxford, Oxford U.P., 2011, p. 4. I riferimenti nel corpo del testo sono tutti basati sulla versione inglese. Le traduzioni sono mie.
(2) Vaclav Hàvel, che aveva scelto Tomáš Sedláček come suo consigliere economico, propone questa domanda nella prefazione al volume (p. IX). Sedláček spiega il senso di questa domanda così:
Allo stesso modo in cui la regina Elisabetta nel 2008 chiese agli economisti perché non erano riusciti a prevedere la crisi economica in arrivo, Václav Havel, reagendo alla crisi, si interrogò sul significato della crescita: “Perché tutto deve crescere costantemente? Perché l’industria, la manifattura e la produzione devono crescere? Perché le città devono crescere in tutte le direzioni finché non rimane neanche un pezzetto di paesaggio , neanche un filo d’erba?” Come ricorda Havel stesso, anch’egli, nel corso dei suoi più di cinque anni di prigionia sotto il regime comunista, doveva lavorare di continuo, ma nella stragrande maggioranza dei casi era un lavoro completamente insensato – un “lavoro per il lavoro”. La crescita economica ha sempre un significato, o è solo crescita fine a se stessa? (p. 231)





