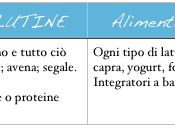Il comportamento umano è un comportamento allusivo (o ambivalente) per definizione. A ridurre l’allusività del comportamento è l’essere vincolato sempre a un contesto o a un ambito interattivo entro il quale viene effettuato. L’ambito interattivo specifico ha la funzione di stabilizzarlo assegnandogli un valore e un significato “univoco” (entro i limiti dell’interazione). L’univocità “interpretativa” del comportamento (e i termini di risposta ad esso) è un fatto puramente “arbitrario”, nel senso che tale univocità interpretativa non è correlata al nostro apparato istintuale. In altri termini non c’è alcuna ragione per attribuire a un dato comportamento un significato univoco e “inequivocabile”. In sé ogni comportamento potrebbe significare una molteplicità di cose. Invece accade che ad ogni specifico comportamento siamo in grado, in relazione a uno specifico ambito interattivo, di attribuirgli uno specifico significato con un minimo margine di errore. Sullo sconosciuto che in pieno giorno ci ferma per strada con in una mano una cartina geografica, con una espressione smarrita e titubante, non abbiamo dubbi che mostri l’intenzione di chiedere qualche informazione. La risposta che forniamo allo sconosciuto non faceva parte del nostro corredo istintuale. Qualsiasi altro animale non addomesticato avrebbe reagito in modo diverso: se il suo corredo istintuale lo avesse classificato come “preda”, probabilmente lo avrebbe aggredito; viceversa, se lo avesse classificato come “predatore” avrebbe reagito con la fuga.
Che la specie umana sia riuscita a “vincolare” il significato del comportamento a un ambito interazionale è un fatto, ma su come sia riuscito imporre questo vincolo si possono avanzare solo congetture. Dal momento che tale significato univoco non appartiene al patrimonio genetico della nostra specie, rimane dunque un mistero capire come sia stato possibile effettuare un tale passaggio. Eppure, l’atto che ha portato a vincolare il significato del comportamento al suo ambito interattivo costituisce l’atto che ha originato lo iato o l’abisso tra il comportamento umano e quello non umano, cioè il punto di non ritorno della specie umana nell’ordine della natura, ossia la sua fuoriuscita dallo stato di natura. In questo atto compiuto possiamo rintracciare la matrice che ha portato a costituire il vincolo , ma rimane pur sempre una congettura. Il comportamento umano è sempre “allusivo”: è, in altri termini, metonimico e metaforico per costituzione, ossia la parte rappresenta o rimanda sempre a un intero, e ogni intero rappresenta o rimanda a una parte. Vediamo di rintracciare la matrice che ha reso possibile “vincolare” il significato di un comportamento a un ambito interattivo, ossia a selezionare un segmento dell’azione eliminando l’allusività all’intero processo. Il problema è come nasce il comportamento univoco, cioè spiegare quale attività viene messa in atto per “scindere” una parte dell’intero in modo tale che possa “rappresentarlo” o “figurarlo” (in un primo stadio) e quindi comunicarlo (cioè trasformarlo in un’informazione in un secondo stadio). È la stessa procedura che mettiamo in atto quando cerchiamo di selezionare alcuni tratti o contorni di una forma stilizzata per rappresentare un oggetto o una scena.
Partiamo dall’azione di fuggire che i nostri antenati mettevano in atto quando all’improvviso si trovavano di fronte a un enorme predatore. Per ipotesi immaginiamo che essi fossero privi di armi per fronteggiare il pericolo. Immaginiamo inoltre che fossero ancora a uno stadio in cui manca qualsiasi modo di “rappresentare” il pericolo imminente. In altri termini, immaginiamo un ominide pre-tecnico, sprovvisto di ogni ritrovato tecnico. In queste situazioni l’unico modo che ha per avvertire la presenza di un predatore è segnalarlo con grida e movimenti del corpo. Tuttavia, il segnale sonoro costituisce di per sé un rischio, perché se da un lato segnala la presenza del predatore segnala purtroppo anche la presenza di chi lo emette. Quando un grosso predatore (un felino) all’improvviso spunta da un cespuglio, non c’è segnale che tenga, la lotta è impari: all’ominide non rimane che come unica via di salvezza la fuga. La sua struttura fisica dell’ominide è difettiva rispetto agli altri primati. L’ominide «è privo di organi difensivi naturali» e dal punto di vista morfologico non ha specializzazioni, bensì primitivismi: «rispetto alle grandi scimmie, che sono arboricoli ad alta specializzazione dotati di braccia ipersviluppate atte all’arrampicata (…), l’uomo è in quanto essere naturale irrimediabilmente inadeguato» (Gehlen). Come spiega Gehlen, la fuga si rivela un tentativo vano, perché l’ominide non può contare né sulla velocità per sfuggire al predatore, né possiede «braccia ipersviluppate atte all’arrampicata» come gli altri primati capaci di arrampicarsi su un arbusto e mettersi in salvo. L’ominide è praticamente del tutto inerme di fronte a un grosso predatore. Quindi, si tratta di un primate non arboricolo, bipede, sprovvisto di una grande rapidità, senza possenti canini per difendersi. Soltanto dei mezzi efficaci di comunicazione potrebbero garantire alla specie di sopravvivere.
Proviamo ad immaginare una scena del genere: un gruppo di ominidi sta divorando una preda. Recenti ricostruzioni hanno dimostrato che «l’uomo avrebbe predato animali premorti per cause diverse, o catturato la grossa selvaggina, messa in disparte da animali meglio attrezzati di lui per l’aggressione» (Roberto Sacco). Praticamente, i primi ominidi, per quanto riguarda il modo di procurarsi il cibo, erano più simili alle iene che non ai felini. Come le iene, piccoli branchi di ominidi si avventavano sulla preda uccisa da un predatore meglio attrezzato dal punto di vista organico. Come è noto i grossi carnivori, i leoni e le tigre ritornano spesso per parecchie notti successive alla carcassa dell’animale ucciso, se gli avvoltoi, gli sciacalli e le iene hanno lasciato qualche cosa.
Quando il branco s’avventa sull’animale il suo sangue attira un grosso predatore. Si avvicina furtivamente al branco che sta consumando velocemente il suo pasto, punta la vittima e all’improvviso scatta e s’avventa su di essa: il corpo dell’ominide sorpreso è completamente paralizzato e in preda a una paura indicibile, tutto il corpo è un solo fremito; grida e movimenti degli arti esprimono il terrore dell’ominide. Il branco sorpreso dal predatore mima la identica emozione di paura, compie gli stessi movimenti, emette le stesse urla. La condivisione dell’emozione crea nel branco un legame forte: ognuno riconosce la propria paura riflessa nei movimenti e nelle grida dell’altro. La vittima prescelta dal predatore, cioè quella sulla quale si avventa, prima di essere divorata agita le parti del corpo più esposte, cioè gli arti ed emette grida di terrore. Il terrore che s’impadronisce degli ominidi è come se si concentrasse in quel disperato tentativo di agitare le braccia e in quelle urla spaventose. Tutte le altre parti del corpo in preda al terrore appaiono come cancellate da quelle urla e da quell’agitarsi delle braccia. Nel momento in cui la paura vissuta lenisce, ciò che permane nella memoria dei sopravvissuti è la percezione distinta di questi due elementi: “braccia agitate”/“grida di terrore” associati al “tentativo di fuga”/“presenza del predatore” da parte degli altri membri del gruppo, come se tutta la loro paura si fosse concentrata in quei due soli tratti. In una gazzella sorpresa da un leone, ad esempio, il terrore si distribuisce su tutto il corpo, non percepiamo una parte del corpo più esposta rispetto alle altre su cui più delle altre si manifesta il senso di terrore.
Diciamo così: ciò che si imprime nel ricordo dell’uomo primitivo è l’agitarsi delle braccia e quei suoni gutturali. Questo «agitarsi delle braccia» accompagnato da grida di terrore è correlato alla scena vissuta del pasto del predatore. Con ciò non voglio dire che il movimento delle braccia sia stato il primo segnale artificiale inventato dagli umani. Voglio soltanto ritrovare la matrice del comportamento stabilizzato. Il coinvolgimento maggiormente emotivo si concentra o converge verso quei due atti inseparabili, che successivamente nel momento del distacco, quando la paura lenisce, diventano i due tratti su cui si fissa il ricordo della scena vissuta. L’agitarsi delle mani e i suoni rimandano all’azione messa in atto (fuga) e al fattore scatenante (l’aggressione del predatore). Dal momento che i due tratti si presentano distintamente alla memoria, essi hanno la possibilità di essere “scissi” dall’intera scena (presenza predatore + fuga), e divenire “parti” del tutto, o parti indipendenti che “rappresentano” il tutto (Cfr. la distinzione tra oggetti indipendenti e non-dipendenti che si trova in La terza ricerca di E. Husserl, in Le Ricerche logiche). Negli altri primati le braccia hanno lo scopo di arrampicarsi velocemente sugli arbusti e sfuggire così al predatore, non restano separati dalla scena ma vengono “pensati” unite al ramo. Nell’ominide, invece, le braccia sono scarsamente allungate rispetto al corpo per servire a questo scopo. Lo iato o la matrice del comportamento stabilizzato deve aver avuto luogo in questa operazione di “scissione”: a ogni membro del branco, le urla e l’agitarsi degli arti hanno il potere di evocare la scena cruenta. Lo stesso meccanismo si ripete nelle società contadine quando la morte colpisce un proprio congiunto: le donne del defunto agitano convulsamente le braccia e lanciano urla strazianti. Qual è il significato “culturale” di questo rituale di lutto? Le donne mimano lo stato di paura e di smarrimento in cui all’improvviso si vedono piombare quando viene a mancare loro un membro importante della comunità: ancestralmente si congiungono alla scena del predatore che piomba sulla vittima inerme. La “morte” che all’improvviso s’appropria del proprio congiunto è come il famelico predatore che all’improvviso dal buio della foresta s'avventa sulla preda.
Vedi anche: "Dal comportamento allusivo al comportamento stabilizzato" e "La forza del comportamento allusivo"