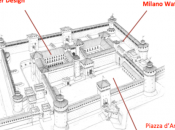di Angelo Salento * [Documenti]

La fabbrica della crisi. Fianziarizzazione delle imprese e declino del lavoro”, di A. Salento e Giovanni Masino, Carocci 2013
È almeno dalla pionieristica ricerca di Richard Sennett (1998) che la sociologia ha iniziato a far luce intorno alle implicazioni delle “nuove” modalità di lavoro sulla condizione sociale ed esistenziale dei lavoratori. Benché non siano mancate e tuttora non manchino letture ambivalenti (e qualche volta incantate) dei processi di individualizzazione del mercato del lavoro, della diffusione della “auto-imprenditorialità”, del “lavoro autonomo di seconda generazione”, il disagio e la deprivazione connessi alla rarefazione del lavoro e alla diffusione del lavoro flessibile/precario sono diventati oggetto, progressivamente, di una letteratura sociologica ricca e sono entrati nel discorso sociale. È chiaro da tempo, per chi lo voglia riconoscere, che la ristrutturazione dell’ordine economico e sociale dagli anni Ottanta a oggi – con la transizione dal cosiddetto embedded liberalism a un’impostazione neo-liberale – ha indotto non soltanto un indebolimento delle tutele del lavoro, ma anche un arretramento dei dispositivi di protezione sociale dei lavoratori (e dei disoccupati). Soltanto con la crisi esplosa nel 2008, tuttavia, questa consapevolezza è diventata una percezione di massa, che diventa sempre più chiara con il protrarsi della recessione economica. Dopo una lunga stagione di infatuazioni, si può dire che la crisi sia stata, per le società dell’Occidente, una sorta di risveglio triste.
Per almeno due decenni, tuttavia, le voci critiche sono state poche. Sia nei mezzi di comunicazione di massa sia nella produzione delle scienze sociali (intese in senso ampio) ha prevalso la convinzione, espressa o tacita, che il dispiegamento più o meno libero del mercato su scala transnazionale sarebbe stato un elemento di razionalizzazione e di progresso. Bisogna riconoscere, effettivamente, che il profilo di maggiore solidità della grande trasformazione degli ultimi trentacinque anni è il suo corredo simbolico e culturale; o, se si preferisce, ideologico. Come ha scritto Marco Revelli, la sconfitta del lavoro ha colpito con le basi materiali della forza lavoro anche i suoi livelli di coscienza. Ha aggiunto alle gambe tagliate del lavoro anche la sindrome della lingua mozzata. Della riduzione al silenzio. E poi della “mutazione antropologica” delle sue figure: del farsi altro da sé, irriconoscibili nel proprio passato. Con memorie intrasmissibili alle generazioni dei figli. Privi di capacità di racconto e di memoria. “Fattore” ora – non più “soggetto” – produttivo” (Revelli, 2010, p. 56).[1]
Naturalmente, per comprendere come sia stata possibile la rimozione collettiva degli effetti corrosivi di una regolazione neo-liberale, si può scegliere entro un ampio ventaglio di spiegazioni, dalle più sofisticate alle più semplici:
in cerca di una spiegazione – annotano Gallino e Borgna (2012, p. VI)[2] – si potrebbero mobilitare illustri teorie della falsa conoscenza, dalla caverna platonica agli idola di Bacone, dal velo dell’ideologia di Marx al concetto di egemonia di Gramsci. Oppure, per stare più sull’ordinario, si potrebbe rinviare al fiume di pubblicazioni, convegni e dossier che, muovendo dai serbatoi del pensiero, dai think tank internazionali del liberismo, diffondono quotidianamente le sue ideologie: economica, politica, monetaria, educativa. Le quali, a differenza dei miti, diventano pratiche di governo e di amministrazione a tutti i livelli della società.
In un libro che si è meritato la fama di un classico contemporaneo, Luc Boltanski e Ève Chiapello (1999)[3] hanno sostenuto che la chiave della forza culturale del “terzo capitalismo” sta nell’aver saputo incorporare, almeno all’apparenza, le istanze di emancipazione espresse dai movimenti operai e studenteschi negli anni Sessanta e Settanta, riuscendo a prendere per così dire in contropiede la critica sociale.[4] L’illusione di una liberazione collettiva dalle necessità del mondo si è sviluppata massimamente a proposito dei cosiddetti knowledge workers, il nucleo (ristretto) di lavoratori che, particolarmente prossimi a quella logica della produzione fondata sulla valorizzazione del general intellect, sono apparsi liberi nel lavoro. Illusioni consolatorie, probabilmente, per chi non abbia fatto i conti con le reali capacità emancipatorie di una classe lavoratrice globale che vede aumentare i carichi di lavoro e peggiorare la propria capacità economica: ossia – come avverte Carlo Formenti – per chi non abbia analizzato realisticamente «la composizione politica del proletariato globale» (Formenti, 2011, p. 149).[5]
Fuori da qualsiasi rappresentazione illusoria degli ultimi trentacinque anni – fuori dai tre “post-ismi” (postmodernismo, postindustrialismo, post-fordismo) con cui l’epoca corrente è stata rappresentata – occorre innanzitutto provare a censire i danni economici e sociali prodotti da una lunga stagione di accumulazione finanziaria (e di declino del lavoro). Le conseguenze macroeconomiche della finanziarizzazione, intesa come aumento dell’attività e delle dimensioni degli operatori finanziari e come crescente ammontare dei prodotti finanziari circolanti, sono state ampiamente esplorate dalla letteratura, oramai vastissima, sulla crisi: perdita del controllo dei processi economici da parte degli Stati nazionali, ipertrofia dei capitali speculativi internazionali, aumento della cartolarizzazione e della circolazione di prodotti finanziari ad alto rischio, impennata del volume dei debiti sovrani. In definitiva, emerge una condizione di piena subordinazione della dimensione politico-economica all’influenza e all’arbitrio di poteri privati de-territorializzati e improduttivi, fondati sulla speculazione e sulla rendita.
In linea con gli obiettivi del libro, dedicheremo questo capitolo a un’analisi degli aspetti del processo di finanziarizzazione delle imprese non finanziarie che riguardano le capacità produttive delle imprese stesse e i rapporti di lavoro: dal declino industriale alla rottura del patto distributivo fordista-keynesiano, alla precarizzazione e alla degradazione delle condizioni di lavoro, all’impatto sui livelli occupazionali. Ci soffermeremo soprattutto sull’esperienza italiana. E vedremo anche quali conseguenze questo degrado della dimensione industriale e produttiva dell’economia abbia sulle dinamiche dell’innovazione e di quelle, connesse, dell’istruzione e della formazione.
* (questo è un paragrafo – il primo del cap. 5 “5.1 Un risveglio triste”, scritto da Salento – del libro “La fabbrica della crisi. Fianziarizzazione delle imprese e declino del lavoro”, di A. Salento e Giovanni Masino, Carocci 2013)[1] M. Revelli, Poveri noi, Einaudi, 2010.
[2] L. Gallino e P. Borgna, Prefazione a Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, 2012.
[3] Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.
[4] Sul rapporto fra il senso comune neo-liberale e l’immaginario della libertà formatosi tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, cfr. anche M. Magatti, Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, Feltrinelli, 2010.
[5] Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Egea, Milano, 2011.
0.000000 0.000000