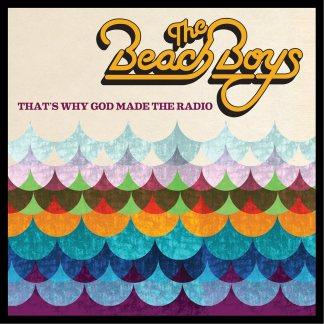 “Summer’s gone
“Summer’s gone
I’m gonna sit and watch the waves
We laugh, we cry
We live then die
And dream about yesterday”
Da diversi anni “uso” i Beach Boys in conversazioni pubbliche e private come strumento attraverso cui verificare la presenza d’una soglia minima di conoscenza della storia della musica nell’interlocutore di turno. Si calcola infatti che siano il gruppo che in assoluto ha venduto più dischi, ognuno ne conosce almeno un paio di motivi ed il carattere più superficiale, quello da festa sul mare in cui si accorpa Gloria Gaynor a Piotta e Brian Wilson a Jovanotti. Orbene, non me ne vogliano i molti amici simpatici ma senza una adeguata coscienza storica musicale, i Beach Boys sono ciò che si spera che in una webzine che tratta di musica nel 2012 sia ampiamente riconosciuto senza ripetizioni pomeridiane come questa premessa ed insegnato alle elementari della scuola dell’ascolto: senza i Beach Boys, senza capolavori come “Pet Sounds”, senza canzoni come “God Only Knows” (una candidata reale al titolo di miglior canzone di tutti i tempi, oltre ogni estemporaneità ed esaltazione da ultimo recente ascolto) oggi la musica sarebbe radicalmente diversa. E la società sarebbe radicalmente diversa se al posto di istrionici dei pagani e poi angeli caduti alla Jim Morrison e pacifisti bellibravintelligenti alla John Lennon avesse preso come idoli verso cui guardare uomini alla Brian Wilson, dal profilo senz’altro meno stereotipizzabile ma certamente più onesto, fragile e complesso.
In cinquant’anni suonati di musica eccezionale, grandi sogni, cadute senza posa e bizzarie infinite (la mia preferita, il “sandbox”, il recinto di sabbia entro le mura di casa nel quale aveva posizionato il pianoforte a coda, per comporre senza dover uscire di casa, mettendo i piedi nella sabbia per ricreare la sensazione che ogni essere umano prova ascoltando un brano a caso dei Beach Boys) Brian Wilson ha avuto la cura di firmare e interpretare, nel disco fresco d’uscita “That’s Why God Made The Radio”, l’ultima canzone dell’ultimo disco suo, della band e di un’era, un “un leitmotif latente, semi-inconscio, contenuto nel suo opposto apparente” come scrive Francesco Paolo Ferrotti, l’esaltazione fanciullesca di ogni sole.
La canzone in questione è “Summer’s Gone”, e pazienza se per una volta iniziamo (restando nei paraggi) dall’ultima traccia del disco, perchè come una clessidra che si capovolge alcune canzoni hanno il potere metafisico di far scoccare ancora lancette del tempo sepolte dalla polvere e far sbocciare ancora l’epopea d’eterna giovinezza d’una band nello stesso momento in cui questa compie consciamente il suo canto del cigno, in un attimo visionario ed estremo, in cui il bambino diventa davvero il padre dell’uomo, citando la celebre poesia “The Rainbow” di William Wordsworth che lo stesso Brian Wilson reinterpreta e cita più volte (in particolare in quel favoloso sogno spezzato poi ricomposto dopo quarantaquattro anni di “Smile”). Le atmosfere sono quelle sospese in un sogno malinconico di “Just Wasn’t Made For These Times”, tese però ad un canto dell’abbandono simile a quello evocato in “Caroline No”. Perchè, se non si era ancora capito, questo disco sembra talvolta una risposta finale e finalmente serena alle domande di “Pet Sounds” che tanto dolore recarono a Brian Wilson ed al destino della band. E la pioggia, tema tabù della surf generation e del surf rock (fatta eccezione per l’eccezionale e misconosciuto album di Jan & Dean, “Save For A Rainy Day”, cui andrebbe dedicato un capitolo a parte e del quale Kingsley Abbott disse che “sarebbe stato inconcepibile se non sulla scia di “Pet Sounds”” e come questo col destino d’esser pubblicato in tirature degne dopo svariati decenni, per l’appunto) aspetta placidamente il dispiegarsi della musica e dell’epopea del sole immenso profuso dai Beach Boys in tutti questi anni. Aspetta ed avvolge, più di qualsiasi nebbia. Perchè se è nel contrario di ogni simbolo evocato che si cela la possibilità di un’armonia incompiuta e sfuggente, è allora chiaro che l’eternità di un Beach Boy sia in una infinita ed amorevole pioggia settembrina.
Come altri dischi recenti della band (meno riusciti di questo, e comunque di non meno di vent’anni fa…), anche in quest’ultimo capitolo sono solo alcune le canzoni capaci di completare un repertorio tanto esteso tanto completo di temi, suggestioni ed emozioni prettamente umane quanto quello dei Beach Boys. Si segnalano in ciò “Pacific Coast Highway”, penultima canzone (e sarà un caso che il meglio sia alla fine o una metaimmagine inconsciamente programmatica) che come fa notare magistralmente ancora Francesco Paolo Ferrotti “riveste la medesima funzione strutturale di “Going Home” in “That Lucky Old Sun”: “Sometimes I realize/ My days are getting on/ Sometimes I realize/ It’s time to move along/ And I wanna go home”. (…) Sprofonda poi in un corale “goodbye” carico di presagi” con un rinnovato “simbolismo tragico del richiamo verso casa: possiamo riconoscere la stessa pulsione edipica anche dalla prospettiva giovanile di “Pet Sounds” (“Let me go home/ I wanna go home…”), rivelando una complessa coincidenza inconscia tra puer e senex, tra il luogo d’origine e la meta estrema, tra l’inizio dell’estate e la sua fine”. Le musiche, un saliscendi più da “Smile” che da “Pet Sounds”, hanno l’innato senso del movimento sfrenato d’ogni suggestione ma accolgono anche una stanchezza che non si può più ignorare e che per questo appare così elegante, nobile e meravigliosamente onesta. E’ esattamente la canzone che un critico musicale ravveduto avrebbe potuto augurare ai Beach Boys degli anni ’60 per il loro finale di carriera ed ancora una volta si ha la sensazione, anche a livello di musiche, che il percorso nella sua chiusura, si riapra sul suo primo orizzonte. Tim Buckley del resto scrisse nel 1967 un album (e la relativa title track) chiamato “Goodbye And Hello”, ed ecco in due parole altrui il senso di questa immagine che torna e di cui c’è il rischio di abusare eludendo un disco che può rivelarsi interessante anche non strettamente agli appassionati dei Beach Boys.
Anche “From There To Back Again” segue il solco della ri-perdita e ri-nascita, ed apre il trittico con le due canzoni di cui sopra, e elevata dalla celestiale voce di Al Jardine è composizione elegantemente controllata ma anche vivace, romanticamente ancorato ad un’ideale nostalgico sepolto nella memoria e ripescato per dirci chi siamo rispetto a un vivido negativo del passato. La metafora della strada sfocia poi nella successiva, e qui precedente, “Pacific Coast Highway”, di cui è introduzione al tramonto evocato “through the consequence of the wine”, sia ben chiaro, e quindi con più allegria e meno dimessa consapevolezza.
Questo trittico non solo è meritevole d’ogni sperticato elogio, d’ascolto intenso e assiduo ed ogni amorevole attenzione, ma è l’unica parte del disco che possa non solo stare accanto ai capitoli migliori di questa saga grandiosa, quanto compierla, giocando pienamente con i simboli che l’hanno composta e ispirata, e poi, come in ogni storia, che l’hanno naturalmente chiusa. Il consiglio, in un’era in cui più che dal negozio di dischi si passa dal masterizzatore per compilation d’ogni tipo, è di rivisitare il “Best Of” dei Beach Boys fermo a diversi anni fa (e se vi siete persi “Smile”, consideratevi peccatori e basta) aggiungendo di diritto Summer’s Gone e valutando l’inserimento delle altre due piccole perle qui descritte.
Se volete divertirvi poi ci sarebbe anche un disco di dieci tracce residue ancora da ascoltare. Ma consiglio di virare altrove, fatta eccezione per la deliziosa, brillantee rotonda “Shelter” e la title track, decisamente all’altezza della maggior parte della musica moderna che viene prodotta. Le canzoni, le idee, le parole, altrove paiono stanche e plastificate, o più semplicemente decisamente trascurabili al cospetto della discografia passata.
Resta una traccia di cui intendo parlarvi. La prima, “Thinking About The Days”. Ed è dove meno ti aspetti il paragone col passato che la raggiunta maturità esistenziale (e non certo compositiva, con quella è nato) sembra poter intonare una “Wouldn’t It Be Nice” non più dedicata alle illusioni giovanili tanto alla veggenza senile, rivelatasi in tutto ciò che aspetta chi sa di aver vissuto e lasciato degna testimonianza di ogni suo sogno, cantando per un’altra volta ancora al mondo il coraggio di esser tutti gli errori, le follie, il dolore passato, volgendosi finalmente pacificato verso l’ignoto che attende ognuno di noi, con una della canzoni più tendenti al silenzio che i Beach Boys abbiano mai composto.
Ed ecco perché, a mio personalissimo giudizio, l’unico percorso possibile è quello che va dalle ultime tre canzoni alla prima. Ecco che a voi si spalancheranno le porte di un EP imperdibile, all’interno di un disco comunque imperdibile per i cultori della materia, meno per quel pubblico che ho tratteggiato all’inizio della qui presente recensione.
Buona compilation dei Beach Boys a tutti, dunque, e che questo presunto EP celebri senza per questo suonare celebrativo uno delle più grandi storie di musica che il Novecento possa testimoniare. Del resto, that’s why God made the radio.


