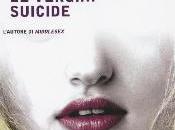Le ombre del mondo di Alexander. Titolo emblematico, per un’altrettanto emblematica band. I Bethlehem rappresentano infatti, a partire dagli anni ’90, una delle realtà metalliche più interessanti, all’interno del filone estremo.
Le ombre del mondo di Alexander. Titolo emblematico, per un’altrettanto emblematica band. I Bethlehem rappresentano infatti, a partire dagli anni ’90, una delle realtà metalliche più interessanti, all’interno del filone estremo.
Anche a loro va infatti il merito di aver contribuito alla codifica dei linguaggi oggi etichettati col termine dark metal (omonimo album, 1994) e suicidal black metal (“Dictius te necare”, 1996 e “S.U.I.Z.I.D.”, 1998). Album importanti, non a caso spesso citati da altri musicisti, un nome per tutti Niklas Kvarforth (Shining, Skitliv, Den Saakaldte), in forze agli stessi Bethlehem, per un breve periodo, con la sua voce malata.
Ma facciamo un passo indietro e torniamo al 2001, anno della pubblicazione di questo “Schatten aus der Alexander Welt”, lavoro paradigmatico nel quale la band capitanata dall’istrionico Jürgen Bartsch esce dai propri territori abituali, dedicandosi a un altro tipo di oscurità in musica, questa volta ammantata da meno livore metallico e una maggiore sperimentalismo sonoro.
L’album è un concept, che narra l’ambigua storia della deriva esistenziale di un uomo (l’Alexander del titolo, simbolo/allegoria di tutti gli uomini alla deriva), ossessionato e intrappolato all’interno di un mondo che è sostanzialmente un labirinto di follia, suicidio, morte.
La tracklist alterna brevi trasmissioni radio, registrazioni vocali che fungono da diario di quest’uomo malato, diventando via via sempre più deliranti e confuse; e le canzoni vere e proprie, tradotte in un metal pesante nelle atmosfere, oscuro e opprimente, vicino al doom, per certi versi, ma infuso di sonorità elettroniche, sperimentalismi realizzati tramite linee di piano in loop, beat trip-hop e strati di cori.
Non i soliti Bethlehem, dunque, e lo scarto stilistico col passato è più che mai percepibile e netto, sebbene a livello concettuale e atmosferico la band sia rimasta comunque fedele a se stessa, e ai propri demoni interiori.

Ottima l’interpretazione vocale di Guido Meyer de Voltaire, ennesimo vocalist di un organico da sempre instabile e inquieto, a suo agio con un basso growl death-doom, ma anche con la voce pulita, utilizzata in modo sia melodico che spoken-word, ma sempre coinvolgente e in grado di veicolare il senso di abbandono, solitudine, delirio e deriva che è la cifra stilistica dell’intero album.

Per chi fosse interessato si segnala, oltre l’edizione Prophecy qui presa in esame, il doppio CD originale, con differente tracklist, e dialoghi e monologhi completi, al posto dei piccoli inserti radio.
Un album denso come un mare nero, ma inafferrabile come un banco di nebbia.
Da riscoprire e rivalutare.
01. Radio EIN/Radiosendung 1 (01:59)
02. Maschinensohn (05:01)
03. Radiosendung 2 (00:35)
04. Somnambulismus In Maschinenzimmer 30 (04:03)
05. Radiosendung 3 (00:44)
06. Mein Kuss Erstickt Im Imperativ (05:04)
07. Radiosendung 4 (00:20)
08. Mary Samaels NFB 418 (05:45)
09. Dunkle, Kalte Materie (03:46)
10. Radiosendung 5 (00:17)
11. Das 4. Tier Aß Den Mutterwitz (05:55)
12. Radiosendung 6 (00:34)
13. Rost, Wahn & Tote Gleise (03:14)
14. Radiosendung 7 (01:12)
15. Tod Einer Dieselkatze (04:26)
16. Radio AUS (00:41)
17. Aus Dunkler Ritze Truchtig Wahn (03:28)