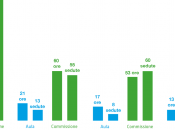Lunedì 19 novembre 2012, alle ore 21:00, presenterò il libro “L’inferno chiamato Afghanistan” a Pavia, presso il Collegio universitario Senatore, un istituto canossiano il cui edificio risale niente meno che ai tempi del re longobardo Liutprando. Sono stato invitato dalla vulcanica Madre Superiora, Antonella Rocca, che ho conosciuto il giorno in cui partiva per il Congo insieme a mia figlia e ad altri volontari. L’evento è stato inserito nel “Festival dei Diritti”, iniziativa promossa dal CSV di Pavia e giunta alla XII edizione. Dialogherà con me il Prof. Marco Dotti, docente di Professione dell’editoria della facoltà di CIM (Comunicazione, Innovazione e Multimedialità) dell’Università degli studi di Pavia. L’incontro è aperto alla cittadinanza. Sono felice di presentare il libro a Pavia e maggiormente di farlo dialogando con un docente dell’Alma Ticinensis Universitas. Pavia è una città che ho nel cuore; lì feci i miei studi universitari e mi laureai nel 1980. Ci ritorno dopo tanti anni con un po’ di emozione e una domanda in nuce. Hanno qualcosa in comune L’Afghanistan, la poesia e Pavia? Il lettore si chiederà perché accosto in qualità di comune denominatore due realtà così lontane come l’Afghanistan e Pavia. Intanto, perché mi sono laureato in Lettere Moderne e ripensando ai miei trascorsi sulle rive del Ticino mi è venuto in mente un episodio che in qualche modo si presta a fare da liaison. Era il 1975(o 1976?) e Alfonso Gatto, il grande poeta ermetico nativo di Salerno, venne a Pavia, invitato dall’Università, per incontrare gli studenti che frequentavano i corsi di Lettere e Filosofia nell’aula magna della facoltà. Partecipai a quell’incontro e rimasi folgorato dalle parole e dallo sguardo di quell’uomo inquieto e avventuroso che sarebbe morto di lì a poco, il 6 marzo 1976. Gatto usava la parola “cuore” con una certa frequenza e ricordo che disse “quando si nasce poeti, l’amore e la morte si fanno compagnia!”. D’un tratto, ripensando a quel giorno, e riflettendo che dopo 32 anni farò ritorno nell’ambiente universitario che mi ha formato, mi è apparso il nesso fino a pochi istanti prima invisibile tra Pavia e l’Afghanistan. È la poesia. Ma come, hai definito l’Afghanistan un “inferno” e parli di poesia? Lo so, potrà sembrare strano a molti che io colleghi la terra dei talebani a Euterpe (poesia lirica), Calliope (poesia epica) ed Erato (poesia amorosa), tuttavia queste tre Muse hanno frequentato Pavia e insieme l’Afghanistan, dove conservano una piccola dimora nonostante i cannoni, le bombe e le mine. A conferma di ciò, cioè del fatto che in Afghanistan fu coltivata la poesia (in lingua persiana e pashtu) voglio riportare un brano del mio libro tratto dal capitolo Gli afghani avrebbero amato il Leopardi, il cui titolo è paradigmatico. “Gli afghani avrebbero amato Giacomo Leopardi, ma non perché siano degli inguaribili pessimisti. Credo che ne avrebbero apprezzato la malinconia e la profonda sensibilità poetica che costituisce una cifra fondamentale della loro stessa natura. È strano che un popolo che si sente vivo solo se impugna un fucile abbia un debole per la poesia. Non la poesia in generale, ma quella latrice di sofferte emozioni, gravida di pianto come le nuvole che ricoprono le alti vallate del Panjshir. Forse, ciò dipende dal fatto che amano la libertà e vivono di ricordi. Khushhal Khan, il padre della lingua e della poesia afghana vissuto nel XVII secolo, ha dettato queste parole: “la grazia più vera che può darci il Signore è darci una lunghissima pazienza, sì che noi ci s’adatti, rinunciando a morire di dolore”. La pazienza pare essere un’altra virtù degli afghani. Altrimenti come potrebbero conservare quel lume di speranza in un futuro migliore che ancora hanno? Ma più che a causa del dolore, gli afghani continuano a morire per l’esplosione delle mine e delle bombe, per malattia, fame e privazioni. Tornando alla loro sensibilità poetica, non posso che essere d’accordo con quello che dice Andrea Busfield nel suo struggente romanzo Il bambino che corre nel vento: Certi uomini sparerebbero in testa a qualcuno senza pensarci due volte, certe famiglie si venderebbero le figlie per un secchio di sabbia, e tutti cacherebbero sul cadavere dei propri nemici; ma a sentir recitare un verso ben scritto, l’uomo afghano diventa vulnerabile quanto una donna. Quando una poesia finisce, scrollano il capo e restano seduti immobili per un lungo momento, lo sguardo perso nel vuoto o fisso a terra, come se vedessero il proprio cuore spaccato in due dalle parole, vergogna e dolore messi a nudo agli occhi del mondo. Gialal al-Din Rumi, forse il più grande poeta mistico della letteratura persiana e fondatore dei dervisci rotanti, è afghano di nascita; venne al mondo nell’Afghanistan del Nord, a Balkh, l’antico centro dello zoroastrismo. A Herat, la splendida città dove non si poteva stendere una gamba senza dare una pedata a un poeta, come ha scritto Khaled Hosseini, ho visitato il santuario di Gazar Gah in cui è sepolto il poeta-sufi Ansari, vissuto nell’XI secolo. È uno dei luoghi più sacri dell’Afghanistan ed è visitato tutti i giorni da migliaia di pellegrini. Sempre a Herat, ho reso omaggio alla tomba del grande poeta Jami, autore di opere contemplative sul divino. Sheikh Ahmad-e Jami morì nel 1492, l’anno in cui Colombo scopriva l’America. Da allora, la sua tomba è meta di devoti che siedono ai lati per pregare e meditare. I venti di guerra non hanno spazzato via l’albero di pistacchio che si è fatto strada nel marmo bianco né le bandiere verdi che circondano il sacello. L’amore per la poesia ha resistito ai cannoni e ai missili”. Credo avesse ragione Alfonso Gatto. Sì, la poesia e la morte possono convivere. L’Afghanistan ne è la prova più convincente e di ciò renderò testimonianza con le parole e le immagini a Pavia, nel ricordo del tempo e dei grandi uomini che ormai vivono nel ricordo.
Lunedì 19 novembre 2012, alle ore 21:00, presenterò il libro “L’inferno chiamato Afghanistan” a Pavia, presso il Collegio universitario Senatore, un istituto canossiano il cui edificio risale niente meno che ai tempi del re longobardo Liutprando. Sono stato invitato dalla vulcanica Madre Superiora, Antonella Rocca, che ho conosciuto il giorno in cui partiva per il Congo insieme a mia figlia e ad altri volontari. L’evento è stato inserito nel “Festival dei Diritti”, iniziativa promossa dal CSV di Pavia e giunta alla XII edizione. Dialogherà con me il Prof. Marco Dotti, docente di Professione dell’editoria della facoltà di CIM (Comunicazione, Innovazione e Multimedialità) dell’Università degli studi di Pavia. L’incontro è aperto alla cittadinanza. Sono felice di presentare il libro a Pavia e maggiormente di farlo dialogando con un docente dell’Alma Ticinensis Universitas. Pavia è una città che ho nel cuore; lì feci i miei studi universitari e mi laureai nel 1980. Ci ritorno dopo tanti anni con un po’ di emozione e una domanda in nuce. Hanno qualcosa in comune L’Afghanistan, la poesia e Pavia? Il lettore si chiederà perché accosto in qualità di comune denominatore due realtà così lontane come l’Afghanistan e Pavia. Intanto, perché mi sono laureato in Lettere Moderne e ripensando ai miei trascorsi sulle rive del Ticino mi è venuto in mente un episodio che in qualche modo si presta a fare da liaison. Era il 1975(o 1976?) e Alfonso Gatto, il grande poeta ermetico nativo di Salerno, venne a Pavia, invitato dall’Università, per incontrare gli studenti che frequentavano i corsi di Lettere e Filosofia nell’aula magna della facoltà. Partecipai a quell’incontro e rimasi folgorato dalle parole e dallo sguardo di quell’uomo inquieto e avventuroso che sarebbe morto di lì a poco, il 6 marzo 1976. Gatto usava la parola “cuore” con una certa frequenza e ricordo che disse “quando si nasce poeti, l’amore e la morte si fanno compagnia!”. D’un tratto, ripensando a quel giorno, e riflettendo che dopo 32 anni farò ritorno nell’ambiente universitario che mi ha formato, mi è apparso il nesso fino a pochi istanti prima invisibile tra Pavia e l’Afghanistan. È la poesia. Ma come, hai definito l’Afghanistan un “inferno” e parli di poesia? Lo so, potrà sembrare strano a molti che io colleghi la terra dei talebani a Euterpe (poesia lirica), Calliope (poesia epica) ed Erato (poesia amorosa), tuttavia queste tre Muse hanno frequentato Pavia e insieme l’Afghanistan, dove conservano una piccola dimora nonostante i cannoni, le bombe e le mine. A conferma di ciò, cioè del fatto che in Afghanistan fu coltivata la poesia (in lingua persiana e pashtu) voglio riportare un brano del mio libro tratto dal capitolo Gli afghani avrebbero amato il Leopardi, il cui titolo è paradigmatico. “Gli afghani avrebbero amato Giacomo Leopardi, ma non perché siano degli inguaribili pessimisti. Credo che ne avrebbero apprezzato la malinconia e la profonda sensibilità poetica che costituisce una cifra fondamentale della loro stessa natura. È strano che un popolo che si sente vivo solo se impugna un fucile abbia un debole per la poesia. Non la poesia in generale, ma quella latrice di sofferte emozioni, gravida di pianto come le nuvole che ricoprono le alti vallate del Panjshir. Forse, ciò dipende dal fatto che amano la libertà e vivono di ricordi. Khushhal Khan, il padre della lingua e della poesia afghana vissuto nel XVII secolo, ha dettato queste parole: “la grazia più vera che può darci il Signore è darci una lunghissima pazienza, sì che noi ci s’adatti, rinunciando a morire di dolore”. La pazienza pare essere un’altra virtù degli afghani. Altrimenti come potrebbero conservare quel lume di speranza in un futuro migliore che ancora hanno? Ma più che a causa del dolore, gli afghani continuano a morire per l’esplosione delle mine e delle bombe, per malattia, fame e privazioni. Tornando alla loro sensibilità poetica, non posso che essere d’accordo con quello che dice Andrea Busfield nel suo struggente romanzo Il bambino che corre nel vento: Certi uomini sparerebbero in testa a qualcuno senza pensarci due volte, certe famiglie si venderebbero le figlie per un secchio di sabbia, e tutti cacherebbero sul cadavere dei propri nemici; ma a sentir recitare un verso ben scritto, l’uomo afghano diventa vulnerabile quanto una donna. Quando una poesia finisce, scrollano il capo e restano seduti immobili per un lungo momento, lo sguardo perso nel vuoto o fisso a terra, come se vedessero il proprio cuore spaccato in due dalle parole, vergogna e dolore messi a nudo agli occhi del mondo. Gialal al-Din Rumi, forse il più grande poeta mistico della letteratura persiana e fondatore dei dervisci rotanti, è afghano di nascita; venne al mondo nell’Afghanistan del Nord, a Balkh, l’antico centro dello zoroastrismo. A Herat, la splendida città dove non si poteva stendere una gamba senza dare una pedata a un poeta, come ha scritto Khaled Hosseini, ho visitato il santuario di Gazar Gah in cui è sepolto il poeta-sufi Ansari, vissuto nell’XI secolo. È uno dei luoghi più sacri dell’Afghanistan ed è visitato tutti i giorni da migliaia di pellegrini. Sempre a Herat, ho reso omaggio alla tomba del grande poeta Jami, autore di opere contemplative sul divino. Sheikh Ahmad-e Jami morì nel 1492, l’anno in cui Colombo scopriva l’America. Da allora, la sua tomba è meta di devoti che siedono ai lati per pregare e meditare. I venti di guerra non hanno spazzato via l’albero di pistacchio che si è fatto strada nel marmo bianco né le bandiere verdi che circondano il sacello. L’amore per la poesia ha resistito ai cannoni e ai missili”. Credo avesse ragione Alfonso Gatto. Sì, la poesia e la morte possono convivere. L’Afghanistan ne è la prova più convincente e di ciò renderò testimonianza con le parole e le immagini a Pavia, nel ricordo del tempo e dei grandi uomini che ormai vivono nel ricordo.
Magazine Attualità
 Lunedì 19 novembre 2012, alle ore 21:00, presenterò il libro “L’inferno chiamato Afghanistan” a Pavia, presso il Collegio universitario Senatore, un istituto canossiano il cui edificio risale niente meno che ai tempi del re longobardo Liutprando. Sono stato invitato dalla vulcanica Madre Superiora, Antonella Rocca, che ho conosciuto il giorno in cui partiva per il Congo insieme a mia figlia e ad altri volontari. L’evento è stato inserito nel “Festival dei Diritti”, iniziativa promossa dal CSV di Pavia e giunta alla XII edizione. Dialogherà con me il Prof. Marco Dotti, docente di Professione dell’editoria della facoltà di CIM (Comunicazione, Innovazione e Multimedialità) dell’Università degli studi di Pavia. L’incontro è aperto alla cittadinanza. Sono felice di presentare il libro a Pavia e maggiormente di farlo dialogando con un docente dell’Alma Ticinensis Universitas. Pavia è una città che ho nel cuore; lì feci i miei studi universitari e mi laureai nel 1980. Ci ritorno dopo tanti anni con un po’ di emozione e una domanda in nuce. Hanno qualcosa in comune L’Afghanistan, la poesia e Pavia? Il lettore si chiederà perché accosto in qualità di comune denominatore due realtà così lontane come l’Afghanistan e Pavia. Intanto, perché mi sono laureato in Lettere Moderne e ripensando ai miei trascorsi sulle rive del Ticino mi è venuto in mente un episodio che in qualche modo si presta a fare da liaison. Era il 1975(o 1976?) e Alfonso Gatto, il grande poeta ermetico nativo di Salerno, venne a Pavia, invitato dall’Università, per incontrare gli studenti che frequentavano i corsi di Lettere e Filosofia nell’aula magna della facoltà. Partecipai a quell’incontro e rimasi folgorato dalle parole e dallo sguardo di quell’uomo inquieto e avventuroso che sarebbe morto di lì a poco, il 6 marzo 1976. Gatto usava la parola “cuore” con una certa frequenza e ricordo che disse “quando si nasce poeti, l’amore e la morte si fanno compagnia!”. D’un tratto, ripensando a quel giorno, e riflettendo che dopo 32 anni farò ritorno nell’ambiente universitario che mi ha formato, mi è apparso il nesso fino a pochi istanti prima invisibile tra Pavia e l’Afghanistan. È la poesia. Ma come, hai definito l’Afghanistan un “inferno” e parli di poesia? Lo so, potrà sembrare strano a molti che io colleghi la terra dei talebani a Euterpe (poesia lirica), Calliope (poesia epica) ed Erato (poesia amorosa), tuttavia queste tre Muse hanno frequentato Pavia e insieme l’Afghanistan, dove conservano una piccola dimora nonostante i cannoni, le bombe e le mine. A conferma di ciò, cioè del fatto che in Afghanistan fu coltivata la poesia (in lingua persiana e pashtu) voglio riportare un brano del mio libro tratto dal capitolo Gli afghani avrebbero amato il Leopardi, il cui titolo è paradigmatico. “Gli afghani avrebbero amato Giacomo Leopardi, ma non perché siano degli inguaribili pessimisti. Credo che ne avrebbero apprezzato la malinconia e la profonda sensibilità poetica che costituisce una cifra fondamentale della loro stessa natura. È strano che un popolo che si sente vivo solo se impugna un fucile abbia un debole per la poesia. Non la poesia in generale, ma quella latrice di sofferte emozioni, gravida di pianto come le nuvole che ricoprono le alti vallate del Panjshir. Forse, ciò dipende dal fatto che amano la libertà e vivono di ricordi. Khushhal Khan, il padre della lingua e della poesia afghana vissuto nel XVII secolo, ha dettato queste parole: “la grazia più vera che può darci il Signore è darci una lunghissima pazienza, sì che noi ci s’adatti, rinunciando a morire di dolore”. La pazienza pare essere un’altra virtù degli afghani. Altrimenti come potrebbero conservare quel lume di speranza in un futuro migliore che ancora hanno? Ma più che a causa del dolore, gli afghani continuano a morire per l’esplosione delle mine e delle bombe, per malattia, fame e privazioni. Tornando alla loro sensibilità poetica, non posso che essere d’accordo con quello che dice Andrea Busfield nel suo struggente romanzo Il bambino che corre nel vento: Certi uomini sparerebbero in testa a qualcuno senza pensarci due volte, certe famiglie si venderebbero le figlie per un secchio di sabbia, e tutti cacherebbero sul cadavere dei propri nemici; ma a sentir recitare un verso ben scritto, l’uomo afghano diventa vulnerabile quanto una donna. Quando una poesia finisce, scrollano il capo e restano seduti immobili per un lungo momento, lo sguardo perso nel vuoto o fisso a terra, come se vedessero il proprio cuore spaccato in due dalle parole, vergogna e dolore messi a nudo agli occhi del mondo. Gialal al-Din Rumi, forse il più grande poeta mistico della letteratura persiana e fondatore dei dervisci rotanti, è afghano di nascita; venne al mondo nell’Afghanistan del Nord, a Balkh, l’antico centro dello zoroastrismo. A Herat, la splendida città dove non si poteva stendere una gamba senza dare una pedata a un poeta, come ha scritto Khaled Hosseini, ho visitato il santuario di Gazar Gah in cui è sepolto il poeta-sufi Ansari, vissuto nell’XI secolo. È uno dei luoghi più sacri dell’Afghanistan ed è visitato tutti i giorni da migliaia di pellegrini. Sempre a Herat, ho reso omaggio alla tomba del grande poeta Jami, autore di opere contemplative sul divino. Sheikh Ahmad-e Jami morì nel 1492, l’anno in cui Colombo scopriva l’America. Da allora, la sua tomba è meta di devoti che siedono ai lati per pregare e meditare. I venti di guerra non hanno spazzato via l’albero di pistacchio che si è fatto strada nel marmo bianco né le bandiere verdi che circondano il sacello. L’amore per la poesia ha resistito ai cannoni e ai missili”. Credo avesse ragione Alfonso Gatto. Sì, la poesia e la morte possono convivere. L’Afghanistan ne è la prova più convincente e di ciò renderò testimonianza con le parole e le immagini a Pavia, nel ricordo del tempo e dei grandi uomini che ormai vivono nel ricordo.
Lunedì 19 novembre 2012, alle ore 21:00, presenterò il libro “L’inferno chiamato Afghanistan” a Pavia, presso il Collegio universitario Senatore, un istituto canossiano il cui edificio risale niente meno che ai tempi del re longobardo Liutprando. Sono stato invitato dalla vulcanica Madre Superiora, Antonella Rocca, che ho conosciuto il giorno in cui partiva per il Congo insieme a mia figlia e ad altri volontari. L’evento è stato inserito nel “Festival dei Diritti”, iniziativa promossa dal CSV di Pavia e giunta alla XII edizione. Dialogherà con me il Prof. Marco Dotti, docente di Professione dell’editoria della facoltà di CIM (Comunicazione, Innovazione e Multimedialità) dell’Università degli studi di Pavia. L’incontro è aperto alla cittadinanza. Sono felice di presentare il libro a Pavia e maggiormente di farlo dialogando con un docente dell’Alma Ticinensis Universitas. Pavia è una città che ho nel cuore; lì feci i miei studi universitari e mi laureai nel 1980. Ci ritorno dopo tanti anni con un po’ di emozione e una domanda in nuce. Hanno qualcosa in comune L’Afghanistan, la poesia e Pavia? Il lettore si chiederà perché accosto in qualità di comune denominatore due realtà così lontane come l’Afghanistan e Pavia. Intanto, perché mi sono laureato in Lettere Moderne e ripensando ai miei trascorsi sulle rive del Ticino mi è venuto in mente un episodio che in qualche modo si presta a fare da liaison. Era il 1975(o 1976?) e Alfonso Gatto, il grande poeta ermetico nativo di Salerno, venne a Pavia, invitato dall’Università, per incontrare gli studenti che frequentavano i corsi di Lettere e Filosofia nell’aula magna della facoltà. Partecipai a quell’incontro e rimasi folgorato dalle parole e dallo sguardo di quell’uomo inquieto e avventuroso che sarebbe morto di lì a poco, il 6 marzo 1976. Gatto usava la parola “cuore” con una certa frequenza e ricordo che disse “quando si nasce poeti, l’amore e la morte si fanno compagnia!”. D’un tratto, ripensando a quel giorno, e riflettendo che dopo 32 anni farò ritorno nell’ambiente universitario che mi ha formato, mi è apparso il nesso fino a pochi istanti prima invisibile tra Pavia e l’Afghanistan. È la poesia. Ma come, hai definito l’Afghanistan un “inferno” e parli di poesia? Lo so, potrà sembrare strano a molti che io colleghi la terra dei talebani a Euterpe (poesia lirica), Calliope (poesia epica) ed Erato (poesia amorosa), tuttavia queste tre Muse hanno frequentato Pavia e insieme l’Afghanistan, dove conservano una piccola dimora nonostante i cannoni, le bombe e le mine. A conferma di ciò, cioè del fatto che in Afghanistan fu coltivata la poesia (in lingua persiana e pashtu) voglio riportare un brano del mio libro tratto dal capitolo Gli afghani avrebbero amato il Leopardi, il cui titolo è paradigmatico. “Gli afghani avrebbero amato Giacomo Leopardi, ma non perché siano degli inguaribili pessimisti. Credo che ne avrebbero apprezzato la malinconia e la profonda sensibilità poetica che costituisce una cifra fondamentale della loro stessa natura. È strano che un popolo che si sente vivo solo se impugna un fucile abbia un debole per la poesia. Non la poesia in generale, ma quella latrice di sofferte emozioni, gravida di pianto come le nuvole che ricoprono le alti vallate del Panjshir. Forse, ciò dipende dal fatto che amano la libertà e vivono di ricordi. Khushhal Khan, il padre della lingua e della poesia afghana vissuto nel XVII secolo, ha dettato queste parole: “la grazia più vera che può darci il Signore è darci una lunghissima pazienza, sì che noi ci s’adatti, rinunciando a morire di dolore”. La pazienza pare essere un’altra virtù degli afghani. Altrimenti come potrebbero conservare quel lume di speranza in un futuro migliore che ancora hanno? Ma più che a causa del dolore, gli afghani continuano a morire per l’esplosione delle mine e delle bombe, per malattia, fame e privazioni. Tornando alla loro sensibilità poetica, non posso che essere d’accordo con quello che dice Andrea Busfield nel suo struggente romanzo Il bambino che corre nel vento: Certi uomini sparerebbero in testa a qualcuno senza pensarci due volte, certe famiglie si venderebbero le figlie per un secchio di sabbia, e tutti cacherebbero sul cadavere dei propri nemici; ma a sentir recitare un verso ben scritto, l’uomo afghano diventa vulnerabile quanto una donna. Quando una poesia finisce, scrollano il capo e restano seduti immobili per un lungo momento, lo sguardo perso nel vuoto o fisso a terra, come se vedessero il proprio cuore spaccato in due dalle parole, vergogna e dolore messi a nudo agli occhi del mondo. Gialal al-Din Rumi, forse il più grande poeta mistico della letteratura persiana e fondatore dei dervisci rotanti, è afghano di nascita; venne al mondo nell’Afghanistan del Nord, a Balkh, l’antico centro dello zoroastrismo. A Herat, la splendida città dove non si poteva stendere una gamba senza dare una pedata a un poeta, come ha scritto Khaled Hosseini, ho visitato il santuario di Gazar Gah in cui è sepolto il poeta-sufi Ansari, vissuto nell’XI secolo. È uno dei luoghi più sacri dell’Afghanistan ed è visitato tutti i giorni da migliaia di pellegrini. Sempre a Herat, ho reso omaggio alla tomba del grande poeta Jami, autore di opere contemplative sul divino. Sheikh Ahmad-e Jami morì nel 1492, l’anno in cui Colombo scopriva l’America. Da allora, la sua tomba è meta di devoti che siedono ai lati per pregare e meditare. I venti di guerra non hanno spazzato via l’albero di pistacchio che si è fatto strada nel marmo bianco né le bandiere verdi che circondano il sacello. L’amore per la poesia ha resistito ai cannoni e ai missili”. Credo avesse ragione Alfonso Gatto. Sì, la poesia e la morte possono convivere. L’Afghanistan ne è la prova più convincente e di ciò renderò testimonianza con le parole e le immagini a Pavia, nel ricordo del tempo e dei grandi uomini che ormai vivono nel ricordo.
Possono interessarti anche questi articoli :
-
CHRIS HANRETTY, STEFANIA PROFETI (A CURA DI) Politica in Italia I fatti dell’ann...
Dopo aver conquistato la leadership del proprio partito alla fine del 2013, ed essere salito a Palazzo Chigi nel mese di febbraio 2014, Matteo Renzi ha... Leggere il seguito
Da Paolo Ferrario
SOCIETÀ, SOLIDARIETÀ -
A Expo Milano 2015: arriva la Gastronomia Campana
Il meglio del distretto enogastronomico della Campania, istituito dall'amministrazione comunale di Palma Campania, in esposizione ad Expo Milano 2015. Eventi... Leggere il seguito
Da Yellowflate
ATTUALITÀ -
L’Egitto al centro della lotta anti-jihadista
Il 16 febbraio scorso il Ministro della Difesa francese Jean-Yves Le Drian si è recato al Cairo per firmare l’accordo per la vendita di una Fregata e 24... Leggere il seguito
Da Geopoliticarivista
POLITICA, POLITICA INTERNAZIONALE, SOCIETÀ -
Grande successo per la prima edizione Miti Moda Muse – Brindisi Città del Mare
Si spengono le luci, cala il sipario, la magica notte si conclude così. Ed è proprio stata una magica notte quella conclusasi nelle tarde ore del 20... Leggere il seguito
Da Yellowflate
ATTUALITÀ -
“Agenda Setting: la cooperazione italiana”, nuovo MiniDossier di Openpolis
La collana MiniDossier si arricchisce di una sezione di approfondimento: Agenda Setting. Il primo focus, realizzato con ActionAid, riguarda la cooperazione... Leggere il seguito
Da Openblog
ATTUALITÀ, ECONOMIA, FINANZE, LAVORO -
L'odore dell'escalation al mattino
(Uscito sul Giornale dell'Umbria)Qualche settimana fa la Reuters pubblicava un'inchiesta fatta dai suoi giornalisti in Ucraina. Leggere il seguito
Da Danemblog
SOCIETÀ