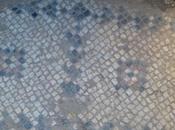La storia talvolta ci mette di fronte a corsi e ricorsi, come istantanei flashback di una pellicola farneticante che rivela, ancora una volta, l’assoluta mancanza di senso progressivo dell’uomo e con essa pure la totale infondatezza di quel motto che vorrebbe, dall’umanesimo in poi, la storia come magistra vitae. E’ il caso dell’etica del risparmio o della ritenzione che, da valore di riferimento a cui tendere, si sta piano piano svuotando delle proprie solenni significazioni per trasvalutarsi sempre più in un disvalore da avversare.
A dirla tutta, come peraltro spesso accade nelle cose che attengono alla morale, essa muta di segno perché non è più tale da servire l’uomo e, perdendo quindi la propria utilità, finisce per trasformarsi in una zavorra da cui liberarsi, insostenibile peso per quel “virtuoso” meccanismo di crescita a cui l’uomo ha voluto placidamente assoggettarsi: la “saggezza economica”. La descrive linearmente Alain de Benoist: “si è solo ciò che si ha; la prova del valore è data dal successo materiale (…) ciò che caratterizza lo spirito borghese non è dunque soltanto la razionalizzazione dell’attività economica, bensì l’estensione di questa razionalizzazione a tutti gli ambiti della vita (…) da ciò l’idea che quel che non può essere razionalizzato sia inutile, superfluo o inesistente”. Per il borghese della prima ora, assieme alla conformità e all’allineamento (si pensi ad esempio a quegli omini dell’Olanda calvinista, tutti egualmente vestiti di nero, dipinti da Rembrandt o da Vermeer), all’ordine e al calcolo, era un valore da testimoniare nella quotidianità pure il risparmio, o per meglio dire la parsimonia. Oggi invece viene fortemente contrastato, talché solo qualche reazionario come Latouche si sogna di parlare favorevolmente di “frugalità voluta”. Tradendo per un momento quello spirito economico che vorrebbe scrupolosamente vagliare ogni cosa per porla sotto l’omnibus della stretta convenienza, il risparmiatore, come il centrino vuole preservare l’integrità di ciò su cui si appoggia, risponde ad un bisogno fisiologico che solo un “povero” sentirebbe come tale. Solo colui che soffre del presente rivolge infatti il proprio sguardo verso un “futuro” che ancora non è, luogo idealizzatosia dal cristianesimo (l’aldilà), sia dalle moderne istanze democratiche (il progressismo e forse oggi il dominio di una techné che nell’innovazione continua vorrebbe risolvere la vita in un’accumulazione crescente di “ben-essere”), in cui la promessa di “stare meglio” possa sublimare l’angoscia verso ogni presente. Non sarà forse un caso se, in un noto adagio popolare, l’aristocratico diventa convessamente all’Accumulatore, il Dissipatore.
 L’aristocratico quindi, a
differenza del parvenu borghese,
potrà forse andare in rovina e finire magari in mezzo ad una strada, perdendo
così tutte le proprie fortune, ma in quanto nobile non correrà mai il rischio
di smarrire il proprio titolo, laddove al contrario l’”accumulatore” ha la
necessità di confermarsi giorno dopo giorno, perché solo quel che possiede è in
grado di convalidarne l’identità.
Il borghese è dunque un decadente
in sé, fisiologicamente. Il nobile, un decadente per volere!
Un individuo incapace di preferenze, che accumulando un’enormità di
esperienze indifferenti, non riesce più a capire quale sia il rimedio alla sua
insoddisfazione e perciò, inadeguato ad ogni presente, ha bisogno di proiettare
sempre le proprie speranze in un futuro che ancora non è ("tutti i nodi vengono al pettine" ne è la preghiera edificata ad ottimistica speranza).
E proprio questo demi-monde
di spettri “in cerca di un autore” si è trasformato oggi in middle class, senza però mai comprendere
appieno quale sia il senso della propria funzione sociale, né tantomeno dove
voglia condurre la propria esistenza. Un uomo in preda alle convulsioni fattosi
oggi classe dirigente, che guida la società attraverso lo stesso nonsense nichilista che ne orienta le
confuse decisioni private.
Massimo Fini ha notato acutamente la spregiudicata
mancanza di senso a cui il loro sistema economico di riferimento ci ha condotto: la società si
è trasformata da una società di produttori in una società di consumatori. Non è
infatti del lavoro dei "produttori" che si nutre, bensì della capacità che l’uomo
ha di ingoiarne, ad un ritmo sempre più insostenibile e frenetico, i
superficiali prodotti.
“Bisogna fare girare l’economia!”.
L’uomo è stato così retro-cesso a semplice funzione,
quella del consumatore: “non si produce
più per consumare, ma si consuma per produrre”.
Segnando un’inversione concettuale con l’intera
“filosofia economica classica”, oltre che col buon senso, quest’affermazione
demenziale dice che, come i tubi digerenti si lasciano attraversare da ogni
scarto senza opporre resistenza, così dobbiamo mangiare anche quando non abbiamo
fame, uscire quando vorremmo magari rimanere in casa, comprare quando non ne sentiamo alcun bisogno.
L’aristocratico quindi, a
differenza del parvenu borghese,
potrà forse andare in rovina e finire magari in mezzo ad una strada, perdendo
così tutte le proprie fortune, ma in quanto nobile non correrà mai il rischio
di smarrire il proprio titolo, laddove al contrario l’”accumulatore” ha la
necessità di confermarsi giorno dopo giorno, perché solo quel che possiede è in
grado di convalidarne l’identità.
Il borghese è dunque un decadente
in sé, fisiologicamente. Il nobile, un decadente per volere!
Un individuo incapace di preferenze, che accumulando un’enormità di
esperienze indifferenti, non riesce più a capire quale sia il rimedio alla sua
insoddisfazione e perciò, inadeguato ad ogni presente, ha bisogno di proiettare
sempre le proprie speranze in un futuro che ancora non è ("tutti i nodi vengono al pettine" ne è la preghiera edificata ad ottimistica speranza).
E proprio questo demi-monde
di spettri “in cerca di un autore” si è trasformato oggi in middle class, senza però mai comprendere
appieno quale sia il senso della propria funzione sociale, né tantomeno dove
voglia condurre la propria esistenza. Un uomo in preda alle convulsioni fattosi
oggi classe dirigente, che guida la società attraverso lo stesso nonsense nichilista che ne orienta le
confuse decisioni private.
Massimo Fini ha notato acutamente la spregiudicata
mancanza di senso a cui il loro sistema economico di riferimento ci ha condotto: la società si
è trasformata da una società di produttori in una società di consumatori. Non è
infatti del lavoro dei "produttori" che si nutre, bensì della capacità che l’uomo
ha di ingoiarne, ad un ritmo sempre più insostenibile e frenetico, i
superficiali prodotti.
“Bisogna fare girare l’economia!”.
L’uomo è stato così retro-cesso a semplice funzione,
quella del consumatore: “non si produce
più per consumare, ma si consuma per produrre”.
Segnando un’inversione concettuale con l’intera
“filosofia economica classica”, oltre che col buon senso, quest’affermazione
demenziale dice che, come i tubi digerenti si lasciano attraversare da ogni
scarto senza opporre resistenza, così dobbiamo mangiare anche quando non abbiamo
fame, uscire quando vorremmo magari rimanere in casa, comprare quando non ne sentiamo alcun bisogno. Un uomo che reagisce semplicemente a degli stimoli indotti... L’onta massima per questo “borghese nichilista” diventa infatti la percezione dell’essere inutile a tenere in piedi l’assurdo carrozzone che ha per giunta reificato a massimo latore di comfort e benessere. In tal modo anche il risparmio diventa oggi condizione d’indigenza, come disse infatti Keynes: “ogni volta che risparmi 5 scellini togli a un uomo un giorno di lavoro”. L’equazione è così a portata di sensazione: se risparmi non fai girare l’economia e quindi, penalizzando il lavoro, crei disoccupazione. Se non compri, non lavori! Di fronte ad un irrisolvibile aut aut, ci siamo cacciati, col tonto ottimismo che contraddistingue ogni cattiva coscienza, in un cul de sac senza fondo, per cui il buon lavoratore, che per natura vuole anzitutto un’occupazione, dovrà acquistare il frutto del proprio lavoro per continuare paradossalmente a lavorare. Un do ut des infinito che dà sempre somma zero. Mangiamo ciò che caghiamo, e caghiamo ciò che mangiamo: finalmente la tautologia eretta a realtà! E ci sarà forse anche il tempo per ghignare, quando sarà chiaro a tutti che ogni bisogno, anche quello “nobile” di lavorare, crea esclusivamente maggior dipendenza dal bisogno stesso. L’art pour l’art si è finalmente nobilitata in un nonsense monomaniacale: “consumo per lavorare”.