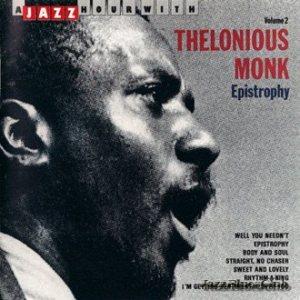«
Sometimes it’s to your advantage for people to think you’re crazy» (Qualche volta va a tuo vantaggio che la gente pensi che tu sia pazzo). Prestando orecchio e tendendo le proprie corde ad un pezzo come
Blue Monk, anche per uno come me, neofita dell’artista e certamente profano del genere musicale (sebbene affascinato e amatorialmente appassionato), è evidente come emerga un viaggio in una dimensione dai pesi gravitazionali assai poco stabili. I miei iniziali pregiudizi vengono però travolti e immersi in una danza di un pianoforte incostante, e a tratti scostante. Un solista stonato, che illumina la parte ritmica e la conduce per mano fino a soggiogarla con pause da groppo in gola. Una danza sui tasti snodata e padrona di un mondo bizzarro e accentato, dissacrante e al limite dello sfottente, con pause e artifizi messi lì a scherzare con l’orecchio, e a flirtare col resto. Un matto nella terra dei matti, terra chiamata jazz, terra che si nutre di improvvisazione. Terra che però ha un suo codice, un suo lato che tende a imbrigliare l’istinto. Un lato reazionario che avvolge ed etichetta anche terreni bradi ed apparentemente ispidi. Non artisti, ma correnti: questo è il gioco, o il giogo. L’avvento di Monk ha contribuito proprio a esaltare i tratti liberi dell’artista, deflagrando sul muro della tradizione e ponendo la questione dell’innovazione e del cambiamento attraverso il rifiuto di regole ormai stantìe. Si parla dunque di rifiuto consapevole, coperto da un mantello chiamato “pazzia”. L’artista finalmente si impone come anti-eroe e mostra come al centro della costruzione ci possa dunque essere lo scontro, la rottura. Non sempre mani strette e condivisioni forzate. Non sempre binari che segnano rotte predefinite. Monk dunque specchio del reale peso di un’esistenza umana lacerata dal binomio del bene e del male, in conflitto perenne con l’inconscia necessità di rompere la confezione del proprio intimo mondo, offuscato troppo spesso dalla nebbia che giace lungo gli argini della via maestra.
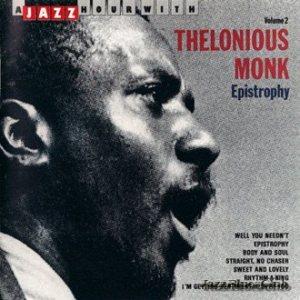
Parte
Epistrophy e Thelonious Monk si presenta dai primi istanti con il suo stile spigoloso, stridente con il contesto e volutamente anticonformista. Una ricerca di fuga che si snoda tra le folli corse delle sue mani sui tasti, là a rischiare di prendersi a schiaffi con la melodia. Là con i lamenti dei fiati ad assecondare la tarantolata magia del piano. Uno stile volutamente anticonformista e senza alcun compromesso da voler o dover pagare. L’approccio con lo strumento d’espressione, con la vera e propria appendice dell’artista, è un approccio che dà l’accento su un’impostazione al di là di ogni concetto di regola. Uno stile profondamente anti-accademico, che sembra godere di fronte all’indignazione del censore più classico. L’apoteosi dell’emozione, con affreschi di pura irrazionalità, pronti non ad avvolgere ma a strattonare i sensi, danzando al di là di ogni più accennata tabella teorica. L’armonia è in Monk un concetto solista. L’armonia è il danzare sul filo e mostrare il muso duro. L’artista non è parte del mondo che contempla il mondo: l’artista diventa parte del mondo che guerreggia contro il mondo. Un pioniere, un marinaio fascinoso, uno zingaro, una ballerina di flamenco. L’artista è l’uomo talmente al limite da non trovar più spazio sul limite. Tutto ciò comporta il rischio della stecca, dell’incomprensione, del fragore. Tutto ciò comporta alberi recisi a colpi di machete, e pone l’arte come vera essenza di individualità umana che si crogiola nei suoi difetti e nei suoi sbagli, fonti di inesauribile virtù. «I made the wrong mistakes» (ho fatto gli errori sbagliati) furono le parole dello stesso Monk dopo un’improvvisazione non soddisfacente. La vita è l’errore, e l’errore è autodeterminazione e indipendenza. Non più morale comune, non più prigionia dell’improvvisazione, non più finte libertà. Fuoco sui dettami, asce sui paletti.

La copertina di
Underground (1967): Monk viene raffigurato davanti al suo pianoforte con un fucile a tracolla, in una stanza piena di armi e bicchieri semi-vuoti, con il prototipo di un generale nazista legato ad una sedia, ostaggio del musicista, costretto ad ascoltare il suono pianoforte, la vera arma. Arma ben più efficace del fucile che pare essere soltanto un deterrente per i nemici (comunque tanti). Fallace e scontroso.
Ribelle, rabbioso, figlio della questione razziale, dell’odio e del lato ruvido della vita. Desideroso di rivendicare ingiustizia e di mostrare rancore, alla sua maniera. Desideroso di raccontare le passioni e i dissapori aspri di una società americana e di un mondo non in linea con le proprie aspettative. Con il suo stile. Uno stile grezzo e senza convenevoli. Uno stile che si perde tra silenzi desertici e marziani e vortici di note a formar scale a chiocciola, oltre le nubi. Pennellate a dipingere locali con nebbie di fumo e luci soffuse, uomini al bancone, fondi di bicchieri sempre troppo vuoti e mai troppo pieni, donne che ballano in mezzo alla sala e ridono da sole, tra l’amaro e il divertito. Uno stile che non si può raccontare, né riferire, né canonizzare. Forse perché «Trying to explain music is like trying to dance architecture» (Tentare di spiegare la musica è come tentare di danzare l’architettura), e il sottoscritto sta cercando proprio di compiere questa missione impossibile.
(Pubblicato su Gli Altri Settimanale del 5 agosto 2011)
 Tracciare un solco. Togliere sterpaglie e ostacoli, segnare il cammino attraverso la rottura totale di ogni schema, anche a costo di smarrire volontariamente la grande via maestra. Inventarsi un sentiero passando per l’istinto “distruttivo” è azione e privilegio di pochi. Uno di questi è Thelonious Monk. L’estate del Paese, si sa, è un piacevole pullulare di festival jazz, che attraversando lo stivale fanno emergere quel sottobosco culturale che è da sempre risorsa dell’italico popolo. Questa per giunta è l’estate ove ricorre il cinquantenario della pubblicazione di “Thelonious Monk in Italy”, capolavoro datato 1961, raccolta di registrazioni live in Italy e omaggio del grande pianista di Rocky Mount al nostro paese. Parlando e soprattutto ascoltando jazz, è inevitabile omettere o trascurare uno snodo focale come Monk e la sua profonda rottura comunicativa col binario passato.
Tracciare un solco. Togliere sterpaglie e ostacoli, segnare il cammino attraverso la rottura totale di ogni schema, anche a costo di smarrire volontariamente la grande via maestra. Inventarsi un sentiero passando per l’istinto “distruttivo” è azione e privilegio di pochi. Uno di questi è Thelonious Monk. L’estate del Paese, si sa, è un piacevole pullulare di festival jazz, che attraversando lo stivale fanno emergere quel sottobosco culturale che è da sempre risorsa dell’italico popolo. Questa per giunta è l’estate ove ricorre il cinquantenario della pubblicazione di “Thelonious Monk in Italy”, capolavoro datato 1961, raccolta di registrazioni live in Italy e omaggio del grande pianista di Rocky Mount al nostro paese. Parlando e soprattutto ascoltando jazz, è inevitabile omettere o trascurare uno snodo focale come Monk e la sua profonda rottura comunicativa col binario passato.