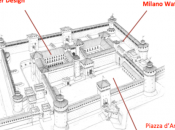l’articolo 27/10/2014 di Rossella Bufano
A che punto siamo con le barriere all’entrata per il lavoro delle donne?

Donne che lavorano. Tra ruoli e difficoltà da superare (Franco Angeli, 2012)
Monica Legittimo (Donne che lavorano. Tra ruoli e difficoltà da superare, Franco Angeli, 2012, con utile Introduzione di Rosalba Nestore) osserva che nel periodo 1960-80 vennero rimossi gli ostacoli giuridici all’accesso al lavoro delle donne: le si ammette a tutte le professioni compresa la magistratura (l. 66 del 1963), si vieta il licenziamento per matrimonio (l. 7 del 1963), si introduce la parità di trattamento retributivo (l. 903 del 1977). Eppure ancora oggi ci si misura con la difficoltà a ricoprire posizioni di rilievo e ruoli dirigenziali; la ghettizzazione professionale (scarsa presenza in ambiti tradizionalmente maschili e tendenza a lavorare in settori considerati “femminili”: istruzione, sanità, ecc.); e con la disparità di remunerazione, nonostante le donne siano spesso più produttive e abbiano raggiunto livelli di istruzione superiori a quelli maschili.
La studiosa si serve dei dati Istat e Isfol 2009-10: in Italia il numero di donne occupate è inferiore a quello degli uomini (il 46,4% contro il 68,6%), ma nel Sud è addirittura la metà. L’aumento dell’occupazione femminile è di tipo quantitativo più che qualitativo. Aggiungiamo noi che questi dati vengono confermati dall’ultimo rapporto Istat (2014). Dunque la crescita si è arrestata[1].
Legittimo sottolinea il persistere del gender pay gap, soprattutto nelle professioni intellettuali-scientifiche (+25,3% per gli uomini) e fra agricoltori e operai (+21,1%). Il gap è maggiore per le donne con bassa (15%) o alta (13%) scolarizzazione, mentre si riduce per le diplomate (10%). Le donne sono quindi più esposte al rischio di povertà, poiché da salari più bassi conseguono pensioni più ridotte[2].
L’autrice, utilizzando una vasta letteratura, descrive le cause sociali e psicologiche che ostacolano ancora il lavoro femminile, e le verifica su un campione. Le cause sono diverse: gli stereotipi di genere, la percezione della propria autoefficacia, la possibilità di conciliare i tempi di vita-lavoro.
Gli stereotipi sin dall’infanzia indirizzano uomini e donne a una diversa percezione di sé: gli uomini alla leadership e alla competizione, quindi ad attività imprenditoriali e di comando, con ambizioni di carriera; le donne, alla cura, la comprensione, la mediazione e alle relative professioni. L’autoefficacia, ovvero l’idea di poter “riuscire” nel lavoro, per le donne varia a seconda della tipologia professionale: è alta nei ruoli tipicamente femminili, si riduce in quelli maschili.
In questi ultimi (politica, management, ecc.) gli uomini non riconoscono competenze e abilità alle donne, tanto che queste devono faticare il doppio per ottenere lo stesso rispetto e subiscono spesso battute sessiste. Per di più le donne si trovano imprigionate in atteggiamenti e linguaggi maschili (spesso si accusano le donne in politica di comportarsi come gli uomini) che favoriscono la diffidenza anche delle altre donne. La scarsa presenza di donne in certi ruoli è ascritta anche alla loro tendenza a rifuggire situazioni di stress generati dalla competizione e alla mancanza di modelli femminili.
Non ultima vi è la difficoltà oggettiva di conciliare vita e lavoro, maternità e orari di lavoro o spostamenti e trasferimenti.
L’indagine, svolta nel Salento, ha confermato la maggior parte delle analisi compiute dalla letteratura: è maggiore l’autoefficacia percepita nei settori sanità e educazione (le donne intervistate sono motivate soprattutto dalla soddisfazione personale); c’è disagio per la competizione e preferenza per la mediazione e la comprensione. Le donne impiegate in lavori maschili lamentano l’imprigionamento in linguaggi e atteggiamenti maschili che non consentono loro di ottenere la stessa attenzione. Diversamente dalla letteratura, hanno tutte dichiarato di poter contare sulla famiglia per la conciliazione vita-lavoro (ma la maggior parte delle intervistate non ha figli).
Molte indagini però rivelano un basso tasso di natalità nel Sud per la mancanza di servizi sociali aggiunta al mancato aiuto dei parenti, contro un alto tasso di natalità in regioni con sviluppati servizi sociali[3].
Legittimo evidenzia anche il gap di genere in ambito politico (sebbene recentemente, in Italia, esso si sia ridotto per volontà di alcuni partiti).[4]
27 ottobre 2014
[1] Nel 2013 l’occupazione maschile è scesa al 64,8% (Rapp. Istat 2014). Ciò ha accresciuto le donne breadwinner, che sopperiscono alla disoccupazione del partner, soprattutto nel Sud. Invece l’occupazione femminile è cresciuta in Germania (+7%), Belgio (+4,8), Austria (+4,5), Svezia (+3) e Regno Unito (+2,5), soprattutto nella sanità e assistenza sociale, seguite da educazione e formazione. Cfr. http://www.istat.it/it/files/2014/05/Rapporto-annuale-2014.pdf
[2] Vedi Gosta Esping Andersen, La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglie, welfare, il Mulino, Bologna, 2011.
[3] V. R. Bufano, L’occupazione femminile favorisce la natalità (e lo sviluppo), Sviluppo Felice 15/10/ 2013,.
[4] La stessa tendenza fu riscontrata nei paesi scandinavi da B. Gelli, T. Mannarini, Gap di genere e gap intragenere, in B. Gelli, G. Lavanco, M. Mandalà (a cura di), Essere donne al tempo delle nuove tecnologie, F. Angeli, Milano, 2007.