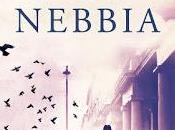Quando sono tornato a casa dal lavoro, verso l’1 e mezza, ‘era mia madre. Mio padre non arrivava, il che era apparso abbastanza strano, ma lì per lì uno si dà le spiegazioni più normali. Gli era già capitato di aver lasciato la macchina parcheggiata con i fari accesi e magari gli si era scaricata un’altra volta la batteria o poteva aver avuto qualche altro problema. Ma non c’è stato molto tempo per riflettere. Stavamo guardando una tv locale, non mi ricordo neanche come mai perché di solito a quell’ora guardo i telegiornali nazionali.
Su Rete7, invece, diedero la notizia dell’assalto all’armeria di via Volturno. Non dissero precisamente cos’era accaduto, dissero solo che c’erano due persone colpite. Si capiva che erano decedute, ma non benissimo. Ho però guardato mia madre e ho iniziato a chiamare il 112 per chiedere ai carabinieri se loro avevano notizie, ma invece di quelli di Bologna mi rispondevano quelli locali, di Castel San Pietro, che ne sapevano meno di me. Non vedendo che altro fare, ho preso l’auto e sono corso a Bologna a vedere cosa fosse successo.Sono arrivato nello stato d’animo che tutti possono immaginare e c’era via Indipendenza transennata già molti metri prima, all’altezza di via Righi- Lì ho abbandonato l’auto per correre verso via Volturno, ma non mi ci hanno neanche fatto arrivare perché avevano già fatto i rilievi e i corpi erano stati portati via. Così i vigili mi hanno consigliato di andare in questura e arrivato lì la cosa buffa, assurda, paradossale per certi versi, è che mi sono messo buono ad aspettare che qualcuno mi dicesse qualcosa. Ho aspettato parecchio e quando mi ricevettero mi fecero soprattutto delle domande invece di rispondere alle mie. Alla fine chiesi solo dov’è mio padre e mi dissero che era all’obitorio, in attesa dell’autopsia e sulle mie gambe sono andato a riprende l’auto che era ancora in via Indipendenza e ho raggiunto medicina legale.
Qui un medico me l’ha fatto finalmente vedere e così si è conclusa una giornata in cui mia madre era a casa serena, mio padre era uscito come tutti gli altri giorni per andare a Bologna a fare uno dei mestieri – il commesso di negozio – più tranquilli del mondo e io ho saputo cos’era accaduto dalla televisione. Alla fine ho ritrovato mio padre su un tavolo d’obitorio e quello che non dimentico è il suo sguardo, come attonito, interrogativo, come uno che chieda “che cazzo sta succedendo?”
Le parole sono di Alberto Capolungo, figlio di Pietro, ex carabiniere in pensione ucciso il 2 maggio 1991. Era un giovedì all’apparenza come tutti gli altri, un feriale come tanti nel centro di Bologna, in cui la gente va e viene e i negozi, stretti sotto i portici, sono aperti. Tra questi, in via Volturno, una traversa della centralissima via Indipendenza, c’è un’armeria a cui si accede solo dopo aver scampanellato. All’interno, si scoprirà a metà di quel giorvedì mattina, ci sono due morti. Sono Licia Ansaloni, la proprietaria, e Pietro Capolungo, il commesso. Due morti in pieno giorno, a pochi metri da uno dei ristoranti più noti del centro cittadino, all’interno di un esercizio commerciale frequentato spesso da poliziotti e carabinieri. Tutto, ufficialmente, per rubare due Beretta del valore di 700 mila lire.

Non è la prima volta che a Bologna accadono fatti del genere, quelli che si ascriverebbero alla periferia degradata di qualche metropoli dove la delinquenza dilaga senza che sia possibile porvi un freno. E invece intorno al capoluogo emiliano, al centro di una provincia complessa e importante, si aggira da anni una banda, la banda della Uno bianca, che compare, spara, spesso uccide e poi svanisce.
Ogni volta si materializza, quasi fosse un fantasma o un simbolo, un’auto di piccola cilindrata, una di quelle che si trovano ovunque perché costano poco. Così finisce che in tanti le hanno comprate e non danno più nell’occhio. Ma essendo così diffusi, quei veicoli, suggeriscono anche altro: la minaccia può arrivare in qualsiasi momento, da chiunque, perché chi uccide, in questa provincia che si dà arie da gran signora progressista, si nasconde sotto le spoglie della normalità. Inoltre, quando colpisce, la banda lo fa con determinazione, è spietata, incomprensibile nella sua eccessività. Sembra uscita da un’azione militare di quelle cattive, infonde paura alla gente che non ha alcuna possibilità, alcuna preparazione, per anche solo abbozzare una difesa.

Questa storia cattiva inizia il 19 giugno 1987 e si concluderà il 21 novembre 1994. Quasi sette anni e mezzo durante i quali verranno uccise 24 persone e 102 resteranno ferite. Inizia con una rapina al casello di Pesaro, sull’autostrada A14. È in questa data infatti che nasce la banda della Uno Bianca. Dopo la prima rapina, ne avvengono altre 12, tutte nel giro di due mesi, e per compierle berrà utilizzata la Fiat Regata di Alberto Savi.
Siamo così nel pieno della prima fase della banda, la meno violenta, che però inizia a virare presto verso toni più pesanti, azioni più impavide. Accade quando il proprietario di un concessionario d’auto riceve una serie minacce: è un’estorsione e per convincere il commerciante a pagare saranno messi a segno alcuni attentati contro le vetrine del suo punto vendita. I banditi, nelle loro richieste di denaro, gli intimano anche di non rivolgersi alla polizia, ma il proprietario informa comunque le forze dell’ordine che organizzano una trappola. Scatta il 3 ottobre 1987: un poliziotto si nasconde nella vettura che dovrà consegnare il denaro e un’auto civetta segue quella guidata dal proprietario del concessionario. Il quale dovrà fermarsi a ogni cavalcavia lungo l’autostrada A14 fino a quando non troverà un corda penzolante a cui legare la valigetta col denaro.
Però la banda degli estorsori si accorge probabilmente della presenza delle forze dell’ordine e apre il fuoco. Resterà ucciso, dopo una lunga agonia in ospedale, il sovrintendente di polizia Antonio Mosca, 39 anni, e rimarrà ferita Addolorata Di Campi, un’agente ai tempi poco più che ventenne. È lei che fonderà a Rimini, una volta che tutta questa storia sarà finita, l’associazione delle vittime, poi trasferitasi a Bologna con Rosanna Zecchi che ne assume la presidenza. Tornando a quell’ottobre 1987, siamo di fronte al battesimo di sangue dei Savi.
 Da qui in poi cambiano gli obiettivi della banda: dalle rapine di notte ai caselli autostradali, si alza il tiro e si punta agli uffici postali e ai supermercati. Per chi ha seguito tutta la storia della Uno banda, questa è la seconda fase, quella in cui in cui si assottigliano i bottini ma aumentano i morti e i feriti. Per lo più si spara, ma non solo. Il 19 febbraio 1988, per esempio, durante la rapina alla Coop di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, si ricorre anche all’esplosivo: una piccola carica viene piazzata vicino alla cassaforte. Dopodiché i banditi attendono che arrivi il furgone portavalori con le guardie giurate che devono ritirare l’incasso della giornata. E quando accade l’azione inizia con l’esplosione e poi una pioggia di proiettili che bersaglia i vigilantes. Il bilancio dell’incursione tra le guardie giurate è di un morto, Carlo Beccari, e di tre feriti.
Da qui in poi cambiano gli obiettivi della banda: dalle rapine di notte ai caselli autostradali, si alza il tiro e si punta agli uffici postali e ai supermercati. Per chi ha seguito tutta la storia della Uno banda, questa è la seconda fase, quella in cui in cui si assottigliano i bottini ma aumentano i morti e i feriti. Per lo più si spara, ma non solo. Il 19 febbraio 1988, per esempio, durante la rapina alla Coop di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, si ricorre anche all’esplosivo: una piccola carica viene piazzata vicino alla cassaforte. Dopodiché i banditi attendono che arrivi il furgone portavalori con le guardie giurate che devono ritirare l’incasso della giornata. E quando accade l’azione inizia con l’esplosione e poi una pioggia di proiettili che bersaglia i vigilantes. Il bilancio dell’incursione tra le guardie giurate è di un morto, Carlo Beccari, e di tre feriti.
Ma non è questa l’unica volte in cui si ricorre all’esplosivo. Succede anche il 15 gennaio 1990 in un colpo a un ufficio postale di Bologna, in via Emilia Levante. I banditi arrivano nel giorno in cui vengono pagate le pensioni e i locali sono pieni di gente. La bomba, secondo quanto diranno a processo, doveva servire per sfondare la barriera che separa il pubblico dagli impiegati, ma la carica è eccessiva e finisce quasi a strage: oltre quaranta saranno i feriti, di cui uno gravissimo, Luciano Cavina, che rischia il dissanguamento a causa delle ferite alle gambe e che per anni subirà interventi chirurgici per rimuovere tutte le schegge che lo hanno raggiunto.
Come negli altri casi in cui si ricorre all’esplosivo, anche l’ordigno usato alle poste di via Emilia Levante era stato costruito da Roberto Savi che – si ricostruirà a processo – aveva imparato a fabbricarli in gioventù quando, abbandonate le istanze troppo moderate della destra partitica, si avvicina a organizzazioni estremistiche, come Ordine Nero, e conosce personaggi i cui nomi sono legati alla storia degli anni di piombo, come Nestore Crocesi. Il quale, nelle pagine che raccontano la strategia della tensione, viene ricordato in relazione al “giovedì nero di Milano”: una manifestazione indetta dal Movimento sociale che ebbe luogo il 12 aprile 1973 e nel corso della quale morì l’agente di polizia Antonio Marino, colpito da una bomba a mano.
Nel caso della rapina dall’ufficio postale di Bologna si disse che Roberto Savi sbagliò a costruire l’ordigno. Ma di certo un effetto quell’esplosione lo ottenne: contribuì a un crescendo di terrore per le strade della città e della regione. Finora, questo terrore si era nutrito di benzinai, casellanti autostradali e di guardie giurate. Ma c’è un’ulteriore fonte, che con le rapine sembra non centrare. Gli attentati ai carabinieri.