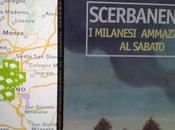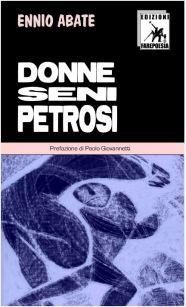
Il 22 ottobre alle ore 18
alla Libreria Odradek
Viale Principe Eugenio 28
(tel 02.314948)
Paolo Giovannetti
presenterà la raccolta
Donne seni petrosi
di Ennio Abate
pubblicata dalla casa editrice
Farepoesia di Pavia.
Le donne, sì, seni petrosi
contro fantasticati, molli seni
a strapparmi il filo del respiro.
E bambocci si chinano gli ometti
dinanzi ai femminili simulacri:
terribile Madre, Figlia sventata
Amante che fra quelle si dibatte.
E più spazio rivendicano.
Ma dove?
Nel mio letto, nel cuore
o dentro il mio intelletto?
*
Vendimi un po’ del tuo odio sfuso
padroncina dei miei bisogni.
Faccio tardi, faccio notte a pregarti.
Solo lacrime versa lei
sul mio pane salato di rancore.
L’amore non si vende, m’insegna.
*
Ancora il soppalco, gli scaffali smontati.
Ancora un trasloco!
E dove dormirò stasera?
Ehi, tu che comandi
dammi spiegazioni.
Ti smonti tutto da solo, fratellino.
Te lo sei voluto tu il trasloco
in altro indefinito loco.
*
Uomo da donne fatto a pezzi
mi ricomporrò mai nei corpi famminili -
quello materno, quelli brucianti
quelli delle rissose
della dolce ballerina di valzer
della muschiosa fanciulla, l’intravista?
*
Gironzolavo per una città di mare
gironzolavo come per amare
guardavo nei bar vicino al mare
così vagando, per osservare.
Poi con una per mano andavo.
La portavo in collina e poi in città
verso il mare
chissà se per amare o solo per guardare.
Ci unisce cosa? ci domandavamo.
Non il corpo che adesso si riposa.
Allora cosa? Il dolore, rispondevamo
che sta nel mare e sreve per amare.
*
Armeggio con gli occhiali, confondo.
Ho problemi di vista e di visione.
Tenere o no le distanze? misurarle? annullarle?
Poi – bontà sua! (del sogno o di lei?)
mi cavo d’impaccio:
ho già su le lenti a contatto.
Il contatto dunque c’è
con lei, col mondo, spero.
*
Prefazione
di Paolo Giovannetti
Al lettore del “narratorio” di Ennio Abate innanzi tutto direi di affrontare queste poesie in maniera lineare, orizzontale, in senso stretto poematica, prima cioè di aver preso visione della prosa autobiografica e storicizzante che lo conclude. Ne esce un racconto, discontinuo ma non dissipato, che – attraverso il progressivo allontanamento da antiche identità maschili – è in grado di elaborare un rapporto non troppo conflittuale con la femminilità. Grazie anche alla mediazione della “baldracca” storia, un soggetto enunciatore, un io che dice la propria esistenza, sente di poter lasciare qualcosa come un’eredità a un tu femminile – e di tanto più giovane – desideroso di conoscere.
Non solo, e anzi soprattutto: quell’io non è un dato ma è una conquista, raggiunta nella seconda parte dell’opera, e consolidata liricamente nella terza, dove a parlare è un perplesso Don Giovanni pezzente, ultima delle maschere tematiche che ritmano il libro. Le prime due essendo un Robinson alle prese con una “sposa femminista” perduta, e la seconda una metamorfosi (un “discendente”) del leopardiano pastore errante, messo in crisi dall’incostanza della madre-luna.
Beninteso, c’è anche un (lasciatemelo dire) bellissimo antefatto, che evoca il distacco avventuroso e leggermente sentimentale (patetico nell’accezione buona del termine) da valori maschili ereditati, e insieme da un mondo – tra il contadino e l’urbano – di povertà. E parlo di un “consolidamento lirico” all’insegna di Don Giovanni, anche perché la voce risentita che recita in nome del pastore errante lo fa con una teatralità e una vera e propria ironia (grazie a un uso, peraltro minimo, del dialetto e più in generale a una forma di gesticolazione sopra le righe) che nella terza parte si perde del tutto.
Questa poesia, dico, non solo tematizza un percorso – secondo un narrare “oratorio”, vocalissimo e argomentante, che forse spiega il neologismo narratorio – ma agisce in modo straniato, differenziando, dissimilando. L’oggettivazione si alterna alla soggettivazione, in maniera in parte imprevedibile; e ciò ci mantiene al di qua di un’identificazione troppo immediata. Certe strategie sono poi proverbialmente novecentesche, a volte ossimoriche, magari anche sul piano delle forme; chessò: il niente di sonorità (la rima-zero) che scandisce versi per l’occhio; e poi il cortocircuito dei ritmi dentro la prosa (si ascolti il dattilo, o anfibraco, palazzeschiano, nella serie “Lei chièda distràtta. Lei scèlga la dànza. Io sòlo le buòne macèrie, per òra, le pòrgo”, p. 77), nonché la rima spiattellata e sovresposta provocatoriamente (“Gironzolavo per una città di mare / gironzolavo come per amare”, p. 62). Che Abate impari un po’ da Fortini – diciamo, soprattutto dall’ultimo Fortini – lo si può cogliere anche solo leggendo il pensoso Commiato, inciso in ipotiposi: dove il dire e l’oggetto del dire si fondono per sottolineare l’artefatto della scrittura, il suo essere prodotto di un’intenzione umana per nulla naturale.
Certo, una specie di soggettivismo, molto invadente perché affidato alla prosa, può talvolta risultare eccessivo e suggerire forme di abbandono liricistico non del tutto controllate (sintomo ne sono sintagmi come “Donne, giovanili prede”, “la mia ferita di incerta lussuria”, “incorporeo fantasma di tiepida vergogna”, e come un – di nuovo – dattilico nonché clausolare “assiduo riguardo all’antico fulgore”; il tutto a p. 81). Ma è probabile che si tratti solo di episodi, efficacemente contestati da quanto viene subito prima o subito dopo.
Questa poesia, lo ribadisco, ci mette di fronte alla necessaria contraddittorietà di ogni costrutto poematico, tanto più fragile quanto più voluto, tanto più necessario quanto più diffratto dalla varietà degli stili e delle voci. Però, poi, il lettore arriverà alla nota finale e trarrà le sue conclusioni circa il senso autobiografico del racconto.
Parte integrante del testo, del libro che abbiamo in mano, anch’essa, quella nota, richiede una risposta critica. La mia è di sconsolata (non mi viene in mente un altro aggettivo) ammirazione per il coraggio che un intellettuale “maschio” ha di riconoscere la vitalità del pensiero e delle pratiche femministe – oggi relegate a una condizione di sostanziale oblio. C’è persino il rischio che qualcuno, nel 2010, non sappia nemmeno di che cosa stiamo parlando. La cultura italiana contemporanea sta facendo strame anche di questo tipo di memoria, con pratiche e dispositivi variamente modulati. Il più innocuo dei quali – lo dico dalla nicchia specialistica che mi capita di coltivare – è forse la quasi totale assenza di gender studies nel sistema universitario italiano, clamorosa eccezione entro un mondo occidentale che ha inalveato – in modo però non sempre indolore – l’antico radicalismo femminista nel “metodo” della ricerca accademica.
Resta, saldamente, il bilancio della poesia. La gatta del femminino, nella poesia di Ennio Abate, spiazza e anzi spesso fa fuori i sempre più indifesi cani e cagnolini del mondo maschio. Le madri (persino la città-matrigna) feriscono l’uomo che protezione e ricovero da loro si aspettava. La poesia è sessuata, e non può che cantare la sconfitta di un io il quale eventualmente cerchi una conciliazione. Bene. Proviamo a ripartire da qui, dal Robinson in balia del mare urbano ostile. Dopo il più glorioso dei naufragi.
*
Postfazione dell’autore
A metà anni Settanta, come non pochi militanti della cosiddetta «nuova sinistra», mi inoltrai nei territori “forti” del femminismo. Era un’epoca in cui marxismo e psicanalisi parevano in via d’avvicinamento. Sembravano confermarlo certe mie letture di testi femministi (di Mitchell, Melandri, della stessa Irigaray), i dialoghi serrati con compagne, amiche e soprattutto con la donna – moglie, compagna e madre dei miei primi due figli – con la quale da tempo vivevo.
Mi ci inoltrai con la stessa (sventata?) volontà di apprendista del mestiere di vivere, che all’inizio degli anni ’60 m’aveva sostenuto nel trapianto a Milano da una città del Sud (Salerno), poi come lavoratore-studente nell’occupazione della Università Statale di Milano tra fine ’67 e inizi del ’68 e poi nello studio di Marx, Lenin, Gramsci, Fortini ed altri, autori prima a me ignoti.
Presto però le femministe scombinarono le mediazioni, calcolate o ingenue, architettate per “addomesticarle”. E furono proprio i gruppi di sole donne, le loro manifestazioni separate dagli altri cortei del movimento nella Milano convulsa e plumbea della fine degli anni Settanta a preannunciarmi la fine della «rivoluzione».
La comunità dei compagni (o il sartriano gruppo in fusione) si svelò più ingessata e asfittica di prima, quando il disagio di appartenervi mi veniva dalla percezione dello scarto di potere (mascherato o taciuto) tra dirigenti e diretti. Ora, sotto la pressione femminista, la sentivo arroccarsi nell’ambivalenza di chi è di fronte a un aut aut imprevisto: o rinunciare al potere ordinatore dell’organizzazione politica (e fu la scelta che fece «Lotta Continua» “sciogliendosi”); o mantenerlo ance a costo d’irrigidirsi in formule dogmatiche e catechistiche, che schiacciavano i nuovi bisogni delle compagne, le quali – testarde, insolenti, arrabbiate, agguerrite, separatiste – pretendevano di essere soltanto donne e soprattutto contro quel noi, che pareva com-prenderle.
Dopo varie avvisaglie, la tempesta femminista, seguita da uno stillicidio di separazioni di coppie di compagni, amici, amiche, conoscenti, arrivò anche addosso a me, che forse m’illudevo di evitarla per la singolarità della mia esperienza solitaria di immigrato esterno ai branchi di “soli maschi”. E dovetti recitare, da attore impreparato e allo sbando, nel dramma di una separazione impostami da una «sposa amara, luccicante di lacrime e tenace nell’amore più proibito», di botto estranea e in più spalleggiata nel suo pur dolente distacco da una a me inaccessibile comunità di donne.
In quel frangente il femminismo fu per me il nome della lama di coltello che proprio la donna con me da anni – riserva (in un immaginario arcaico e patriarcale?) quasi certa d’amore e d’affetto, cuscinetto tra me e il mondo più crudo e ostile – usava (ferendomi) per allontanarsi. Un lutto amoroso s’aggiungeva al lutto politico per la perdita della comunità dei compagni.
In anni successivi, rielaborando quel doppio lutto, ho accostato la sofferenza mia e della nostra generazione (penso di poter dire) a quella dei tanti sconfitti della storia, di cui parlò Ernesto De Martino. Eppure – mi sono detto – c’è una differenza: io/noi non possedevamo un mondo, un consolidato Eden, piccolo o grande, dal quale a un certo momento venivamo scacciati. Avevamo appena iniziato a costruirlo il possibile mondo, la possibile città futura. Ne avevamo tirato su appena un simulacro provvisorio (o un’allegoria) – tale mi pareva il Partito che insieme si voleva costruire – per contrastare un Potere di classe, questo sì potente e radicato da secoli nelle menti e nella realtà materiale. E, mentre una Ristrutturazione tuttora sconvolgente già erodeva e poi travolgeva quella classe operaia, alla quale avevamo legato le speranze di riscatto anche dalla nostra condizione subordinata di intellettuali di massa, vedevamo sorgere dall’interno del comune cantiere, una forza femminile e femminista avversa e minacciosa, che lo smantellava, sostituiva i precedenti simboli con altri esclusivi e propri; e, in certi casi, non esitava ad allearsi con il «Nemico», sbarazzandosi di noi senza esitazioni.
La scrittura anche di questa mia terza raccolta poetica s’è mossa per anni attorno a questo nucleo di sconfitta personale e storico. È ripartita dal “terra terra”, perché lì ero finito. Per esprimerne i grumi più pesanti e le fasi della sofferenza ho indossato tre maschere (Robinson, il discendente del pastore errante, don Giovanni pezzente).
Sono archetipi di un passato letterario a me caro e a cui avevo avuto accesso. Li ho desublimati, trapiantandoli in una periferia galleggiante in un vasto chissà dove. Sono serviti per abbandonare – in parte scrivendo da solo, in parte col sostegno di un giovane analista – quel mio mondo finito in pezzi. Aggirandomi nel mio Ade, tali maschere hanno calamitato, rabbonito, indotto a compassione o a collaborazione una folla notturna di fantasmi, di certo più oscura, immobile e a tratti quasi indecifrabile di quella diurna, che in anni precedenti – gli anni della politica – avevo più agevolmente avvicinato grazie alle scorrevoli mediazioni della donna che mi viveva accanto, dei compagni e delle compagne.
Al narratorio di versi-prosa di quel «periodo nero» ho aggiunto – omogenei per contenuto e forma – i disegni a carboncino del mio alter ego artistico, Tabea Nineo. Lo pubblico tardi, postumo quasi: lontanissime le vicende trasformate in parole e le psico-scritture successive, con le quali ho rovistato nei fondi scuri del sogno e della memoria d’infanzia.
Nella sua genesi e sistemazione hanno contato il silenzio di figure reali qui evocate e le perplessità di amiche e amici, che hanno letto la bozza. E anche il fallimento di un tentativo quasi di simbolica riconciliazione col femminismo, che si era delineato alcuni anni fa, quando io e un’amica poetessa femminista progettammo di pubblicare in un unico volumetto, in parallelo e in modo quasi complementare, questa mia raccolta assieme a una sua. Erano nate indipendenti l’una dall’altra ma sul medesimo tema: un rapporto amoroso uomo-donna.
Risultò invece vana (per caso?) la ricerca di un padrino e una madrina, che avrebbero dovuto scrivere le rispettive prefazioni. E neppure ha poi avuto seguito l’intenzione di presentarcele noi: io la sua, lei la mia. Per un crescente (e reciproco) scetticismo, credo. Alla fine – e qui parlo solo per me – non me la sono sentita di essere il rappresentante di una scrittura “maschile” o “al maschile” né di riconoscere lei come la portavoce di una scrittura “femminile” o “al femminile”.
Anzi il dubbio che l’immaginario non sia così nettamente separabile in maschile e femminile, come lasciano credere i mass media o si ibridi facilmente secondo un certo psicanalismo, si è rafforzato in me. Assieme al sospetto che la disinvoltura con cui si trattano tali questioni nasconda la rimozione e il venir meno di una riflessione critica sullo scontro storico che ha visto, a fine Novecento, la sconfitta sia dell’ipotesi comunista sia dell’ipotesi femminista.
Se prima, nelle società occidentali, il conflitto di classe oscurava il conflitto di genere, oggi anche quello di genere, venuto per brevi anni in evidenza politica e culturale dopo il ’68, s’è opacizzato: in parte riassorbito dalla società dello spettacolo; in altra parte fluente carsicamente nelle pieghe della società e pensato solo nelle “catacombe” di alcuni circoli di donne; e in altra parte ancora accolto (non senza reali resistenze) liberalmente soprattutto in ambienti accademici (gender studies).
Alla vulgata sia della fine della storia che del postfemminismo o della femminilizzazione trionfante nel lavoro delle società post-fordiste, ho preferito una riconsiderazione storica sia del comunismo che del femminismo: entrambi per me rovine di un fine Novecento da interrogare e reinterpretare per leggere nelle trasformazioni in corso – non certo benefiche per i molti uomini e donne del pianeta – qualcosa d’altro.
Non credo che il mio narratorio sia misogino o antifemminista, ma più monologante che dialogante di quanto desideravo, sì. Per costrizioni esterne e per scelta meditata e consapevole poi. Da qui l’attestarmi in una pacata difesa del vissuto che sta alla base di Donne seni petrosi. E anche della forma – amara, smorzata, cupa, “cruda” – di certi testi e dello stesso titolo.
Considero tali aspetti “da vecchio”, quale sono in effetti diventato, una faticosa conquista compiuta soprattutto attraverso la scrittura. E voglio conservarli, discuterli pure, ma non scioglierli con disincanto in una tardiva, impossibile, astorica, artificiosa nuova armonia tra uomo e donna, tra “maschile” e “femminile”.
Ennio Abate
12 maggio 2010