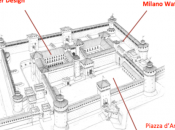Introduzione.
The Invitation
Oriah Mountain Dreamer
|
Cheyenne, Wyoming, 30 novembre 2008
Il nodo che mi serra la gola non ha intenzione di sciogliersi mentre rendiamo l’ultimo saluto al nostro George, Professore di Lettere e Filosofia.
Mi guardo intorno con sgomento, un ronzio lieve accompagna la sua discesa, Jason dondola da un piede all’altro senza alzare gli occhi da terra e Beth singhiozza sommessamente appesa al suo braccio; qualcuno getta un fiore sulla cassa di legno scuro, qualcun altro accenna un saluto con la mano, poi tutti si avviano verso le auto e se ne vanno. Inutile restare qui mentre gli addetti portano a termine la sepoltura.
Jason continua a restare immobile sul vialetto di accesso, per lui George non è stato solo un collega ma l’insegnante paziente e comprensivo della sua adolescenza e in seguito un caro amico. Ci fissiamo mesti, sembra volermi dire qualcosa, ma sua moglie lo allontana con dolcezza e lui si volta istintivamente per un ultimo addio.
Non me la sento di tornare a casa, questa scomparsa mi ha turbato anche se lo conoscevo da pochi anni, così mi avvio verso un angelo di pietra pensando ai suoi modi pacati, ai suoi capelli bianchi, al suo quieto sorriso. Un uomo che amava le parole e sapeva trasformarle in storie per avvolgere l’anima in un caldo abbraccio.
Fa freddo, il silenzio è assoluto, rotto solo dal respiro che si addensa in lenti sbuffi. La nevicata di questa notte ha trasformato il cimitero nell’illustrazione di un romanzo di Dickens. È triste e bellissimo.
Seduta sul basamento, infagottata nel piumino blu navy, con le lacrime ancora strette negli occhi, mi rendo conto che anch’io, come lui, avrei una storia da raccontare, prima di tutto a me stessa, anche se so di non essere altrettanto brava. Perciò lascerò che i pensieri fluiscano liberamente, li lascerò correre e ruzzolare in rapide disordinate fino a che si placheranno a formare il lago di una memoria finalmente innocua.
Cheyenne, giovedì 14 dicembre 2006
“Che ne pensi amico mio?”
Jason alza gli occhi e mi squadra indeciso, ha scavato e ruzzolato col cucchiaino nel dessert tanto a lungo da trasformarlo in una poltiglia indefinibile. Ormai parlo la sua lingua abbastanza bene da farmi capire senza indecisioni, perciò non mi spiego la sua esitazione se non come una forma di disagio.
Siamo amici, ma le nostre chiacchiere della pausa pranzo non si erano mai spinte a questo genere di confidenze. Questa sera però è diverso.
Ha iniziato per primo parlandomi dei suoi dubbi, vorrebbe troncare con la moglie ma non se la sente. Negli ultimi tempi la situazione fra loro s’era fatta pesante e hanno deciso di prendere fiato e riflettere; così Beth e le bambine hanno anticipato di un paio di settimane le vacanze e si sono trasferite in campagna dai nonni. Jason le raggiungerà per Natale. Se dovesse decidersi a mollare tutto davvero non sarebbe un bel regalo per le piccole.
La tavola calda è affollata di gente che va e viene pensando agli affari propri e, sopra tutti, aleggia un motivetto allegro interrotto a tratti dalle battute e dalle risate degli animatori. L’atmosfera è distratta e dispersiva, probabilmente non adatta a una simile conversazione o forse, proprio per questo, appropriata.
“E così sei venuta qui”.
“Già, se fossi rimasta non avrei saputo ricominciare. Non incontrando ogni giorno le stesse facce, gli stessi occhi. Mi sentivo chiusa in un barattolo. Senza aria, senza luce. Dovevo cambiare tutto o mi sarei persa di nuovo”.
“Ma perché così lontano?”
“Proprio per essere così lontano, abbastanza da scongiurare anche il più casuale degli incontri. Out! Tabula rasa! Tutto nuovo, diverso, difficile da imparare per non avere il tempo di lasciarsi andare ai ricordi”.
“Eppure è proprio di ricordi che abbiamo parlato”.
“Sì, ma è passato tempo a sufficienza da renderli meno dolorosi. Del resto, con tutto l’impegno che puoi metterci, il passato non ti molla mai”.
Sorrido senza essere credibile. La sua espressione amara e un po’ interdetta, invece, non lascia dubbi.
“Accidenti, Alice, non so che dire”.
Pronuncia il mio nome all’americana, come tutti qui. Io l’ho accettato come un regalo, perché è stato un po’ come cambiarlo, un modo in più per prendere le distanze dalla mia vecchia vita e Dio solo sa quanta fatica c’è voluta per riuscirci.
Il nostro tavolo è vicino alla vetrata e dietro le tendine a quadroni rossi la via è invasa dalle luminarie, a dire il vero in questo periodo l’intera città assomiglia a un gigantesco Albero di Natale. Accanto all’entrata il vecchio Bill, col costume rosso e la barba finta, scampana e distribuisce caramelle facendo ballare la sua enorme pancia vera, sbuffando nuvolette di fiato denso ogni volta che ride. Ha il naso arrossato, ma dubito che sia solo per il freddo.
Jason intanto è passato a tormentare il tovagliolo.
“Certo che li sai tenere bene i segreti! Cosa ti ha ferito di più?”
“Non lo so, tante cose. Alla fine mi sentivo una nullità, un’inutile superflua presenza cui si concede la sopportazione come un favore, e che conviene usare, visto che c’è. Credo che fosse proprio questo, più di tutto la mancanza di considerazione. Può essere tagliente come un rasoio, sai? O pesante come una mannaia”.
Sta cominciando a nevicare. Era nell’aria da questa mattina, il cielo aveva quell’inconfondibile colore lattiginoso che ti fa continuamente alzare lo sguardo in attesa dei primi fiocchi. Ci voleva la neve, fra poco è Natale e da quando sono qui non è mai mancata: anche questo è un regalo.
“Pensaci Jason, il divorzio è una scelta definitiva. Un piccolo uragano domestico. Non illuderti di passarci attraverso indenne. Anche se ce la metterai tutta, non potrai impedire che qualcosa sfugga al tuo controllo. Qualcosa di molto importante, come il rapporto con le tue figlie, per esempio. Davvero va così male con Beth? Pensaci, non credo tu lo voglia veramente”.
Mi alzo per pagare il conto e lo saluto con un abbraccio malinconico perché è vero, i ricordi hanno perso il loro potere distruttivo ma non la tristezza e stasera so che non mi abbandoneranno facilmente. Anche se non rimpiango nessuna delle mie decisioni, certe notti sono più lunghe delle altre.
Appena fuori, mi tiro su il cappuccio del Montgomery. Nevica proprio bene, a larghe falde soffici e asciutte, leggere come piume e avrei voglia di restare qui in mezzo alla strada fino all’alba a guardarle danzare nelle luci… potrei se volessi. Ora posso, se voglio posso. È una bella sensazione. Non aprirò l’ombrello, non ce n’è bisogno, non abito lontano, lascerò che mi solletichino il viso e mi raccontino una storia. Magari una poesia. Poi scuoterò il cappotto, mi infilerò sotto le coperte e resterò a guardare i fiocchi cadere nella cornice della finestra a saliscendi, accumularsi sul corrimano della scala antincendio, finché mi addormenterò in un letto tutto mio.
Cammino piano, non per paura di scivolare, ma per ascoltare le risate dei bimbi, i brandelli di vita che sfuggono dai portoni richiusi in fretta, il carillon di Mamy Rose, i latrati festosi di un cane e i miei passi scrocchiare sempre più forte.
C’è un odore dolce che aleggia lungo i marciapiedi della Central Avenue, un sentore stucchevole di buoni sentimenti, croccante e zucchero filato che seduce e inquieta. È quasi Natale.
Mentre attraverso l’incrocio con la Sedicesima, due ragazzi mi passano accanto sorreggendo a fatica un abete enorme e mi salutano. Non li conosco, chissà per chi mi avranno scambiata, ma il profumo pungente dell’albero mi resta addosso, mi segue fino a casa e ora che sono arrivata quasi mi dispiace lasciare la via. Così mi attardo davanti al portone e, mentre osservo la bandierina che il Sergente O’Connel ha piazzato in mezzo alla corona augurale, non posso fare a meno di pensare come tutto assomigli a uno spot, a una di quelle cartoline hollywoodiane stile anni cinquanta, eppure è tutto incredibilmente vero. Sono veri i cowboys infagottati nelle giacche di montone che scuotono la neve dagli Stetson bianchi con lo stesso gesto secco che usano per la polvere, quella polvere sottile e vellutata come una cipria che regna ovunque, sull’altopiano come in città, che s’insinua nelle fessure e negli abiti, che in estate trasforma la Lincoln in una carovaniera percorsa da nuvoloni rosa pallido, secca la gola e appanna il verde dei giardini e dei parchi. Sono veri i lazos, le sellerie, gli speroni e i copricapo indiani che occhieggiano ovunque dalle vetrine. Sono veri gli Shay-an che lavorano nel rodeo e che durante la stagione dei turisti indossano spesso i costumi tradizionali e si fanno fotografare con dignitosa compostezza, gli sguardi impenetrabili e i gesti misurati. Quelli che vivono in città sono pochi, tuttavia la loro presenza non fa parte del folklore. È storia. Tutto ne è intriso in questa città orgogliosa di essere ancora Far West e ne sono consapevoli loro, la variegata popolazione che la abita e quei visitatori attenti che, accantonata la prima surreale sensazione di vivere in un film, iniziano a vedere più lontano, oltre il manto dei bisonti e i geyser di Yellowstone. Se sai ascoltare qui puoi sentire il volo dell’aquila. Alzando gli occhi la troverai là dove il tuo cuore l’aveva intuita prima che alle orecchie giungesse il suo secco, antico richiamo.
Ho appreso dell’aquila all’Indian Village di Frontier Park, dalle labbra rugose di un vecchio pellerossa, ricurvo e minuto sotto l’immensa acconciatura di piume. Era l’ultimo giorno del mio primo Frontier Days, scattavo foto assieme a un gruppo di italiani e lo ascoltavo divertita senza comprenderlo appieno. E per me sono rimaste soltanto parole finché non mi sono trovata sull’orlo di un dirupo, due anni dopo, col vento che mi sussurrava nei capelli e lo sguardo perso nella serena distesa della Jackson Hole.
Mi è tornato alla mente il significato del secondo nastro del calumet del vecchio indiano, quello rosso del Nord da dove arriva il vento e solo allora ho compreso la medicina dell’aquila, che ti porta in volo attraverso l’ombra delle realtà passate e al di sopra della vita terrena. Là, l’aquila ti insegna a osservare per toccare con il cuore il sole della prima generazione, per amare l’ombra tanto quanto la luce, e poi ti chiede di essere lasciata libera affinché il tuo cuore possa raggiungere la gioia che vuole.
L’aquila è lo spirito della tenacia, è il regalo della visione che ordina le cose e dona loro un senso profondo. È l’equilibrio fra cielo e terra.
È la pazienza per aspettare il momento giusto.
Percorrendo le ampie vie di questa capitale che conta meno abitanti di Olbia, che trabocca di alberi e di casette a un solo piano, dove non ci sono grattacieli ma semplici palazzi, così lontana dal trambusto di New York o di Chicago, dalle luci di Las Vegas e dalle sopraelevate di Los Angeles, ho imparato che in fondo, con tutti i suoi vizi, l’America è ancora un Grande Paese. Con un po’ di polvere di stelle in meno e molti affanni in più, ma con ancora tanto spazio se sai dove cercarlo, abbastanza per sparire e illudersi di non aver mai vissuto prima. Funziona quasi sempre, tranne a Natale o quando qualche amico ti rammenta che vivere in due può essere assai penoso.
Firenze, Italia, dicembre 1999, una vita fa.
Era una strana sensazione, una specie di formicolio interiore; mi sembrava che poco a poco salisse dai piedi e si avvicinasse alla gola. Immagino che, se provasse sensazioni, una bottiglia di plastica che viene riempita di sabbia si sentirebbe così e non sarebbe felice di perdere la propria incosciente leggerezza per diventare contenitore di un tale peso, né di rinunciare suo malgrado alla luminosa trasparenza di cui era ignara fino a pochi minuti prima.
Quel mattino di Natale di sette anni fa, guardando senza nessuna emozione le luci ammiccanti dell’albero, ho imparato una sgradevole lezione: la consapevolezza di sé non sempre è una cosa buona.
Eppure le ghirlande luminose e i globi di vetro scintillanti e orgogliosi della loro estrema fragilità erano gli stessi da decenni. Alcuni risalivano alla mia infanzia, altri erano anche più vecchi, un’eredità di tempi in cui ai rami si appendevano ingenui fiocchi di carta colorata insieme a rare caramelle e le palline di Natale erano autentici gioielli, preziosi incantesimi, spesso solitari, ammirati a bocca spalancata da bimbi che non osavano allungare la mano. C’era un cavalluccio di legno scolpito e dipinto dal mio bisnonno e dagli anni ’50 arrivava una sfera concava grande come un pompelmo, leggera come una bolla di sapone, che racchiudeva un laghetto argenteo in cui due cigni disegnavano un esile cuore coi colli flessuosi. C’era una serie di gocce iridescenti, acquisto del primo Natale da sposata e un etereo Presepe in miniatura racchiuso in una palla di cristallo talmente incolore da far sembrare la scena sospesa in aria, comperato a Roma appena un mese prima. C’era poi una lunga teoria di lanternine, talmente vecchia da non ricordare più di che colore fossero le luci originali, non se ne trovano più di così curate nei dettagli. In alto, sotto il puntale, volava un angelo coi capelli ricci e il vestito di seta che suonava una cetra.
Il mio albero accoglieva una quantità di cimeli in un insieme caleidoscopico assai distante dai modelli monocromatici delle riviste e delle pubblicità, però in questo modo era vivo o almeno così lo sentivo fino a poco tempo prima.
L’albero era lì, lo stesso di sempre, ma senza più alcuna magia. E i regali, sotto i grandi rami di tristissima ecologica plastica, erano solo pacchetti senza incanto corredati di sterili bigliettini da pochi centesimi sui quali non c’erano altro che nomi. La musichetta di sottofondo suonava leggermente stonata per le pile che si stavano scaricando e nessuno sapeva sostituire, il gatto attentava alla precaria stabilità dell’intero apparato nonostante gli urli rabbiosi del padrone e lo Spirito del Natale si era scordato di visitare la nostra casa, così dignitosamente in ghingheri, ma assolutamente gelida.
Io stavo impalata in mezzo al chiassoso via vai di parenti e amici, travolta dagli auguri e dagli innumerevoli baci di circostanza, stanca per i complessi preparativi di quella riunione iniziati nei giorni precedenti e culminati in una levataccia, senza sentire in realtà niente più che un brusio confuso. Non più partecipe, anzi leggermente infastidita da tutto quel brulichio che affollava il salotto, assediava il bagno e che avrebbe lasciato dietro di sé milioni di impronte appiccicose, carte appallottolate per ogni dove e un’altra frenetica lavorata per cancellare il disastro in tempo per il pranzo del giorno successivo.
Mi ero persa inconsapevolmente un bel po’ di pezzi lungo la strada, mi ero tuffata nei preparativi del Natale con l’energia di sempre senza accorgermi che era solo energia, che mancava l’entusiasmo. Ero troppo assorta nel rito e compresa nel ruolo per realizzare che ormai c’era un’altra me che spingeva contro la porta e che io non volevo lasciar né entrare, né tanto meno parlare. Mi rifiutavo categoricamente di prenderla in considerazione e così mi ha colto lei di sorpresa, nell’unico momento in cui ho abbassato la guardia, in cui mi sono fermata per riprendere fiato.
In un attimo la stanza si era fatta piccolissima, i gomiti degli ospiti impossibili da evitare, gli odori sgradevoli e eccessivamente marcati, le parole vuote e inutili. Mi sentivo sballottata e fuori posto in casa mia.
Mentre osservavo mia cognata che, sotto una bordata di sguardi scettici, esibiva il suo nuovo compagno (un tipo ossuto con gli occhiali e il sorriso sghembi), mi chiedevo se davvero fossi lì, se non fosse tutto uno scomodo, spiacevole sogno. Ma ero proprio lì, la teglia delle lasagne mi bruciava le mani, ero lì senza ombra di dubbio e non mi piaceva.
Avevo completamente perso il senso della mia vita ma lo rivolevo indietro e più mi ostinavo a cercarlo, più sbattevo la faccia contro la stessa verità. Avevo sbagliato, tutto quanto, sempre. Mi ero caparbiamente, ottusamente ostinata a vedere solo ciò che volevo vedere, calandomi in un’illusoria realtà alternativa che trovava giustificazione a tutto e a tutti, tranne che a me stessa. Mi ero tappata occhi e orecchie perché non concepivo nemmeno l’idea del fallimento; avevo puntato tutto su un numero che non era uscito, ma facevo finta fosse accaduto. Avevo accettato che l’amore fosse un’arma puntata alla tempia, un ricatto e la sofferenza un prezzo da pagare.
Tratto da “Una stanza vuota” di Francesca Montomoli, Sangel Editore.
__________
Postfazione di Rina Brundu: Una stanza vuota (Sangel Editore) è il primo romanzo della scrittrice grossetana Francesca Montomoli. La protagonista è una Alice che, causa un matrimonio fallito alle spalle, ricerca il suo “paese delle meraviglie” in una America autoctona ideale e idealizzata. Una stanza vuota si risolve quindi nell’essere una sorta di bildung-roman che racconta la crescita personale e intellettuale della protagonista attraverso la sua interazione con l’esterno e attraverso la sua capacità di mettere la propria esperienza e il privato dolore a disposizione di se stessa e degli altri.
Muovendo oltre le dinamiche di fabula, ritengo che molte caratteristiche tecnico-stilistiche nella scrittura della Montomoli possano essere raccontate da questa sua breve poesia Campi d’Africa (2011):
Spirali di pensieri
avvolti
come fumo sparso
dal lento passo
di un presente
assorto
là
dove il futuro
è solo una parola
Una scrittura fondamentalmente introspettiva dunque che attinge la sua vena malinconica da una accarezzata carica poetica ma che nasce e cresce dentro spazi-altri. E questi spazi sono le praterie aperte dove corre una fertilissima immaginazione nutrita da reminescenze salgariane e fascinazioni esotiche come quelle per i popoli nativi americani. Per la loro cultura, le loro avventure fictional e factual, per il loro privilegiare piani mistici e ascetici.
A sedurre l’io-che-scrive di Francesca sembrerebbe essere soprattutto: “La loro spiritualità profondissima, quella innata consapevolezza di non esistere se non come parte di un unico spirito che racchiude e considera ogni elemento dell’universo in egual misura. Un essere umano non è superiore a una foglia o alla terra che la nutre”. Ma l’elemento incarnato non è elemento secondario e lo spirito si scopre ugualmente ammaliato da: “… le uniformi e le sciabole, le cavalcate a pelo, le danze propiziatorie, la carica ipnotica dei canti e dei tamburi, la forza del silenzio, la scaltrezza delle strategie…”; tutti momenti tipici, questi, di ogni cultura indigena ancora capace di interpretare la sua dimensione esistenziale dentro le dinamiche di un universo naturale che è prima di tutto madre-benigna.
Il messaggio implicito e più vero che viene quindi dalla prima prova scritturale di Francesca Montomoli è, a mio avviso, un messaggio di speranza. La convinzione che, nonostante i tempi tristi e a loro modo indecenti, quell’idea di “dream-time”, di schiettezza, di genuinità, di autenticità, di interezza, di libertà dello spirito che permeava la cultura e la tradizione di un altro straordinario popolo quale è quello degli aborigeni australiani, non sia mai morta. Ma vivrà sempre con noi, dentro di noi, in fondo al nostro cuore fino alla fine. Passerà un solo istante dopo… il nostro ultimo respiro. Ad majora, Francesca!
Featured image, raffigurazione pittorica di gruppi etnici in America all’inizio del XX secolo, fonte Wikipedia.