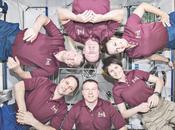Se i petrolieri e in generale le industrie dei combustibili fossili continuano a negare o ridimensionare il rischio dei cambiamenti climatici, potrebbero darsi la zappa sui piedi. È il messaggio di un esperto autorevole del settore: Lord John Browne, ex amministratore delegato della BP e attuale membro del consiglio di amministrazione della Cuadrilla, società inglese specializzata nella valutazione delle risorse energetiche e minerarie.
Lord Browne, intervenendo nel corso di un convegno promosso dal gruppo di consulenza industriale Critical Resource, ha parlato di "minaccia esistenziale" per l'industria mineraria, il cui gradimento sta precipitando nella percezione sociale: l'impopolarità di petrolieri e affini potrebbe presto uguagliare quella dei fabbricanti di tabacco.
Quello da cui Browne mette in guardia non è tanto un boicottaggio dei petrolieri da parte di gruppi organizzati, ma l'adozione di politiche sempre più severe sulle emissioni di gas serra con il consenso popolare: perfino i repubblicani americani, tradizionalmente portatori degli interessi delle grandi società petrolifere, si sono resi conto che non è più possibile continuare a negare l'evidenza, cioè il riscaldamento globale in corso e la forte responsabilità delle attività umane. Se si raggiungerà un accordo internazionale vincolante per mantenere il riscaldamento globale sotto la soglia dei due gradi, ha calcolato Mark Lewis, analista della società di consulenza finanziaria Kepler Cheuvreux, l'industria delle fonti fossili perderebbe 28.000 miliardi di dollari nei prossimi vent'anni.
Ma non solo: il ministro britannico dell'energia Ed Davey ha aggiunto che sarebbero a rischio i fondi pensione, le banche e in generale tutti gli investimenti nel settore degli idrocarburi. Da tempo si parla di una "bolla dell'anidride carbonica" e il governatore della banca d'Inghilterra, Mark Carney, ha ipotizzato che le riserve di idrocarburi, messe a bilancio dalle società del settore, si possano trasformare in "stranded asset", che cioè perdano buona parte del loro valore sul mercato: una perdita che Mark Lewis ha stimato in 19.000 miliardi di dollari in vent'anni.
Non è un caso che le previsioni delle società di consulenza abbiano avuto un'accoglienza particolare da parte della Banca d'Inghilterra e del governo britannico: secondo gli osservatori il Regno Unito, sede di due fra i più importanti petrolieri al mondo (BP e Shell) è particolarmente sensibile all'argomento. Dal punto di vista aziendale però la prima risposta è venuta dalla Francia. In risposta al consiglio di Lord Browne a soffermarsi "sulle opportunità che si presentano nei settori a basse emissioni", la Total ha ricordato il suo pieno supporto a tre iniziative per la tutela dell'ambiente e del clima: ha ridotto volontariamente la combustione di gas nei propri impianti del 40% rispetto al 2005, come auspicato dalla Banca Mondiale; ha deciso l'introduzione graduale di politiche societarie che comprendano le considerazioni ambientali (senza distorcere i meccanismi della concorrenza), come richiesto dal Global Compact, la piattaforma delle Nazioni Unite per un'economia sostenibile; dal 2005 sottopone a verifiche indipendenti i propri indicatori ambientali, e in particolare le emissioni di metano, e ha deciso di aderire alla Climate and Clean Air Coalition, un'associazione nata per ridurre la concentrazione dei gas serra in atmosfera.
Bisogna vedere ora come reagiranno gli altri petrolieri, inglesi e americani, di "Big Oil": se accetteranno compromessi in favore del clima o se alimenteranno le teorie negazioniste sui cambiamenti globali, con una decisione che potrebbe rivelarsi controproducente innanzitutto per sé stessi.
Paolo Gangemi