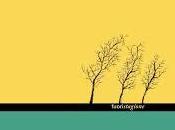Pubblicato da mmagliani su aprile 4, 2012
Recensione di Marino Magliani

La copertina di questo libro è una chiave di lettura; non importa se in realtà è una copertina alla quale manca proprio la chiave. Anzi, è molto importante che la chiave non sia al suo posto. Perché nel romanzo di Fabio Bussotti (Il cameriere di Borges, Perdisa pop, 2012) le cose si vedono così, come dal buco di una serratura. Si vedono di rapina. Non siamo a teatro, malgrado l’autore sia un gran nome del palco. Ma stiamo passando per una strada e una scena all’interno di una casa (minima; un vecchio che si prepara il caffellatte) cattura la nostra attenzione e ci blocca. Allora guardiamo attraverso i vetri, con quel senso di colpevolezza e di complicità. Oppure quella che guardiamo è una scena nient’affatto minima, è piuttosto un pezzo di storia, e noi siamo lì, tanti anni fa, in una foresta andina e umida, assieme a un uomo che ascolta il rantolo di un altro uomo che è diventato un’icona del nostro tempo.
Bussotti, ripeto, oltre che essere narratore capace di incollarci al buco della serratura, è anche uomo di teatro. E qui forse sta la novità di certi libri. Che non ti spingono dentro la scena, perché l’effetto che cercano è proprio quello di lasciarti fuori. La bellezza di guardare un vecchio che si prepara il caffellatte la sera non è quella di entrare nella sua cucina, ma di spiarlo da una finestra. Beckett diceva, mi pare, che in nessun momento lo spettatore dovrebbe perdere la coscienza di essere spettatore. Non so se dica davvero così, ma il gioco del buco della serratura, e questa cosa su cui potrei sbagliarmi di Beckett, mi fanno venire in mente di chiedere alcune cose a Fabio Bussotti.
Intanto dirgli che sono d’accordo, non con lui, ma con chi sostiene che Il cameriere di Borges è potenzialmente un grande film. E poi chiedergli di raccontarci com’è nata l’idea di questo potente intreccio. Premetto che sospetto che l’amore per certe cose argentine provenga da una gentile signora di cui l’autore mi parlò.
Fabio Bussotti: “Mia suocera, che è nata a Buenos Aires, mi parla continuamente dell’Argentina. Glielo chiedo espressamente perché ho bisogno di sentirmi anche io porteño. È un’esigenza fisica, oltre che morale. A Buenos Aires ci sono stato una sola volta, nel ’92, con Vittorio Gassman, durante la tournée di “Ulisse e la Balena Bianca”. Rimasi folgorato dalla vita notturna, dai caffé, dai quartieri, dalle donne, dallo spazi sterminati, dalle grandi avenidas, dalle ragazze… Ci tornerò presto. In quanto all’intreccio, sì, è vero, Il cameriere di Borges nasce come soggetto cinematografico e, dopo essere diventato romanzo, vorrebbe tornare al cinema. Ci sto lavorando alacremente: il mio intento è mettere su una coproduzione italo-argentina.”
Un’altra domanda è sui personaggi, anzi sullo strano personaggio che attraversa periodi storici e oceani. E il commissario Flavio Bertone che sembra contenere la nostalgia del passato e della vita futura, come direbbe Pereira. Quando hai incontrato Flavio Bertone?
Fabio Bussotti: “L’ho incontrato nel 2007. Era un cinquantenne malinconico, un po’ depresso dopo la separazione dalla prima moglie Giuliana e con la fissa per un mediocre trebbiano marchigiano. Il 14 luglio di quell’anno, Bertone finisce in mezzo alla calca dell’ultimo concerto dei Genesis al Circo Massimo. È solo in mezzo a cinquecentomila persone che, come lui, per ore, fanno i conti con la colonna sonora della loro adolescenza. Riaffiorano ricordi, amori, delusioni, immagini sparse, tasselli di un puzzle impossibile da rincollare. Eppure il commissario saltella, balla, canta, ride, piange che manco un adolescente al primo concerto della vita; Bertone si sente all’improvviso un citrullo in mezzo a citrulli come lui. Ma se fosse quella, la chiave della vita? Sentirsi un po’ deficienti forse potrebbe aiutare. Si abbattono gli orgogli, le presunzioni e ci si mette sul cammino dell’umiltà. Così, allegri e stupidi.”