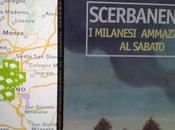Lietta Manganelli
Album fotografico di Giorgio Manganelli. Racconto biografico di Lietta Manganelli
a cura di Ermanno Cavazzoni
Macerata, Quodlibet, 2010, con 109 ill. b/n e col., pp. 104, € 14,00
Giorgio Manganelli
I borborigmi di un’anima. Carteggio Manganelli-Anceschi
a cura e con una postfazione di Lietta Manganelli
Torino, Aragno, 2010, pp. 86, € 12,00
Nel ventennale della morte di Giorgio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922-Roma, 28 maggio 1990) la figlia Lietta, che da anni si occupa con grande passione e diligenza dell’opera paterna (a lei si devono, tra l’altro, le lettere famigliari edite da Aragno nel 2008 sotto il titolo di Circolazione a più cuori), dà fuori, rispettivamente come autrice e curatrice, due contributi preziosi, se non esattamente essenziali, alla conoscenza dell’outsider tra i più estrosi e seducenti del secondo Novecento, il cui forte debito formale verso il Gran Lombardo — tale da procurargli l’ingiusta nomea di principe degli epigoni gaddiani — non vale a scalfirne minimamente la portata.
Il primo, curato da Ermanno Cavazzoni per i tipi della marchigiana Quodlibet, è una fotobiografia commentata all’impronta — con le esitazioni, gli anacoluti, le ripetizioni a distanza ravvicinata, i cambî di progetto tipici del parlato informale — nella quale si ripercorrono con amorosa ironia, non di rado stingente nel più allegro dileggio, i luoghi e le vicende capitali della vita del “Manga”, come egli stesso amava definirsi («sì, sono io, il Manga; lo spregevole, il dappoco, il marginale» scrive in una lettera ad Anceschi). L’infanzia nella Milano degli anni Venti («Mio padre era timidissimo, incavolatissimo, tra l’altro vestito da bambina, secondo me con un trauma psicologico notevole; è vero che allora si usava, ma è anche vero che mio padre era brutto, era brutto già allora […], era abbastanza sgraziato, aveva le braccia più lunghe del normale»); gli insuccessi scolastici («era un cane a scuola fino alle superiori, nel vero senso della parola, è riuscito a farsi bocciare in prima elementare»); la prima prova letteraria, nata quasi per caso («Al liceo, da studente pessimo che era stato, improvvisamente incomincia a leggere come un pazzo, il tutto per effetto, lui dice, di una sua compagna di banco, che probabilmente era qualcosa di più; muore questa sua compagna […] e da lì, in seguito anche a un sogno fatto, comincia a studiare e a scrivere. Il primo racconto si chiama La casa bianca, sembra una delle Centurie, lui la scrive a 18 anni sul giornalino della scuola, ed è la storia di questa casa che si dissolve, lui è un uomo che guarda la casa, sa che lei non tornerà più perché è morta, e la casa pian piano si dissolve, è così che comincia a scrivere»); il matrimonio con Fausta Chiaruttini e la nascita dell’unica figlia, presto abbandonata per cause di forza maggiore e rivista solo undici anni dopo, lo stesso giorno in cui piomba in casa Manganelli un infuriatissimo Gadda («Non ci vedevamo da quando avevo sei anni […], io avevo la proibizione di avvicinarmi a lui, da parte di mia madre che non ne voleva sapere, quindi non è che non l’ho visto perché lui non mi cercava, anzi, ci sono miliardi di lettere tra mio padre e mia madre per la possibilità di vedere la bambina. […] Mio padre e mia madre si sono sposati il 23 marzo 1946, dopo violenti contrasti di mio padre con la sua mammina. Il matrimonio ovviamente è durato quattro mesi, il tempo di mettermi in cantiere. Poi mia madre si è detta: con questo io non ci sto, oltretutto è brutto. […] quando io me lo ritrovo davanti che ho 17 anni, sono assolutamente convinta di aver sbagliato campanello, e sono anche intimiditissima, a Roma alle sette e un quarto di mattina andare a suonare a casa di uno sconosciuto. […] Quindi mi vedo davanti questo signore grasso con le bretelle, pelato, tanto che il nostro incontro è stato anche molto manganelliano perché io gli ho chiesto: “Scusi, lei è il professor Manganelli?” La risposta: “Sì”. “Allora io sono sua figlia”. Ma all’improvviso arriva Gadda per cui mi ha fatto stare sul terrazzo circa un’ora, tirando anche giù le tapparelle. Sentivo degli urli tremendi; poi mi ha detto: “Niente, scusa, era un collega con problemi di nervi”. Gadda l’era andato a cercare e gli aveva fatto una gran piazzata perché diceva che con Hilarotragoedia aveva voluto prendere in giro La cognizione del dolore per via della figura materna comune. Ma che colpa aveva lui se in quell’epoca c’era in giro abbondanza di madri matte? Caro ingegnere, ne abbiamo una a testa, per questo i libri alla fine un po’ si somigliano»); il titubante ingresso nel Gruppo 63 («era una voce totalmente fuori dal coro; c’è un bellissimo ricordo di Luciano Anceschi di questi primi incontri del Gruppo 63 e del Verri: lui si metteva in un angolo, li lasciava parlare e poi con due frasi fulminate [fulminanti?] distruggeva tutto quello che aveva detto fino a quel minuto e buonanotte. Per cui sinceramente non era molto amato, infatti sono pochissimi quelli che poi sono rimasti amici suoi, Gastone Novelli, Barucchello [sic], più che altro i pittori; o i giovanissimi, Nanni Balestrini ecc.»); le zingarate con Augusto Frassineti («facevano gli scherzi più atroci ad esempio ai bigliettai del treno. […] mio padre faceva il nipote portato a casa dallo zio dopo che l’aveva appena tolto dal manicomio, e diceva ad alta voce ad esempio: “zio, quelle case lì, hanno fatto prima le finestre e poi attorno ci han fatto le case?”»); la smodata, poco meno che ossessiva passione per il cibo: «Questa è una bellissima foto mentre esce furtivo dal salumaio, a Dogliani in Piemonte, nell’intervallo di una riunione Einaudi, dove secondo lui si mangiava troppo poco, e doveva andare a farsi un panino, infatti si guarda in giro, “oddio se mi vedono…”, soprattutto temeva ci fosse in giro Einaudi che magari gliene mangiava un pezzo, questa era una cosa che lui non sopportava, Einaudi era l’editore e il padrone, e durante i pranzi allungava la forchetta nei piatti dei suoi autori per assaggiare, era cosa notoria e abituale, mio padre un giorno si è offeso mortalmente, ed è scappato. Alla ripresa della riunione, alle tre, Manganelli era scomparso, “dov’è?”; aveva preso un taxi e si era fatto portare in stazione, e con Einaudi non ha mai avuto più niente a che fare».
Suddiviso in tre sezioni — ventitré lettere di Manganelli ad Anceschi, cinque di questi al primo e due telegrafici stralci da altrettante missive di Anceschi al critico e storico dell’arte Eugenio Battisti su Manganelli, che forse non meritavano tanto onore — I borborigmi di un’anima («ecco a te quel Porco del manganelli; il quale ha solo questo da dire, che ha passato, il Suino, un tempo così nero e vile e sciancato e torbo e stupefatto e fognesco, da sembrargli fatica fuor d’ogni misura metter mano a lettera, disperata arroganza tentar pensieri, soperchiante ambizione dar forma verbata e sintagmatica a quei rutti, quelle loffe, quei borborigmi di un’anima — un’anima! Come paolo sesto — colliquante») documenta, attraverso un dialogo scintillante e fastoso che non conosce calo, il lungo sodalizio umano e culturale nato tra i due negli anni Cinquanta (la prima lettera di Manganelli risale al 15 gennaio 1952) e interrotto solo dalla morte dello scrittore (l’ultima lettera di Anceschi data 4 maggio 1990). Il «Mangagnifico», così lo battezza il fondatore del «verri» in una missiva a Battisti del ’56, parla di sé come di un personaggio, e ciò gli consente non solo d’attingere i vertici d’un feroce autosarcasmo, e dunque della più rapinosa comicità, ma soprattutto di squadernare in tutta la gamma delle possibili sfumature il proprio repertorio linguistico, con un ritmo e una forza inventiva tali da ridurre lo sbalestrato corrispondente (l’Ancescule, l’Ancescone, lo Sferoide, il Magister) a un pallidissimo emulo.