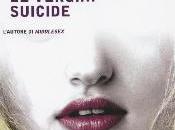![Il senso di una fine, frasi [Julian Barnes] Il senso di una fine, frasi [Julian Barnes]](http://m2.paperblog.com/i/225/2258720/il-senso-di-una-fine-frasi-julian-barnes-L-1WG6Xg.jpeg)
Viviamo nel tempo; il tempo ci forgia e ci contiene, eppure non ho mai avuto la sensazione di capirlo fino in fondo. Non mi riferisco alle varie teorie su curvature e accelerazioni né all'eventuale esistenza di dimensioni parallele in un altrove qualsiasi. No, sto parlando del tempo comune, quotidiano, quello che orologi e cronometri ci assicurano scorra regolarmente: tic tac, tic tac. Esiste al mondo una cosa più ragionevole di una lancetta dei secondi? Ma a insegnarci la malleabilità del tempo basta un piccolissimo dolore, il minimo piacere. Certe emozioni lo accelerano, altre lo rallentano; ogni tanto sembra sparire fino a che in effetti sparisce sul serio e non si presenta mai più.
Al tempo, era tutto più facile: c'erano meno soldi, nessun gadget elettronico, una scarsa tirannia della moda, nessuna ragazza. Niente che ci distraesse dai nostri doveri umani e filiali, vale a dire studiare, superare gli esami, sfruttare il titolo di studio per trovarci un lavoro e infine mettere insieme una vita migliore di quella dei nostri ma senza provocazioni.
In quei giorni immaginavamo noi stessi come prigionieri dentro un recinto, in attesa di essere liberati nel pascolo delle nostre esistenze. Quando fosse giunto il momento, la vita, e il tempo stesso, avrebbero subito un'accelerazione. Come avremmo potuto sapere che in effetti le nostre vite erano già cominciate, che alcuni vantaggi ce li eravamo accaparrati e che qualche danno era già stato inflitto? E che, per di più, ci avrebbero solo liberati dentro un recinto più grande i cui limiti avremmo in principio faticato a riconoscere?
I nostri erano convinti che potessimo lasciarci traviare dagli altri fino a trasformarci in ciò che temevano di più: un masturbatore incorreggibile, un fascinoso omosessuale, uno spericolato ingravidatore senza scrupoli. Temevano per quanto ci riguardava la vicinanza di amici adolescenti, l'ingerenza predatoria di sconosciuti sul treno, l'adescamento della ragazza sbagliata. Che sproporzione, fra le loro ansie e le nostre esperienze.
Il mondo esiste in condizioni di caos perenne e [...] soltanto un primordiale istinto narrativo, a sua volta palese strascico delle religioni, impone retrospettivamente un senso a ciò che è o non è accaduto. Insegnanti e genitori tendevano a ricordarci fastidiosamente di essere stati giovani a loro volta, e di poter quindi parlare a ragion veduta. È solo una fase, ripetevano. La supererai, sarà la vita a darti lezione di realtà e realismo. Al tempo tuttavia ci rifiutavamo di accettare che potessero mai essere stati minimamente simili a noi, e sapevamo di cogliere l'essenza della vita - come della verità, dell'etica e dell'arte - con chiarezza di gran lunga superiore a quella dei nostri vecchi ormai compromessi.Ecco un'altra delle nostre paure: che la Vita potesse rivelarsi diversa dalla Letteratura. Prendi i nostri genitori, erano forse materiale letterario? Tutt'al più, potevano ambire al ruolo di astanti, di spettatori, far parte di un fondale umano contro il quale avvenivano le cose reali, quelle che contano veramente. Tipo? Beh, tutte le cose di cui si occupa la Letteratura: amore, sesso, morale, amicizia, felicità, sofferenza, tradimento, adulterio, bene e male, eroi e cattivi, colpevoli e innocenti, ambizioni, potere, giustizia, rivoluzione, guerra, padri e figli, madri e figlie, l'individuo in rapporto al sociale, il successo e il fallimento, l'omicidio, il suicidio, la morte, Dio.
Che cos'è la Storia? Qualche idea, Webster?
- La storia è fatta delle menzogne dei vincitori, - risposi un po' troppo fulmineo.
- Sì, temevo che avrebbe detto così. Non dimentichi comunque che è fatta anche delle illusioni dei vinti. Simpson?
Colin era più preparato di me. - La storia è come un panino con la cipolla cruda, signore.
- In che senso?
- Perché non fa che ripetersi, signore. Torna su. L'abbiamo constatato mille volte quest'anno. Sempre la solita solfa, lo stesso pendolo tra tirannia e ribellione, guerra e pace, prosperità e depauperamento.
Sarà meglio che spieghi il significato dell'espressione "uscire insieme" di allora, perché poi il tempo l'ha modificato. [...] Ai "miei tempi" - benché non abbia mai vantato diritti d'autore sull'epoca, e meno che mai mi sogni di farlo ora - di solito succedeva così: conoscevi una ragazza, lei ti piaceva, cercavi di ingraziartene i favori, la invitavi in un paio di luoghi di incontro - che so io, un pub -, poi le chiedevi di trovarvi da soli, poi glielo chiedevi di nuovo e, dopo un bacio della buonanotte di intensità passionale variabile, potevi ufficialmente dichiarare che "uscivi" con lei. Era solo dopo aver preso un impegno pressoché pubblico che ti era dato di scoprire la sua posizione in materia di comportamento sessuale. Il che qualche volta significava avere a che fare con un corpo protetto come una riserva di pesca esclusiva.
Veronica non era molto diversa dalle altre ragazze di allora. Si mostravano fisicamente disinvolte, ti prendevano sottobraccio in pubblico, ti baciavano da toglierti il fiato, potevano addirittura premerti volutamente addosso il seno, a patto che restassero almeno cinque strati di stoffa tra pelle e pelle. Erano perfettamente consapevoli di quanto accadeva frattanto nei tuoi pantaloni, pur non parlandone mai. E questo era tutto, per un bel po' di tempo. Certe ti concedevano qualcosa di più: si sentiva di alcune disposte alla masturbazione reciproca e di altre che ti lasciavano fare "sesso completo", come si diceva allora. Non si era in grado di apprezzare l'importanza di quell'aggettivo "completo", se non si aveva avuto parecchia esperienza del suo contrario, vale a dire dell'incompleto. Infine, con il progredire del rapporto, si verificava una serie di implicite contrattazioni, alcune fondate sul capriccio, altre su impegni e promesse, fino a ciò che il poeta ha chiamato "la lotta per un anello".
"Perché no?", domandavo, mentre una mano severa mi bloccava il polso.
"Perché non me la sento".
Ecco uno scambio di battute udito svariate volte dinanzi a un'ansante stufetta a gas, contrappuntata dal fischio di un bollitore. E quando c'era di mezzo il "sentirsela" la discussione era chiusa, perché erano le ragazze, le esperte in materia, i maschi non erano che grezzi neofiti. Perciò quel "non me la sento" esercitava una forza persuasiva di gran lunga superiore e irrefutabile di ogni eventuale ricorso a dottrine religiose o consigli materni. Mi direte, ma non erano gli anni Sessanta? Sì, ma solo per qualcuno, e solo in determinate zone del paese.
L'unica vera utilità delle mestruazioni è quella di farti sapere che non sei incinta.
Devo tuttavia sottolineare ancora una volta come questa sia la mia lettura attuale dei fatti. O meglio, l'attuale ricordo della mia lettura di allora di quanto al tempo accadeva.
Un inglese una volta ha detto che il matrimonio è un pranzo interminabile con il dolce servito per primo. Ti ritrovi a ripetere "Crescono così in fretta, eh?" quando quello che intendi in realtà è: oggi il tempo per me scorre più veloce.Una vita come un'altra, no? Qualche successo, qualche delusione. Personalmente, mi è sembrata interessante, anche se non troverei né disdicevole né sorprendente se qualcuno non la pensasse così. In un certo senso, forse Adrian sapeva quel che faceva. In ogni caso io non mi sarei perso la mia vita per tutto l'oro del mondo, mi spiego?
Sono sopravvissuto. Come si dice, "vivere per raccontarla", giusto? Non è affatto vero che la storia è fatta delle menzogne dei vincitori, come sostenni una volta disinvoltamente, con il vecchio Joe Hunt; adesso lo so. È fatta più dei ricordi dei sopravvissuti, la maggior parte dei quali non appartiene né alla schiera dei vincitori né a quella dei vinti.
La vita non promuove per merito.
La storia che ci succede sotto il naso dovrebbe essere per noi la più chiara, e invece risulta la più deliquescente. Quando si è giovani, chiunque superi i trent'anni ci sembra di mezza età, chiunque superi i cinquanta, decrepito. E il passare del tempo ci conferma che non sbagliavamo di molto. Le piccole differenze d'età, così significative e palesi da giovani, perdono rilevanza. Si finisce con l'appartenere alla stessa grande famiglia, quella dei non-più-giovani. Meno tempo vi resta da vivere, e meno avete voglia di sprecarlo. All'improvviso mi sembra che una delle differenze tra la gioventù e la vecchiaia potrebbe essere questa: da giovani, ci inventiamo un futuro diverso per noi stessi; da vecchi, un passato diverso per gli altri.Perché mai l'età dovrebbe addolcirci? Se è vero che la vita non è obbligata a promuovere il merito, perché dovrebbe preoccuparsi di fornirci calore e conforto verso la fine? A quale scopo evoluzionistico può mai servire la nostalgia?
Ricordo un periodo verso la fine dell'adolescenza in cui mi ubriacavo mentalmente di prospettive avventurose. Ecco come sarò da adulto. Andrò in quel paese, farò questo, scoprirò quello, mi innamorerò di lei, e poi di lei, di lei e di lei. Vivrò come da sempre vive la gente nei romanzi. Quali romanzi, non mi era chiaro, ma sapevo per certo che passione e pericolo, estasi e disperazione (ma sempre seguita da altra estasi, intendiamoci) non sarebbero mancati. Comunque... chi è che ha parlato della "piccolezza delle passioni che l'arte ingigantisce"? Ci fu un momento quando ero ormai prossimo ai trenta, in cui dovetti riconoscere lo spegnersi definitivo di ogni ipotesi avventurosa. Non avrei mai attuato le imprese sognate da ragazzo. In compenso, tosavo il prato di casa, andavo in vacanza, facevo la mia vita. Con quale frequenza raccontiamo la storia della nostra vita? Aggiustandola, migliorandola, applicandovi tagli strategici? E più avanti si va negli anni, meno corriamo il rischio che qualcuno intorno a noi ci possa contestare quella versione dei fatti, ricordandoci che la nostra vita non è la nostra vita, ma solo la storia che ne abbiamo raccontato. Agli altri, ma soprattutto a noi stessi.Il tempo però... ah, come può trascinarci alla deriva e confonderci le idee. Credevamo di aver raggiunto la maturità quando ci eravamo soltanto messi in salvo, al sicuro. Fantasticavamo sul nostro senso di responsabilità, non riconoscendolo per quello che era, e cioè vigliaccheria. Ciò che abbiamo chiamato realismo si è rivelato un modo per evitare le cose, ben più che affrontarle. Già, il tempo ci riserva... il tempo necessario a farci percepire le nostre più salde risoluzioni come traballanti, le nostre certezze come capricci momentanei.
Il carattere delle persone si sviluppa nel tempo? Nei romanzi, naturalmente, sì: altrimenti non ci sarebbe storia. Ma nella vita? A volte me lo chiedo. Cambiano i nostri atteggiamenti, le nostre opinioni, assumiamo nuove abitudini e nuove bizzarrie; ma è un'altra cosa, un fatto più decorativo. Forse il carattere è simile all'intelligenza, anche se raggiunge il suo picco massimo leggermente più tardi, diciamo, tra i vent'anni e i trenta. Dopodiché, non ci schiodiamo più da lì. Siamo soli. Se così fosse, si spiegherebbero parecchie esistenze, non vi pare? Nonché, se il termine non risulta troppo solenne, la nostra tragedia.
Qualcuno una volta ha detto che i suoi periodi storici preferiti erano quelli in cui tutto precipita, perché significano la nascita imminente di qualcosa di nuovo. H a senso questa teoria se la applichiamo alle vite dei singoli individui? Morire quando sta per nascere qualcosa di nuovo, anche se la novità in questione riguarda proprio noi? Perché, esattamente come ogni cambiamento storico o politico prima o poi delude, così succede con il diventare adulti. Con la vita. Certe volte penso che lo scopo dell'esistenza sia quello di riconciliarci, per sfinimento, con la sua perdita finale, dimostrandoci che, indipendentemente dal tempo che ci vorrà, la vita non è affatto all'altezza della propria fama.
Quando si è giovani - parlo per me almeno - si vogliono provare sentimenti simili a quelli di cui leggiamo nei libri. Passioni che ti sconvolgono la vita, che creano e definiscono una realtà nuova. Più tardi, mi pare, vogliamo dai sentimenti qualcosa di più pratico e modesto: che siano di sostegno alla nostra vita per come è diventata e si manifesta. Vogliamo che ci garantiscano che va tutto bene. E che c'è di male in questo?
Non c'è idiota peggiore di un idiota vecchio.
Che ne sapevo io della vita, io che ero sempre vissuto con tanta cautela? Che non avevo mai vinto né perso, ma avevo lasciato che la vita mi succedesse? Io che avevo avuto le ambizioni di tanti, ma che mi ero ben presto rassegnato a non vederle realizzate? Che avevo evitato il dolore e l'avevo chiamato attitudine alla sopravvivenza? Che avevo pagato conti e bollette, che ero rimasto in buoni rapporti con tutti il più a lungo possibile; io, per cui estasi e disperazione erano diventati da molto tempo giusto parole lette una volta nei libri? Uno i cui rimproveri a se stesso non lasciavano mai il segno?
Si arriva alla fine della vita, no, non della vita in sé, ma di qualcos'altro: alla fine di ogni probabilità che qualcosa in quella vita cambi. Ci viene concesso un lungo momento di pausa, quanto basta a rivolgerci la domanda: che altro ho sbagliato?