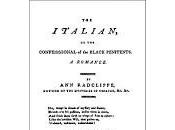Pubblico qui l’introduzione alla mia monografia di James Harpur, (Introduzione e antologia di traduzioni) pubblicata sul N°304 di Poesia Crocetti Editore, Maggio 2015.
F.D.
In un primo momento abbaglia, poi stordisce, poi oscura, poi consola. Infine illumina, seppur di una flebile luce, la tenebra in cui ti ha fatto penetrare. È quanto si prova nel leggere la parola di James Harpur e il suo inglese corrusco.
Un lungo percorso di ricerca escatologica, tanto personale quanto collettiva, il suo, che emerge chiarissimo dalle sue stesse parole. “Sono giunto alla poesia solo negli anni dell’università. D’un tratto mi sono trovato ad obbedire a un impulso sotterraneo e decisi che la poesia era un’impresa nobile e un mezzo per esplorare le fondamentali questioni spirituali, quali l’esistenza di un Dio, se la vita abbia un senso, cosa c’è dopo la morte, ecc. questioni che nella mia vita sono sempre state una forza centrale e propulsiva. Forse tutti quegli uomini di chiesa nel mio DNA… La poesia mi apparve una missione, il mezzo che mi avrebbe permesso di penetrare l’escatologia della vita o, almeno, di venire a patti con i miei rapporti personali, con i grandi temi dell’esistenza. Da questo punto di vista, per me scrivere era ed è tuttora un’attività sacra, quasi quanto la meditazione e la preghiera.” [1]
Non sono molti, oggi, i poeti che vedono nella poesia un’attività che li collega al divino, così com’era alle sue origini. Ma Harpur è un poeta delle origini. Un Urdichter, si potrebbe dire, poiché la sua poesia attinge proprio a quel magma originario da cui la Parola emerge come lògos, come portatrice di tutti i significati possibili e, allo stesso tempo, come potenza ordinatrice dell’universo. Che separa, distingue, nomina e ordina.
Che questa sia la funzione che Harpur le attribuisce è forse sommamente evidente nel lungo poemetto Voices of the Book of Kells, (Voci del Libro di Kells) esplorazione della genesi di questo prodigioso Evangeliario miniato, dell’animo degli anonimi monaci irlandesi che lo miniarono e, allo stesso tempo, della genesi dell’arte. In quella sfera misteriosa della creazione, che è anche lotta costante fra la materia e lo spirito.
Nato in Inghilterra nel 1956, da padre irlandese e madre inglese, di antiche ascendenze anglonormanne, Harpur tiene a spiegare che il significato originario del suo cognome, documentato già nel XII secolo, è arpista, dunque poeta. Lo fu sicuramente un suo antenato. Ma discende anche da una tradizione familiare di uomini di chiesa, Church of Ireland, come lo fu suo nonno e altri prima di lui. Tuttavia Harpur ha scelto un’altra strada. In lui si sono fuse l’anima dell’arpista medievale e quella del mistico. Perché Harpur è un cantore del Sacro. Nel senso più ampio del termine.
La sua prima raccolta organica, A Vision of Comets, (Anvil Press) è del 1993 e raccoglie buona parte dei testi poetici scritti durante il suo soggiorno a Creta, dove ha vissuto per un anno insegnando inglese. L’isola egea gli fa esplodere dentro una potenza poetica e visionaria che diventerà negli anni la sua voce originale, e la poesia che dà titolo alla raccolta ne è riconoscimento e accoglimento.
Le raccolte successive, The Monk’s Dream, 1996 Oracle Bones, 2001 The Dark Age, 2007, Angels and Harvesters, 2012, tutte edite da Anvil Press, insieme a The Gospel of Joseph of Arimathea, (Iona Books) 2007 e Voices of the Book of Kells, 2012, confermano la natura esplorativa di questa ricerca, attraverso i due elementi che raccolgono e alimentano la poesia di Harpur: la luce e la tenebra, che non solo non le è opposta, ma le è complemento speculare ed essenziale.
Uno degli aspetti più profondi e significativi della mentalità celtica è la fascinazione per tutto ciò che è passaggio, trasformazione, per il liminale, per quello spazio e quel tempo che si insinuano fra il momento in cui tutto finisce e quello in cui tutto inizia di nuovo, secondo un tempo ciclico, per quello iato abissale che si apre sul mistero che irrompe fra il “non più” e il “non ancora”. Il non casuale twilight di Yeats. Questo spazio incommensurabile, temibile nel quale si inoltra il pensiero del mistico e dell’artista.
È questo spazio che Harpur esplora. Perché per lui il faticoso e misterioso processo creativo è simile a quello della ricerca spirituale. Lo afferma più volte lui stesso. Un’avventurosa, travagliata esplorazione come uomo e come artista, non immune dal dolore, che tanto somiglia al fortunoso viaggio di Brendano, cui del resto Harpur dedica in The Dark Age un testo qui presentato.
Come dice Adam Zagajevski, “nella poesia si mette ciò che non si sa”. Ma il non sapere richiede che solidi siano i supporti da cui muovere. Per non perdersi nelle fauci del nulla. Il percorso che Harpur si è scelto quindi, chiede strumenti adatti. La sua formazione classica (conosce perfettamente il greco e il latino e gli autori della classicità, di cui ha fatto alcune traduzioni) lo spinge ad esplorare le possibilità che la metrica antica, greca soprattutto, offre alla sua lingua. Trimetro giambico, pentametro, distico elegiaco suonano nel suo inglese con lo stesso elegante equilibrio classico dei testi redatti dagli antichi monaci e santi irlandesi che preservarono la cultura antica e la mantennero viva nelle abbazie, nei cenobi e nei monasteri da loro fondati. Ma l’attingere al patrimonio metrico degli antichi non è solo un espediente tecnico, è l’attingere direttamente alla fonte poetica di quella cultura, da cui non si sente affatto separato o lontano.
Tipicamente irlandese è questa fusione armonica – quasi un fluire dell’una nell’altro – fra l’antica cultura celtica, rutilante di meandri, miti visionari, eroi luminosi anche se sconfitti, percorsi circolari e un cristianesimo coltissimo, esplorativo, costellato di santi anacoreti, misticismo, bizzarria e magia. Una spiritualità in fondo non poi così diversa, nelle sue componenti, da quanto l’ha preceduta in quell’isola.
Ed è infatti questo momento aurorale del cristianesimo, irlandese, ma anche greco e siriaco, che affascina Harpur. Non meno del lento estinguersi dell’antica tradizione classica nei suoi epigoni. Si veda la sua traduzione di Boezio dal titolo The Fortune’s Prisoner, oppure L’augure a riposo, in Ossa oracolari; non meno del patrimonio mitologico celtico, che è costantemente presente in sottofondo.
Nell’interazione fra questi due momenti nella storia dell’Occidente, fra il paganesimo e il cristianesimo, fra l’antico e la modernità, Harpur non legge solo il passaggio fra due epoche, fra due culture, ma un aspetto ben più profondo e inquietante; la lotta, appunto, fra natura e spirito. Come è nel mito di fondazione della conversione irlandese al cristianesimo da parte di San Patrizio, in cui i serpenti che egli scaccia dall’Irlanda, non sono altro che i pericolosi “rettili della mente” di Blake, niente affatto sconfitti.
“Il mio rapporto con la religione, col Cristianesimo e la chiesa è complesso. Mi considero un agnostico rinato, o un ricercatore spirituale. Sono attratto dai mistici di ogni religione e cultura, da Meister Eckhart a Rumi, a Kabir e dal più profondo e radicale maestro spirituale dei tempi moderni che io abbia mai incontrato, J. Krishnamurti. Nutro profonda diffidenza nei riguardi delle strutture religiose istituzionali e delle gerarchie e mi piace il commento di Blake, che, per il culto religioso, un pub sarebbe un luogo migliore di una chiesa”, afferma ancora Harpur nell’intervista già citata.
Fra quelle che Harpur definisce “questioni che nella mia vita sono state forza centrale e propulsiva”, non di secondaria importanza è il problema del fato, il chiedersi se un destino segnato esista, se lo si possa cambiare. È sicuramente centrale in The Monk’s Dream, raccolta pubblicata nel 1996, successivamente alla morte del padre. La poesia che dà il titolo alla raccolta si riferisce alle sospette circostanze della morte del poco amato re Guglielmo II (1056- 1100) in un incidente di caccia. Pare che un anonimo monaco avesse sognato la fine del re e l’avesse fatto avvertire, ma questo non cambiò il fato che lo attendeva. La sezione centrale di questa raccolta è dedicata interamente alla malattia, alla morte e ai funerali del padre di Harpur ed è una lunga meditatio mortis, ma anche una profonda riflessione sul destino finale di ogni vita. E ancora ritorna, come questione aperta, in Ossa oracolari, dove l’eroe nazionale Cuchulainn, protagonista del ciclo mitologico dell’Ulster, sfida il proprio destino già segnato, ignorando volutamente i segni premonitori e i tabù che non potrebbe infrangere, andando consapevolmente verso la morte. Morendo da eroe e da uomo libero.
Fondamentale è stata per lui, in età giovanile, la lettura di Jung e la scoperta della sua teoria dell’inconscio collettivo, che gli dischiudono una nuova visione del mito, quale narrazione fondante della psiche. Così Harpur legge, nelle vite dei santi, talvolta bizzarre e sorprendenti, una ricchezza di miti e leggende non meno articolati e variegati di quelli del mondo pagano e classico, tale da tracciare una mappa della psiche umana.
In questa inesausta ricerca della luce del Sacro attraverso la tenebra della psiche, individuale e collettiva, e della storia dell’uomo, Harpur conversa con i santi e i mistici e gli asceti pagani e cristiani, talvolta anonimi o immaginari, spesso realmente esistiti, ai quali non di rado dà voce. Con Jakob Böhme, con Giuliano di Norwich, con Richard Rolle, con Marguerite Porete. E, soprattutto, in un poemetto di circa 400 versi, con San Simeone lo Stilita, l’anacoreta la cui vita è una parabola della via negationis che, non potendo fuggire dal mondo in orizzontale, lo fuggì in verticale, dimorando per trentasette anni su di una colonna alta quindici metri. Negando se stesso, la propria natura, la propria umanità, il mondo, alla ricerca dell’Assoluto. Ma solo per accorgersi poi, che il mondo accorreva a frotte verso di lui, talché sotto la sua colonna, come dice Harpur, si radunava una sorta di permanente Woodstock!
San Simeone, come lo scrittore, come il poeta, ha sete d’isolamento, di solitudine, ma come l’artista creatore, comprende poi di non poter trascendere, di non poter negare il mondo, così come lo comprese Faust.
Sostenute da un virtuosismo linguistico prodigioso, da una perizia tecnica degna di un antico bardo irlandese, tensione, ascensione, sete e cerca sono i punti nevralgici della sua poesia – poesia mistica, religiosa si potrebbe dire, consapevoli che per Harpur un mistico è anche l’artista – che forse ha solo in Gerard Manley Hopkins, seppur in modo e con origine del tutto diversi, un predecessore in lingua inglese. Forse soprattutto nella ricerca di un metro nuovo, di una lingua nuova, capaci di esprimere l’ineffabile, l’invisibile, l’ascesi, ma che nascono dalla consuetudine con l’antico, ponendosi Harpur volutamente al di fuori delle correnti contemporanee postmoderne, e tantomeno limitandosi a un chiuso mondo, in cui l’io rimane prigioniero delle cose cui arriva la sua vista fisica. No, il mondo di Harpur è fatto più di visioni, di rivelazioni che dalle cose emanano – della capacità di vedere il miracolo, il mistero, irrompere nel quotidiano, come nel testo Angeli e mietitori che dà il nome all’ultima raccolta – e non ha confini né di tempo né di luogo. Ė terra incognita, l’oceano sconosciuto su cui si avventuravano Brendano e i suoi monaci alla ricerca dell’Isola dei Beati, incontrando nel corso del viaggio mostri minacciosi e dèmoni. È la sua stessa anima di poeta e di uomo.
L’uso di immagini sorprendenti e inattese, il concatenarsi delle metafore, la fluidificazione del mito, che scorre potente verso di noi con l’ardore bruciante della fiamma ma con veste rinnovata, e della sua potenza visionaria, la profonda conoscenza del patrimonio culturale dell’Irlanda celtica, della cultura classica, della tradizione cristiana, l’uso sottilissimo del linguaggio, fanno di Harpur il più irlandese dei poeti irlandesi. Perché è su queste basi culturali che si è formata l’Irlanda moderna.
Tutta la sua produzione poetica è un unico, ininterrotto dialogo, che fluisce lungo quel costone semi-illuminato che è il passaggio dal mondo antico e pagano alla modernità, e dalla modernità alla contemporaneità.
È una poesia fortemente impregnata di spiritualità dunque, molto nella grande tradizione poetica bardica irlandese, ma una spiritualità che ha una profondissima connessione con la modernità.
Il travaglio del passaggio da un’epoca a un’altra infatti è l’eco del nostro, le domande che torturano i suoi asceti, cristiani e pagani, i dubbi che attanagliano i suoi uomini, i suoi peccatori, i suoi indovini, i suoi monaci, sospesi tra un mondo e un altro, sono i nostri, la fine drammatica di un’epoca che si avvia incerta verso l’ignoto è la nostra.
Francesca Diano
[1] Intervista su Poetry Ireland Review, N° 105 Inverno, 2011/12
(C)2015 by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA