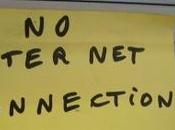Certe albe verde-azzurre, certe nottate di stelle estive passate in coperta un po’ dormendo e un po’ piangendo, certi cigolii di gomene sfilacciate, cullanti o stridenti a seconda della marea, gli odori dell’acqua stagnante e del ferro riscaldato dal sole, di vecchio combustibile e di alghe fresche al mattino. Le bitte di pietra, i gabbiani di cristallo.
Certe albe verde-azzurre, certe nottate di stelle estive passate in coperta un po’ dormendo e un po’ piangendo, certi cigolii di gomene sfilacciate, cullanti o stridenti a seconda della marea, gli odori dell’acqua stagnante e del ferro riscaldato dal sole, di vecchio combustibile e di alghe fresche al mattino. Le bitte di pietra, i gabbiani di cristallo.
Le case stinte con imposte da bambole, i tetti violacei dimore di cicogne; il fumo dei focolari in inverno, qualche spruzzo di neve, le ventate che scendono impetuose dalle montagne lontane e ruggendo si allargano verso il mare aperto lasciando turbini di foglie e polvere e stracci e un cielo più vasto e abbacinante. Le lunghe sere di primavera, un muggito lontano dalle stalle, il canto semplice e contadino dei secchi di zinco. Il timbro antico di zoccoli di legno sui selciati sconnessi, le campane della domenica e dei morti, i bambini con lenze improvvisate che imparano a pescare dal molo, a piedi scalzi.
Un paese mai veduto eppure imparato a memoria.
Quando morì il vecchio Elijah, ne ereditai il mestiere e tutti gli arnesi. Mi sistemai un piccolo laboratorio in una cabina con luce e misi in piedi l’unica attività possibile: l’aggiustatutto. Mi facevo mandare su nel cesto o con corde robuste sedie spagliate, madie traballanti, mastelli sfondati, ma anche casseruole da stagnare, orologi incagliati o giocattoli di legno da riparare. Tutti lo impararono presto: se c’è qualcosa di rotto, portatelo a Viktor, sa fare un po’ di tutto e ha tanto tempo. Mi sono mantenuto così in questi anni, in una scambievole assistenza. Dalla mia prigionia a cielo aperto, ho sopperito con le mie alle mani degli uomini – mariti, padri – lontani in guerra.
“Maxim, cosa mi dici della guerra?
“Eh, la guerra. Va e viene”.
La guerra non si vide mai, ma si sapeva che c’era anche quando pareva tacere. Si spegneva qua per riaccendersi a tradimento un po’ più in là, e non si capiva mai chi stesse vincendo.
“Maxim, ma chi è che vince?”
“Non si sa. Devono ancora deciderlo”.
I bambini continuavano ad andare a scuola e a venire sotto la murata a fare i compiti.
A volte sotto la murata venivano anche gruppetti di ragazze, la domenica pomeriggio. Passeggiavano chiacchierando nell’unico giorno di festa, con i loro vestiti rilucidati e rammendati, le gonne coi ricami tradizionali che nascondevano le calze grosse, sui capelli larghi scialli a fiorami con frange di seta. Mi facevano sorrisi e cenni di saluto, ma erano vergognose perché ero un uomo e passavano oltre senza fermarsi. Forse però, allontanandosi ridacchiando a braccetto, fra loro parlavano di me.
Olga no, perché era sordomuta, e con lei usavano il linguaggio dei segni. E io, di Olga mi innamorai. Di quegli amori necessari ma solo sognati, un’invenzione della solitudine e dell’incertezza. Era un volto da riconoscere e cui pensare come fosse cosa mia pur sapendo che non lo era, come i giocattoli costosi nelle vetrine a Natale. Era una buonanotte dolce e malinconica quando scendeva il buio e mi rintanavo come un topo nell’unico letto che mi era concesso.
Più avanti si sposò, con un ragazzo sordomuto come lei, l’unico rimasto in paese perché scartato dall’esercito per la sua menomazione. Ed ebbero anche dei bimbi, che salutavo dal parapetto quando li conducevano a fare i primi passi lungo il molo. Non ero geloso di quella loro felicità, al contrario provavo una gioia dolente e matura nella mia rinuncia, e mi sentivo quasi un saggio custode di quelle giovani vite.
(continua)
l’immagine, come le altre che illustrano questo racconto, proviene da QUI