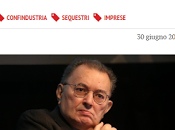Il caso Ilva non è solo paradigmatico del conflitto fra la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dei posti di lavoro degli operai. Esso costituisce un’ulteriore testimonianza del perverso rapporto di dipendenza che rende funzionale la devastazione ambientale del Mezzogiorno alla crescita dell’industria settentrionale e delle aree centrali dello sviluppo capitalistico.
di Guglielmo Forges Davanzati da MicroMega online
La vicenda ILVA mette in luce i più evidenti limiti della gestione della politica economica italiana: l’incapacità di programmare interventi di lungo termine, essendo il problema della non sostenibilità ambientale degli stabilimenti tarantini ben noto da tempo; la pressoché totale incapacità di far fronte al conflitto di obiettivi fra la salvaguardia di posti di lavoro e la tutela della salute e dell’ambiente; l’incapacità di far fronte all’emergenza senza generare conflitti istituzionali. E soprattutto si tratta di una vicenda che ben evidenzia il fatto che, da almeno due decenni, la politica economica in Italia – intenzionalmente o meno – favorisce l’accentuarsi degli squilibri regionali.
Il rischio di chiusura dell’ILVA è, ad oggi, assai probabile a seguito della recente pronuncia del GIP di Taranto, Patrizia Todisco, secondo la quale la produzione delle acciaierie tarantine va immediatamente fermata, perché causa dell’emergenza sanitaria e ambientale che investe la città di Taranto e un’ampia area circostante.
Una indagine dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, resa pubblica lo scorso anno, ha evidenziato, nell’area considerata, un eccesso di mortalità tra il 10 e il 15%, un eccesso di circa il 30% per tumore del polmone, un eccesso tra il 50% (uomini) e il 40% (donne) di decessi per malattie respiratorie acute, un aumento del 10% nella mortalità per tutte le malattie dell’apparato respiratorio, un eccesso del 15% tra gli uomini e 40% nelle donne della mortalità per malattie dell’apparato digerente e un incremento di circa il 5% dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini. Peraltro, che lo stabilimento siderurgico di Taranto fosse uno dei più inquinanti d’Europa lo si sapeva da quasi venti anni. Da quando, cioè, la società del gruppo Riva, con la privatizzazione dell’azienda avvenuta nel 1995, rilevò gli impianti dell’Italsider, con l’obbligo di metterli in sicurezza e di eliminare gli scarichi inquinanti nel Mar Piccolo. Il problema era dunque ampiamente noto e autorevolmente certificato, ma, pure a fronte dell’inaudita gravità del fenomeno, poco o nulla si è fatto, e poco o nulla si è detto e scritto sui principali media nazionali.
E’ bene chiarire, a riguardo, che, in linea generale e in assenza di interventi esterni, un’economia capitalistica di mercato soggiace sempre alla fondamentale contraddizione fra la sua riproduzione (che presuppone la continua crescita della produzione di merci) e la tutela della salute e dell’ambiente (che, per contro, presuppone una costante attenzione ai vincoli posti dalla disponibilità di risorse naturali e dal rispetto della salute). Ma è opportuno anche chiarire che questa contraddizione – che, appunto, ha valenza generale – assume connotati ben più rilevanti in Italia – e ancor più nel Mezzogiorno – rispetto alla gran parte dei Paesi industrializzati. L’Ufficio studi della CGIL rileva che, fra i Paesi europei, l’Italia è quello con minore propensione all’investimento in tecnologie ecosostenibili: posta pari a cento la quota delle esportazioni italiane di fonti di energia rinnovabili nel commercio internazionale alla fine degli anni novanta, oggi l’Italia ha perso quasi 30 punti percentuali (a fronte della sostanziale tenuta dell’UE a 15), mentre ha visto crescere la propria quota di importazioni. Il disinvestimento in ricerca e sviluppo da parte dello Stato, e la rinuncia a porre in essere politiche industriali, nonché la prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni nel settore privato (con la conseguente difficoltà di accedere a finanziamenti per le innovazioni) spiegano in larga misura questo fenomeno.
Non vi è dubbio che l’ipotesi di chiusura degli stabilimenti ILVA di Taranto è inquietante, sia perché sancirebbe la definitiva desertificazione produttiva del Mezzogiorno, sia soprattutto per l’enorme aumento del tasso di disoccupazione che ne deriverebbe, con prevedibile esplosione del conflitto sociale. Sono queste le preoccupazioni del Governo Monti e dei Ministri andati a Taranto per provare a risolvere politicamente la crisi aziendale. Il problema viene declinato come inerente al doppio ‘ricatto’ occupazionale e ambientale, mettendo in evidenza la tesi (ovvia) stando alla quale la riconversione dell’attività produttiva in attività ecosostenibile metterebbe fine al caso. E’ una tesi ovvia solo a condizione di assumere (il che non è stato, e non è) che sia nell’interesse di un’impresa privata assumere i costi della riconversione produttiva. Si tace sul fatto palese che un’impresa privata non ha alcun interesse a risolvere problemi di esternalità negative e che, come evidenziato nella gran parte della letteratura economica, la soluzione di questi problemi rinvia a interventi dello Stato, anche sotto forma di nazionalizzazione. Si tace anche su un aspetto sul quale occorrerebbe riflettere per mettere meglio in evidenza i termini del problema, ovvero: quanto l’ILVA contribuisce allo sviluppo economico dell’area sulla quale insiste?
Si consideri che a Taranto viene prodotto oltre il 45% dell’intera produzione di acciaio italiana e che, nell’eventualità di chiusura degli stabilimenti tarantini, dovrebbero chiudere anche le acciaierie di Novi Ligure e Genova, che, non disponendo di impianti a caldo (e, dunque, producendo con minore impatto ambientale), dipendono direttamente dalla produzione tarantina. Si consideri anche che la riduzione della produzione di acciaio avrebbe rilevanti ricadute, in particolare, sulla produzione di automobili ed elettrodomestici. E’ vero che la produzione dell’ILVA contribuisce per il 75% circa al PIL della provincia di Taranto, ma è anche vero che – come drammaticamente emerso in queste settimane – ciò avviene a un prezzo altissimo e difficilmente quantificabile (i danni all’ambiente e alla salute). Si calcola, a riguardo, che fra le 10.000 industrie più inquinanti d’Europa, l’ENEL “Federico II” di Brindisi e l’ILVA di Taranto sono fra le prime 50. Gli impianti con maggiore impatto ambientale sono, nella gran parte dei casi, collocati nelle periferie d’Europa, a ragione del fatto che, essendo elevato in quelle aree il tasso di disoccupazione, è più credibile il “ricatto occupazionale”, ovvero è più semplice assumere lavoratori disposti a rischiare infortuni o malattie sul lavoro con salari bassi e in riduzione.
Letta in quest’ottica, la vicenda ILVA pare costituire un’ulteriore testimonianza del perverso rapporto di dipendenza che rende funzionale la devastazione ambientale del Mezzogiorno alla crescita dell’industria settentrionale e delle aree centrali dello sviluppo capitalistico.
Filed under: Economia, Lavoro Tagged: Ilva, industria, Taranto